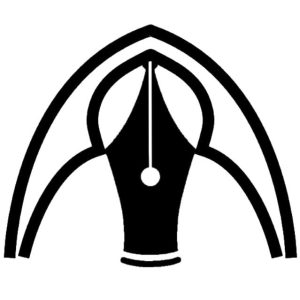Una falange del nostro gruppo ha ideato per il sito Vinonuovo una Via Lucis (che è? Qua), un po’ particolare, perché abbiamo associato, suggestionandoci, a sette stazioni, alcuni brani della letteratura che amiamo: dalla fantascienza di Lem, a J.K. Rowling, ai nostri Tolkien e Lewis, a Dostoevskij, Dickens e Manzoni. Ne abbiamo fatto anche dei brevi video: pubblichiamo oggi che è pure Pentecoste tutto nel nostro canale Youtube!
Una poco di Venerdì Santo, con Miriam Cuatto
Miriam Cuatto, che è cintura nera di Siena e d’intorni, ci invia questo pensiero del Venerdì Santo attorno ad una tavola del Lorenzetti: e ci pare buona cosa renderlo disponibile a tutti.
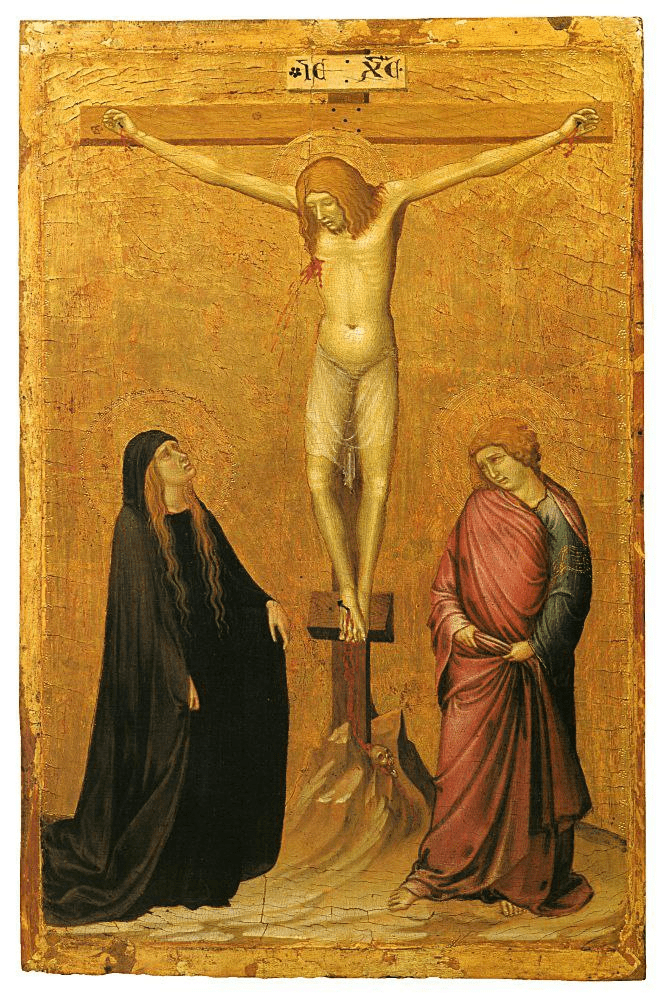
Una piccola tavoletta, forse una valva di dittico che doveva completarsi con una natività, com’è canonico in questi piccoli oggetti di devozione privata. Cosa rende particolare lo stile di Ambrogio in quest’opera, una delle prime a lui attribuite con certezza? Ambrogio è un giovane artista senese, cresciuto nella scuola e all’ombra del fratello Pietro, tra Siena, Assisi e Firenze e risente della verve espressionistica del fratello traslando quelle emozioni esplosive in atteggiamenti tesi, ma pacati. San Giovanni non piange certo, non ha le lacrime agli occhi ma manca poco, con quelle mani stringe la veste con forza, quasi a strapparla, in un anchement gotico che riflette sul corpo il moto dell’anima; pare dire: “lascia ch’io pianga“. Maria, un po’ vergine un po’ Maddalena con quei capelli lunghi sciolti, guarda dal basso suo figlio, in una lievissima smorfia di singhiozzo, reggendo il manto.
Ecco, il manto della vergine, aperto già per accogliere già il corpo del figlio. Pare una composizione canonica, pienamente regolare, quella crocifissione con dolenti vista mille volte ma chi conosce Ambrogio lo sa, per lui le regole esistono per essere infrante e rinnovate. Il manto della Madonna è nero; ma il blu è il colore della Vergine, da secoli, e questo è il primissimo esempio di rottura di questa regola. Ma coma può un pittore tra gli altri fare prevalere la sua visione su una tradizione di secoli?
Nel trecento in tutta Italia ma a Siena soprattutto, la religiosità popolare era in mano non ai chierici, bensì alle confraternite laicali (si stima che 2/3 della popolazione senese fosse considerata “religiosa” in questo senso) e Ambrogio era uno di questi. Era vicino alla confraternita della Vergine sotto il duomo ma non solo, queste compagnie che si occupavano di cura, assistenza, preghiera, mortificazione e seppellimento dei defunti erano il tessuto portante della religiosità cittadina. Ambrogio attinge a questa religiosità che si esprime nel mondo delle laudes, musica religiosa confraternale che umanizza la scena sacra e veste la madonna, più che creatura, delle vesti nere delle donne della città ai funerali.
Dal canone assisiate:
O sorelle della scura
Or me date uno manto nero
A quella che giammai non cura
De bel drappo né buon velo
Puoi ch’io so’ abbandonata
E del mio figlio vedovata.
Il genio creativo di Tolkien, a Torino
Uuuuhhhhh promuoviamo un evento tolkieniano a Torino: se siete in zona, ma anche se non lo siete, non mancate! Di seguito qui il comunicato ufficiale per le stampe.
Da Oxford a Torino. Giuseppe Pezzini racconta il genio creativo di J.R.R. Tolkien
Venerdì 5 aprile appuntamento a Torino con il professor Giuseppe Pezzini, professore Associato al Corpus Christi College presso l’Università di Oxford, che presenterà l’autore e studioso J.R.R. Tolkien.
L’iniziativa, che si terrà alle ore 21:00 nella Chiesa di Santa Teresa (Via Santa Teresa, 5), è promossa dal gruppo letterario Inkiostri in collaborazione con i Carmelitani scalzi di Torino e il nostro giornale.
Spiega il moderatore della serata Daniele Barale:
«si proverà a indagare il “mistero della creazione letteraria”, percorrendo l’itinerario creativo e spirituale dell’autore o, meglio, subcreatore (per usare un concetto a lui caro) de “Il signore degli anelli”. Tolkien ricorda che ciascun uomo è chiamato ad impreziosire, con i propri particolari talenti, un disegno benigno più grande. E la letteratura e l’arte in generale sono tra le vie principali per riuscirvi; oltre che un dono e un compito (divino) per recuperare un atteggiamento di meraviglia di fronte al creato. Quindi, l’autore è un “inventore”, cioè colui che “trova” (stando al suo etimo corretto) il ponte che congiunge il mondo primario (la realtà, frutto della creatività di Dio) al mondo secondario (il frutto dell’immaginazione umana). Allo stesso tempo, ha un legame con la propria opera che è paragonabile alla metafora che Tolkien usò, in due Lettere (263 e 328), per il suo rapporto con “Il Signore degli anelli”: quella della donna partoriente che dà alla luce un figlio che non gli appartiene».
L’ingresso è libero.
Chi è Giuseppe Pezzini?
È professore Associato all’Università di Oxford e Tolkien Editor del Journal of Inklings Studies. Ha studiato alla Scuola Normale di Pisa, all’Università di Oxford e a Princeton. I suoi lavori riguardano principalmente la linguistica e la filologia latina, la commedia romana, la teoria della finzione letteraria, antica e moderna; è collaboratore dell’Institute for Theology, Imagination and the Arts dell’Università di St Andrews; ed è membro del comitato scientifico delle mostre “The Tree of Tales”, curata nel 2021 per il “Meeting di Rimini”, e “Tolkien. Uomo, Professore, Autore”, che dal 16 novembre 2023 all’11 febbraio 2024 è stata allestita presso la GNAM di Roma e, nel novembre prossimo, sarà alla Reggia di Venaria Reale. Tra le sue opere, vi sono la monografia “Tolkien and the Mystery of Literary Creation” (in uscita nel 2024 per Cambridge University Press) e “The Tree of Tales. Tolkien e la polifonia della creazione” (Itaca Edizioni).

Un Tolkien Reading Day, a Pinerolo, anche quest’anno
COMUNICATO STAMPA, un po’ ufficiale oh. Tenetevi liberi! 🙂
Sul binomio “Service and Sacrifice”, tema scelto dalla Tolkien Society per il 2024, si articolerà il Tolkien Reading Day promosso dal gruppo letterario Inkiostri. L’evento si svolgerà nel pomeriggio di domenica 24 marzo a Pinerolo, nel salone della Basilica di San Maurizio.
Si inizia con un intervento a due voci: «Servizio e sacrificio in Dante e Tolkien: l’Autorità e il pericolo del Potere». Spiegano i relatori Chiara Bertoglio (musicista e teologa torinese) e Davide Gorga (scrittore e studioso sanremese): «Tolkien e Dante (il 25 marzo si celebra anche il Dantedì) trasposero i loro ideali anche nella vita politica, per cui presentano un’Autorità dedicata al servizio della collettività, fino al sacrificio personale, se necessario. L’antitesi è la ricerca del Potere personale, tradimento della comunità ma anche tentazione e pericolo mortale che distrugge l’anima di chi vi si abbandona».
“Sam: servizio e fedeltà” è, invece, il tema che verrà proposto dalla germanista e scrittrice torinese Luisa Paglieri. «Sam incarna il tipo del servitore “buono e fedele” – racconta la relatrice –. Non cerca nulla per sé, anzi desidera solo il bene e il successo di “padron Frodo”. E per amor suo desidera anche il successo della missione della Compagnia dell’Anello. Dopo la partenza di Frodo, Bilbo e Gandalf, Sam si dedica alla piccola comunità in cui vive, diventando sindaco. E si occupa della ancor più piccola comunità familiare, essendo un marito e padre di famiglia molto devoto. La sua vita è operoso servizio. È sintomatico che di mestiere sia un giardiniere: ciò che tocca prospera e fiorisce».
A scavare nella mitologia tolkienana ci penserà l’insegnante pinerolese Maria Finello con “Dare la vita per tramandare vita. La morte dell’eroe nel Silmarilion”. «Quest’opera affronta sotto diverse sfumature il topos epico della morte dell’eroe, ma senza mai limitarsi a mero esercizio letterario. Il destino di ogni personaggio si inserisce in maniera unica all’interno di un intreccio più grande che segnerà la sorte del Beleriand e delle Stirpi che lo abitano. La gloria distruttiva di Feänor, il sacrificio di Finrod, la caduta di Echtelion e Glorfindel assieme alle fondamenta della loro città: l’intervento – anticipa Maria Finello – si propone di analizzare questi eventi alla luce di un arco narrativo che capovolge i paradossi e riconosce alla sconfitta un valore in grado di generare vita».

Alle conferenze seguirà l’inedito reading teatrale “Il ritorno di Beorhtnoth figlio di Beorhthelm”, rielaborazione che la scrittrice fantasy Adriana Comaschi ha fatto del poema di Tolkien “The Homecoming of Beorhrtnoth Beorhthelm Son”. I due protagonisti, dopo la battaglia di Maldon, sono andati a recuperare il corpo del loro signore caduto nella battaglia. Questo triste compito fornisce loro l’occasione per scambiarsi alcune considerazioni sulla guerra.
Il pomeriggio pinerolese sarà anche l’occasione per incontrare l’autore del libro “Al Drago verde”, l’insegnante e saggista lumezzanese Mauro Toninelli che così presenta la sua ultima fatica: «Un po’ come al pub o alla locanda. Un po’ come si racconta nella biografia di Tolkien: dove il luogo in cui lui e gli amici si confrontavano sulle storie fossero le riunioni fatte di chiacchiere. Nasce così questo libro. Nasce dalle prime pagine de “Il Signore degli Anelli” dove alcuni avventori discutono dei Baggins e di tutto quello che si sono portati dietro, dalle ricchezze alla pazzia. Nasce nella locanda della Contea più adatta ad essere il luogo delle favole, visto il nome dedicato a un drago. E idealmente, a causa della passione dei miei figli per i draghi e di quella del padre per il mondo di Arda, ci troviamo seduti al tavolo del Drago Verde a chiacchierare, brindando con una pinta di birra del Decumano Est. E la cosa al professore, che amava i draghi, la birra, la buona compagnia e le storie, non sarebbe certo dispiaciuta».
Per restituire l’atmosfera della locanda e dei circoli letterari inglese sarà preparata una merenda “tea and muffins” che sarà possibile consumare anche durante le letture tolkieniane che ciascuno dei presenti potrà liberamente proporre, a seconda dei propri gusti. Non mancheranno, inoltre, alcuni intermezzi musicali ispirati alla tradizione celtica e irlandese.
Una tavola rotonda, moderata dall’insegnante e saggista torinese Chiara Nejrotti, tirerà le fila sul tema e concluderà il TRD pinerolese per il quale è stata stampata, in edizione limitata, anche una speciale card commemorativa.
L’ingresso a tutti gli eventi della manifestazione, con inizio alle ore 14.30, è libero. Per info e per prenotare la card: 348.36.48.699 – info@inkiostri.net
Carteggio d’autore, di Maria Finello
Ed ecco qui un racconto di Maria Finello: che parla di letteratura, della sua influenza sulla realtà, e sull’essere autori (e, tra le righe, suggerisce anche molte cose in più). È un po’ lungo, così si consiglia di scaricarlo comodamente qui, oppure lo trovate anche giù in fondo!
Buona lettura!
Scherzingen, 23 marzo
Alla cortese attenzione del professor Ottinger.
Gentile professore,
mi chiamo Anna Miesch e gestisco un piccolo negozio di fiori nel Canton Turgovia. Chiedo scusa per il disturbo, immagino che le giornate di uno scrittore della sua fama siano terribilmente impegnate, ma mi sono permessa di scriverle perché ultimamente lei ha avuto una grande influenza sulla mia vita.
Qualche mese fa ho trovato tra gli scaffali della mia libreria il suo romanzo d’esordio, La grotta dei narcisi, di cui avevo sentito molto parlare. Il fatto curioso è che non ho idea di come quel libro fosse finito tra le mie cose: non ricordo che mi sia stato prestato da nessuno dei miei amici ed escludo di averlo acquistato di mia iniziativa, perché, avendo una casa poco spaziosa, compro solo titoli che già conosco e che vorrei avere con me. Incuriosita da quel volume misterioso, ne ho iniziato la lettura il pomeriggio stesso e ne sono stata catturata.
Ammetto con una punta di imbarazzo che non sono quella che si definisce una lettrice forte: mi piacciono i libri e spizzico sempre qualche pagina prima di andare a dormire o nei giorni di pioggia, ma di solito mi lascio consigliare dai librai nelle mie scelte e non ritengo di avere un gusto sofisticato: mi limito per lo più ai best-seller. Eppure, leggendo la prima pagina della Grotta dei narcisi, ho avuto l’impressione che fosse scattata una scintilla, che fosse iniziata una storia.
Lei è uno scrittore e potrebbe aiutarmi a esprimermi con parole migliori, ma ho provato la sensazione che quel racconto mi appartenesse profondamente. Non perché si riferisse a dettagli della mia storia personale, ovviamente (l’unica cosa che ho in comune con i protagonisti sono i narcisi del titolo, che vendo a pochi franchi l’uno), ma per qualcosa di indefinito nello stile che ha fatto risuonare in me uno spazio vuoto che non sapevo di avere. Nelle sue parole ho riconosciuto qualcosa di profondamente mio.
Insomma, il fatto è che nelle ultime settimane il mio pensiero torna a lei in continuazione. È per questo che ho deciso di scriverle, pur senza aver niente di reale da dirle. Mi sono fatta molti scrupoli, perché suppongo che riceva innumerevoli lettere come la mia ogni giorno (anche se, probabilmente, meno sconclusionate) e non volevo appesantire la sua giornata, ma infine mi sono decisa a prendere in mano la penna, quanto meno per rendere più concreta questa bizzarra vicenda.
In sostanza concludo esprimendole tutta la mia ammirazione e augurandole buona fortuna per il suo lavoro.
Rispettosi saluti,
Anna
***
Zurich, 29 marzo
Cara Anna,
mi permetto di rivolgermi a te con tono affettuoso perché la freschezza che traspare dalle tue parole, per quanto curate, mi ha rimandato l’immagine di una giovane donna che da poco cammina sul sentiero della vita con le proprie forze. Forse mi sbaglio, ma non credo di molto: ormai ho raggiunto un’età in cui posso definire giovane quasi ogni donna senza temere che le mie intenzioni vengano fraintese.
Sono grato che tu abbia superato le riserve dettate dalla discrezione (come vorrei che più persone si ponessero gli stessi scrupoli), perché la tua lettera mi ha fatto un gran piacere. Innanzitutto per la sua fisicità: per la carta che hai impiegato, appena ingiallita, e che forse hai recuperato da un cassetto dove era stata dimenticata da tempo, regalo femminile dell’adolescenza; per la penna che hai stretto tra le dita, per le righe che hai tracciato sulla carta e che solo alla fine vacillano contro il margine del foglio; per il tempo e la cura che hai dedicato a ogni parola.
È una mia deformazione professionale immaginare, forse impropriamente, frammenti di scene letterarie nella vita quotidiana e tu mi hai regalato un bel paragrafo della tua vita. È stato proprio questo ad attirare la mia attenzione tra i numerosi messaggi con cui lettori e ammiratori mi assediano ogni giorno; questo e un fatto sorprendente: sei stata l’unica a scrivermi del mio libro senza sentire il bisogno di dirmi quanto fosse bello. Forse mi dirai per pudore che era sottinteso, ma io non credo che fosse così: La grotta dei narcisi ti ha chiamata, ma non ti è piaciuto. Non puoi neppure immaginare quanto ciò mi incuriosisca. La mia vanità ne è stuzzicata e la mia creatività non può che ricamare sopra le tue ragioni.
Non temere, non ti infastidirò con le indiscrete supposizioni di un vecchio: sappi solo che darei quaderni colmi di buone idee pur di scoprire cosa delle mie parole è suonato familiare alla tua anima; ma per farlo dovrei avere a disposizione molti più dettagli su di te: con che espressione disponi i fiori nei vasi del tuo negozio quando apri le serrande al mattino e che cosa dicono i tuoi occhi quando la sera conti quelli avanzati e destinati ad appassire? Dove ti siedi la sera, quando chiudi il mondo fuori dalla porta di casa e resti in tua compagnia? Con che cosa leghi i capelli quando ti scivolano sugli occhi, intralciandoti nei movimenti?
Sia ben chiaro, non ti sto chiedendo una risposta reale a queste domande (mi rendo conto di quanto possano apparire inquietanti): si tratta solo di piccoli giochi con cui passo il tempo. Dopotutto, ciò che rende un romanziere tale è proprio il fatto di porsi sciocche domande del genere e di essere sinceramente interessato alla risposta. Solo così possiamo creare vite e mondi interiori.
Credo di essermi dilungato troppo, ma le giornate di uno scrittore famoso sono molto meno frenetiche di quanto immagini, piccola Anna, e tu mi hai aiutato a intrattenere un pomeriggio altrimenti troppo lento. Di solito rispondo a queste lettere in modo che i lettori possano conservare la migliore opinione di me senza sentire l’esigenza di cercarmi di nuovo, ma sappi che per te è diverso. La tua limpidezza potrebbe essermi utile per una questione su cui mi arrovello da tempo e, se i discorsi a scatole cinesi di questo vecchio non ti hanno scoraggiata, sentiti libera di scrivermi ancora.
Nel frattempo auguro ai tuoi fiori di svettare fragranti nei mazzi di belle persone.
Sursum corda! (Ho sempre preferito questa espressione al più castigato “cordiale”.)
Arnold Ottinger
***
Scherzingen, 3 aprile
Gentile professor Ottinger,
sono ancora piena di meraviglia per la precisione con cui ha indovinato così tanti dettagli dalle mie poche pagine.
In effetti ho da poco compiuto ventinove anni, che è quell’età in cui ti rendi conto di non essere più un ragazzo pur senza capire come sia potuto accadere. Quando ho terminato i miei studi sentivo il bisogno di lanciarmi in un futuro sfolgorante, sebbene non avessi le idee chiare su come raggiungerlo, e per un paio di anni ho arrancato in aziende dove tutti erano più bravi e motivati di me. Alla fine mi sono resa conto che l’idea di sfolgorare non mi diceva poi molto e ho cambiato piani: la mia madrina era una fioraia e fin da bambina mi ha trasmesso la sua passione, così quando è andata in pensione mi sono fatta insegnare il mestiere e ho rilevato il suo negozio.
Ma non è questo ciò ha più attirato la mia attenzione. Ad avermi veramente sorpresa è stata la faccenda della carta da lettera, perché mi ha aiutata a ricordare che realmente si tratta di un regalo della mia prima adolescenza: tutte le donne della mia età hanno attraversato un periodo della vita (di solito tra i dodici e i quattordici anni) in cui alle festicciole di compleanno ricevevano immancabilmente set da lettera decorati con fiori, animaletti o personaggi dei cartoni animati. Ho questa carta in casa da anni e non ricordo neppure chi me l’abbia regalata (probabilmente qualche compagna la cui frequentazione si fermava a un passo dall’amicizia), eppure quando ho deciso di scriverle, per qualche strano motivo, me ne sono ricordata e sono andata a prenderla senza quasi rendermene conto. Come se, in un tocco di romanticismo, ritenessi una busta color zucchero filato un dettaglio adatto a presentarmi.
Detto questo, sono sempre più intrigata dall’intuito e dall’attenzione che richiede il mestiere di scrittore: ritengo un onore poter sbirciare un poco nei suoi pensieri ed è per questo che sono più che contenta di poterle prestare il mio aiuto, così come posso.
Rimango a sua curiosa disposizione,
Anna
***
Zurich, 20 aprile
Cara Anna,
attenta a offrire il tuo aiuto prima di sapere come verrà impiegato, perché ci sarà sempre qualcuno come il sottoscritto pronto ad approfittarne.
In questo specifico caso temo che il prezzo da pagare saranno pagine e pagine non richieste di sproloqui letterari. Vorrei infatti chiedere il tuo aiuto per sviluppare una storia.
So che mi hai detto di non essere una lettrice esperta, ma non è di un lettore che ho bisogno. Quella che mi serve è una persona che abbia maggior dimestichezza con la vita che con le parole e in questo ho paura di non poter contare su alcun talento naturale. Il mondo mi è molto più chiaro quando lo ricompongo sulla mia scrivania, attraverso l’odore familiare dei libri, che quando lo devo affrontare di petto; ma la mia capacità di riordinare fatti ed eventi in un intreccio non è sufficiente per il lavoro che ho in mente.
È da un po’ di tempo, infatti, che mi solletica l’idea di un racconto in cui il protagonista faccia la sua comparsa in veste di tela bianca per diventare un essere umano poco a poco.
Mi spiego meglio. Vorrei seguire le vicende di un essere dalle origini misteriose, una creatura indefinibile dall’aspetto umano che tuttavia non ha visto la luce come noialtri. Lo immagino prendere vita dal riflesso di uno specchio o dal riverbero di una pozza d’acqua… Non ho ancora pensato ai dettagli. Quello che mi preme è che venga al mondo come una tabula rasa, senza nulla di più che una vaga coscienza di sé. Credo che sarebbe affascinante seguire il processo di formazione di tutti quegli elementi che rendono una persona tale.
Naturalmente dovrei plasmare pian piano le sue emozioni (e il solo pensare alle dinamiche potenziali insite in una simile premessa mi suscita un brivido d’avventura), ma non solo: qual è la gestualità di un infante in un corpo di adulto, come esplorerà i cinque sensi? Quale suono assumerà la sua voce nel tentativo di articolare i primi suoni e che cosa cercherà di esprimere con essi?
Fremo dalla voglia di scoprirlo, ma è un lavoro che non posso affrontare da solo. Ho bisogno di qualcuno che vigili affinché non si trasformi in un gioco intellettuale e ho scelto te perché, secondo l’idea che mi sono fatto a partire dalle tue parole, sei esattamente il tipo di persona che potrebbe comprendere il mio protagonista e prendersene cura. Lo farai per me? Te ne ringrazio.
Ti manderò ulteriori dettagli al più presto. Nel frattempo, ti prego di aprire gli occhi e il cuore in attesa della mia creatura.
Con riconoscenza,
Arnold Ottinger
P.S. Ho chiesto a te, in maniera piuttosto sfacciata, anche perché ho dato immotivatamente per scontato che il racconto ti piacerà, dato che il nostro stile è molto simile. Lo hai notato? Le nostre lettere, pur lasciando trasparire età e sessi differenti, sembrano scritte dalla stessa mano. Chi di noi due sarà l’impostore?
****
Scherzingen, 29 aprile
Gentile professore,
temo che lei abbia un’opinione decisamente troppo alta di me! È vero, nelle nostre frasi ci sono alcune assonanze, ma di fronte al suo modo di esprimersi io sembro goffa e infantile. In ogni caso sono più che sicura di essere stata io a lasciarmi influenzare dal suo talento, perché non ho mai saputo scrivere così prima d’ora: è oltre le mie reali possibilità e posso solo dedurre che sia stato lei a mettermi le parole in bocca.
In ogni caso non vedo in che modo potrei esserle d’aiuto in un progetto così delicato.
Mentre ero in negozio ho riflettuto molto sulla sua idea: ammetto di non averla capita del tutto, però al tempo stesso è qualcosa di cui vorrei leggere. Credo possa esserci molta tenerezza in una storia del genere.
Anzi, le dirò di più, credo che un pubblico femminile potrebbe adorare il suo racconto: un personaggio dal cuore puro come quello di un bambino, ma al tempo stesso con un fascino incantato? Una sorta di angelo che necessita di essere accompagnato passo dopo passo nel mondo? Lo ammetta, ha inventato un simile scenario solo per far sospirare le donne come me che attraversano le loro banali giornate in compagnia di persone imbolsite.
Naturalmente non sto dicendo che la sua sia un’idea da romanzo rosa: tutti quegli spunti rigorosi di cui parlava nella sua lettera erano molto interessanti, davvero, tuttavia ha ragione quando dice che il tutto potrebbe diventare un po’ troppo complicato. Se io leggessi questo libro non vorrei perdermi in fredde architetture letterarie: vorrei trovarci la vita vera.
Ha presente quel genere di vita che ogni tanto sembra cristallizzare la realtà e sommergerla, come se fosse illuminata da un sole limpido al di là del cielo? È qualcosa che provo spesso e quando accade ho l’impressione che le giornate siano più lunghe, quasi più “abitate”.
Quando posso vado a passeggiare sulle colline dietro casa durante la pausa pranzo (che è piuttosto lunga, lo ammetto, dal momento che nessuno compra fiori quando è ancora appesantito dalla digestione): nelle mie intenzioni dovrebbe trattarsi di camminate agili per portare benefici alla schiena, ma per quante promesse abbia fatto a medici e fisioterapisti finisco sempre per rallentare lungo il percorso e rimirare il paesaggio che mi circonda. La verità è che ci sono troppe cose belle attorno a me per non esserne avvolta: ci sono i fiori della villa patronale, che variano di settimana in settimana in un incantesimo di petali (prima le regali peonie, poi, nascosto dietro ai padiglioni di ferro battuto, il sognante lillà e infine la multicolore esplosione delle ortensie); c’è il rumore dell’acqua che scorre nel canale lungo la pista ciclabile, che ha il suono fresco delle fonti incantate di Shehrazade e fa danzare l’erba filiforme cresciuta lungo i bordi; ci sono le mucche che allattano i vitellini oltre il crinale della collina, nel grande prato dove il sole supera appena la linea montuosa dell’orizzonte sfiorando le loro schiene bionde.
E non solo la natura: il balcone del vicino a cui è appesa una bandiera così scolorita da non essere ancora riuscita a identificarla in tutti questi anni, l’imponente casa di inizio secolo con i segnavento a forma di draghi e che secondo alcuni è abitata dai fantasmi (attenzione, questa è materia da scrittori!), la coppia di anziani che trascorre il suo tempo allevando con amore un pony il cui unico scopo è giocare con i nipotini quando vengono in visita… Quando osservo questi e altri innumerevoli dettagli, amici vecchi e nuovi, mi sento riempire di vita. È una sensazione fisica, simile a un bagno frizzante.
In quei momenti mi sento colma di gioia: non di allegria, attenzione, perché le fatiche e le preoccupazioni restano là (le ombre sono sempre in agguato, non ci lasciano mai completamente), ma è come se si disperdessero in un mare vasto, sereno e grato.
Chiedo perdono per la mia digressione, in realtà i miei esempi divaganti servivano solo per dire questo: io sono una persona comune e riesco a percepire solo piccoli scorci di questa gioia presente nelle cose, ma credo che un personaggio venuto al mondo all’improvviso dovrebbe vivere così ogni singolo istante. Di sicuro sarebbe turbato da alcune cose, spaventato da altre, ma sono certa che resterebbe immerso in quel “bagno di realtà” che ho cercato di descriverle con parole confuse.
Acciderboli, mi sono resa conto di aver scritto tantissimo e non voglio portarle via tempo che potrebbe usare per scrivere. Mi permetto soltanto di farle un’ultima domanda: quale aspetto avrà il suo protagonista? Vorrei riuscire a visualizzarlo meglio.
Grazie per avermi permesso di volare con la fantasia, è un piacere che mi mancava.
Le auguro un buon lavoro,
Anna
P.S. Più ci ripenso più mi sento di dover intervenire: fra le due idee che ha proposto per la nascita del nostro eroe, preferisco quella della pozza d’acqua. L’immagine di uno specchio è troppo appesantita dalla personalità di chi vi si affaccia, mentre il riflesso di un ruscello è accidentale, fluttuante e mitigato dal mistero impersonale della natura.
***
Zurich, 7 maggio
Carissima Anna,
credo che tu possegga un dono grande senza saperlo. Quella che descrivi è una sovrabbondanza di ciò che io chiamo “momenti assoluti”, brevi istanti in cui l’uomo è in grado di trascendere lo spaziotempo.
Si tratta di una sorta di “istantanea” in cui l’anima viene impressionata come una pellicola fotografica, ricevendo in eredità il mondo interiore insito in ciò che la circonda. E come ben sai, i mondi interiori si estendono solo esplorando e inglobando altre collisioni.
Ti rivelerò un segreto: gli scrittori sono continuamente a caccia di momenti assoluti, perché senza di essi sanno di non essere altro che nullità con una penna in mano. Macchine che sfornano sbiaditi stereotipi della realtà, simili alla letteratura così come il motivetto di una sala d’attesa lo è a un preludio di Debussy.
E adesso ti consegnerò un segreto ancora più grande, impronunciabile: nel corso della mia ormai lunga vita io ho vissuto pochissimi istanti simili, forse una manciata in tutto, e quasi esclusivamente durante l’infanzia.
Ecco, ho confessato l’inconfessabile e nominato l’innominabile: sono uno scrittore da sala d’attesa.
Posseggo uno studio con una bella scrivania di mogano scanalato, una lampada d’ottone e pareti tappezzate di prime edizioni, uno scenario che fa notevolissima impressione nella foto sulle quarte di copertina ma che mi marchia come scrittore mediocre. Il genio non ha bisogno di costruirsi un laboratorio. Maupassant non aveva bisogno di scanalature di mogano.
Ecco spiegato il perché di questa caccia grossa, di questo safari del significato e della permanenza. La verità è che, così come il nostro personaggio rappresenta per te il principe azzurro dal cuore puro, per me è una pallida occasione di vedere il mondo con gli occhi che ho sempre desiderato, per la durata di qualche pagina. Un mondo che tu mi mostri.
La verità è che sono così assetato di momenti assoluti da spingermi a ricrearne di fittizi negli occhi di un personaggio immaginario, nella speranza di potermi almeno abbeverare a questi riflessi. Ed è per questo che, ora che ho trovato in te un simile serbatoio, non ti lascerò più andare. Perdonami.
Ma non credere che nella nostra amicizia vi sia solo bieco opportunismo: la nostra corrispondenza è un vero piacere e gli anziani come me hanno la tendenza ad affezionarsi ai giovani come te con la tenerezza di potenziali nonni.
Dopo averti investita di una simile autorità, eccomi pronto ad ascoltare i tuoi consigli: nuntio vobis… e fonte sia!
In realtà non sono del tutto persuaso che le tue ragioni siano imparziali: posso immaginare che per una giovane donna come te, che si emoziona di fronte a un bocciolo di peonia (o meglio, “di regale peonia”), uno scenario naturale eserciti molte più attrattive di un oggetto d’arredamento.
Eppure continuo a pensare che anche l’idea dello specchio avesse il suo fascino. Certo, il problema di un “originale” di cui tener conto non è da nulla perché, in un modo o nell’altro, pretenderà sempre di rubare la scena, ma non è certo con uno scenario bucolico che scongiureremo il rischio. Dopotutto Narciso si è specchiato in una pozza d’acqua e, come tutti sappiamo, aveva una personalità piuttosto ingombrante.
Ciò che mi ha convinto delle tue ragioni, alla fine, è il “mistero impersonale della natura” che hai saggiamente evocato. Mi piace l’idea di una forza insondabile che scompiglia le azioni umane facendone emergere dimensioni inattese (e non solo perché il caso mi evita molti fastidi narrativi). Per questo motivo, credo, riporrò specchi e specchietti nei ripostigli della mia mente e seguirò il tuo consiglio. Come vedi sono molto determinato, quindi risparmiati la fatica di giustificarti nella prossima lettera. You won.
Talvolta gli scrittori hanno bisogno di staccarsi dalle loro creature e di lasciare che siano altri a prendere le decisioni. Il nostro sogno più grande sarebbe quello di poter ascoltare l’opinione di un personaggio, in modo da osservare le vicende dal lato giusto della storia.
Se non ricordo male, nella prefazione di un vecchio libro ho scritto che “la persona migliore a cui chiedere consiglio è il proprio protagonista”. Al momento il nostro protagonista non è ancora nato e per qualche capitolo ancora non sarà in grado di parlare, per cui chiedo a te. Sei tu, bambina mia, che stai dando forma a questo racconto modellandolo su di te.
Tuttavia ci sono ambiti in cui è bene che anche lo scribacchino dica la sua, perché conosce qualche espediente e mezzuccio tecnico che permette all’opera di funzionare. Perciò, come da richiesta, ti descriverò il nostro eroe nel modo in cui, a mio parere, potrebbe rendere meglio.
La parola d’ordine è neutralità. Un personaggio che non è nulla e che al tempo stesso è tutto deve avere un aspetto il più possibile neutro, in modo che scivoli nell’immaginazione del lettore il più silenziosamente possibile. Banditi i nasi importanti, i nei d’amore e i menti volitivi. Al tempo stesso, però, il nostro protagonista non può lasciare indifferenti: deve far voltare le teste al suo passaggio, altrimenti, privo di personalità com’è, per lui diventerebbe troppo arduo reggere il peso di una storia. E qual è l’espediente, vecchio come il mondo, per rendere qualcuno anonimo e al tempo stesso indimenticabile? La bellezza, ovviamente. Gli antichi hanno scoperto per primi questa gradevole forma di impersonalità e i pubblicitari l’hanno portata alla perfezione. Per cui sì, mia cara Anna, il nostro eroe (lancio un ahimé a nome di tutte le persone che, come me, non sono nate con i favori di Venere e Apollo) è costretto a essere bello. Bello come un’idea che, pur non avendo tratti propri, incarna l’aspirazione dell’umanità intera.
Immagino che non ti strapperai i capelli di fronte a questo annuncio. E, in effetti, per quanto possa storcere il naso di fronte a questa emergenza, in quanto imprenditore di me stesso non posso che approvarla perché attirerà un maggior numero di lettori (e di lettrici).
Io mi limiterò a fornire un contenitore ben sagomato, ma sarà il mio pubblico a renderlo man mano più reale, aggiungendo pagina dopo pagina quei dettagli che lo renderanno più vicino alla loro esperienza: per alcuni la bellezza sono labbra carnose, per altri lineamenti aguzzi o clavicole ben definite… ed ecco che i lettori si assumeranno inconsapevolmente parte del mio compito di renderlo umano, dando vita a infinite declinazioni di un’unica perfezione.
Sempre in nome della neutralità, il ragazzo dovrà avere un’età compresa tra i venticinque e i trent’anni (l’età che, secondo alcuni teologi medievali, avranno i corpi dopo la resurrezione finale). Più giovane e renderebbe impossibile immedesimarsi con lui a una larga parte di pubblico, soprattutto del mio, più vecchio e l’assenza di un passato inizierebbe a intaccare la possibilità stessa di essere un uomo (perché, mia cara, crescere è essenzialmente una questione di stratificazioni).
Dal momento che il racconto sarà ambientato nelle nostre terre, per lo più in una cittadina di provincia come la tua, il ragazzo dovrà essere caucasico perché (e mi sento di aggiungere purtroppo) un qualsiasi confronto tra culture comporterebbe un bagaglio storico difficile da gestire nella narrazione. Ovviamente spostando lo scenario le cose cambierebbero, facendosi particolarmente complesse in una grande metropoli, ma come avrai iniziato a capire sono uno scrittore pigro, per cui la mia storia non vedrà grandi città se non sui tabelloni dei treni di piccole stazioni rurali.
Dunque carnagione chiara, ma non come quella di tutti gli altri: il suo aspetto deve mantenere qualche dettaglio che ricordi le sue origini incantate e un pallore lunare sarà perfetto allo scopo. Gli occhi possono permettersi un po’ più di personalità, perché devono mostrare in anticipo ciò che il personaggio saprà diventare (e quindi devono promettere meraviglie): sebbene non sia sempre stato così (nell’Ottocento l’unico colore d’iride degno di nota era il nero), ai nostri giorni sono gli occhi chiari a catturare l’attenzione. Tra le varie sfumature possibili credo che sceglierò il grigio, il più raro.
A questo punto non ci rimane che acconciarlo. Ormai avrai capito il meccanismo: abbiamo bisogno di estremi, un biondo argenteo o un nero lucente, senza vie di mezzo. Entrambe le opzioni comportano piccole sfumature di impressioni, ma, per una pura questione di gusto personale, mi permetto di scegliere il nero. Petrolio e carbone.
Et voila! Pezzo dopo pezzo abbiamo assemblato il nostro protagonista ideale. Forse non particolarmente originale, ma di sicuro effetto.
Scusa, concedimi di giocare un po’. In realtà spero con timore e tremore di non aver ucciso il tuo interesse con questa prolissa descrizione in perfetto stile Frankestein. Ti confesso che tengo immensamente al fatto che il nostro eroe possa piacerti.
Per ripagarti della pazienza mi riprometto di mandarti già con questa lettera alcune scene abbozzate per farti un’idea più organica (motivo per cui queste pagine potrebbero raggiungerti in ritardo rispetto alla data che portano).
Nel frattempo resto il tuo ammirato
Arnold Ottinger
***
Scherzingen, 24 maggio
Gentile professore,
chiedo scusa per il ritardo nel rispondere, ma negli scorsi giorni ho avuto un brutto raffreddore primaverile. Nulla di così grave da costringermi a chiudere il negozio, ma abbastanza da costiparmi il cervello impedendomi di sedermi a un tavolo con carta e penna.
Tuttavia volevo ringraziarla, perché nelle lunghe serate che ho passato chiusa in casa (particolarmente opprimenti in un periodo della mia vita già piuttosto incerto) le pagine che mi ha inviato mi hanno tirata più su dell’aspirina. Sto leggendo altri libri nel frattempo, tra cui, senza offesa, alcuni di autori più accreditati di lei (dopo che ha citato Maupassant sono andata in biblioteca a prendere Une vie: ah, quanta solidarietà nei confronti di un cuore così intimamente sofferente!), eppure non riescono a darmi lo so stesso gusto di quella che ormai considero, mi perdoni, la mia storia.
Conoscere ciò che avviene dietro le quinte di un libro gli dà un peso diverso e permette di affezionarsi maggiormente ai dettagli. Tanto più che ho trovato le sue bozze realmente convincenti: la scena in cui il protagonista inizia a camminare incespicando nel bosco, mettendo in bocca ciò che capita come un bimbo appena svezzato, è molto suggestiva e anche l’incontro con il pensionato che gli offre i suoi vestiti da festa è carica di tenerezza. Sebbene si tratti di un personaggio secondario, l’anziano è tratteggiato con molta umanità; anzi, la cosa curiosa è che la sua descrizione calza a pennello con quella di un signore che vive in una casetta nelle colline dietro al mio paese. Ho trovato questa coincidenza sorprendente e sono sempre più convinta che lei sia già stato nelle mie terre, perché più il protagonista avanza nel suo viaggio, più le descrizioni dei luoghi divengono familiari. Il fiume dell’ultimo paragrafo sembra seguire lo stesso corso di quello che attraversa la mia frazione e ho l’impressione di conoscere da sempre l’ansa in cui il ragazzo si lava per la prima volta: è vero che tutte le pozze d’acqua si assomigliano su carta, ma il paesaggio coincide in maniera impressionante con il posto dove mia zia portava me e i miei cuginetti a fare il bagno da bambini. Sembra quasi che il nostro eroe si stia avvicinando.
Non so se è grazie ai suoi “espedienti e mezzucci” da scrittore, ma sono bastati pochi paragrafi per rendere il nostro giovane amico, così puro e al tempo stesso così forte, il mio nuovo e personale mr. Darcy (sono dell’idea che, approssimando un po’, ogni donna sia attratta o da Darcy o da Heathcliff e, anche se io protendo nettamente per il primo, da qualche anno sto assieme a un turbolento emulatore del secondo: si può essere più stupidi?). Insomma, mi sono innamorata! Sono caduta vittima di quel sentimento vibrante, vivificante, totalizzante e al tempo stesso sereno che è possibile provare soltanto per una creazione letteraria.
Quanto è bello sentirsi parte di una storia! La ringrazio per avermi permesso di entrare nella sua mente, di seguirne i meccanismi creativi, perché è una delle cose più elettrizzanti che mi sia mai capitata. Eppure, sotto all’ironia, nelle sue parole mi è sembrato di leggere anche un’eccessiva severità. Lei è molto meno mediocre di quanto crede, per il semplice fatto che nessuno può essere all’altezza delle sue aspettative.
Non vorrei averle dato l’impressione di saper cogliere “momenti assoluti” ogni istante della mia vita: le assicuro che non sono tutte rose e fiori. Ci sono giorni in cui, anche nelle difficoltà, mi sento immersa in qualcosa di più grande che mi dà pace e giorni in cui non riesco a vedere al di là del mio naso perché ho la testa immersa in una bufera di preoccupazioni.
Questo, per esempio, è uno di quei periodi in cui la mia attitudine contemplativa è scoraggiata dalle contrarietà: un fidanzato stupido a cui voglio ancora troppo bene (ma che se non si dà una svegliata rischia di diventare uno stupido ex), certezze che si incrinano e che non voglio veder crollare, troppe domande su di me. Inoltre è da settimane che nella mia zona non cade una goccia d’acqua e questo caldo fuori stagione non fa bene al negozio: i fiori arrivano da me già affaticati e appassiscono prima ancora che arrivino i clienti, i quali non hanno voglia di comprare mazzi sgualciti. È una tristezza passare le giornate accanto a quelle creaturine che si ripiegano su se stesse minuto dopo minuto… mi sento appassire anch’io.
Ma basta annoiarla con le piccolezze di una vita qualsiasi: mi viene istintivo confidarmi con lei perché le sue lettere hanno il potere d farmi sentire meno male, di dare un ordine alla mia vita, ma dopotutto lei mi sta scrivendo per ricevere un parere letterario, non per curare la posta del cuore di un giornaletto. Per cui ora la lascio in pace, lo prometto, e torno a immergermi nel regno sorprendente e al tempo stesso familiare della sua immaginazione.
La sua sgualcita ammiratrice,
Anna
P.S. A proposito, il nostro eroe ha un nome? Mi piacerebbe pensare a lui in modo più personale.
***
Zurich, 30 maggio
Mia piccola Anna,
questo nostro legame d’inchiostro si è stretto al punto che l’idea che tu sia infelice mi toglie l’appetito. Ho iniziato a pensare a te come a un piccolo dono scovato tra le pieghe di una storia e una parte di me desidera proteggerti così come uno scrittore custodisce il proprio personaggio preferito.
Non posso fare molto per te dal mio studio polveroso, ma ho scritto qualche pagina nella speranza di rallegrarti un poco nel tuo isolamento. A volte le parole sanno consolare. È una storia che racconta della casa con i segnavento a forma di drago e dei suoi fantasmi (ho raccolto la tua sfida) ed è piena di pioggia, per attirarla fino a te.
Per quanto riguarda il nostro protagonista, temo che un nome sia fuori discussione: qualunque insieme di lettere, reale o immaginario, sarebbe troppo connotato. Dovrà conquistarselo passo dopo passo e con fatica, come un tesoro. Forse al termine della sua avventura incontrerà una persona che riconoscerà in lui ciò che ancora non esiste e che lo chiamerà per nome. Non riesco a immaginare conclusione più lieta.
Non ti appesantisco con ulteriori pensieri, avrai bisogno di riposo e distrazione, ma ti mando altro materiale da giudicare.
Sursum corde (ancora una volta e con ancora più affetto),
Arnold Ottinger
***
Scherzingen, 22 giugno
Cortese professor Ottinger,
la sua lettera mi ha stupita, non tanto per il suo interessamento ma perché a prima vista è sproporzionata. Io le ho scritto soltanto di un raffreddore, un fidanzato inadeguato e qualche petalo appassito (piccole seccature, certo, ma nulla che lasciasse intendere che io fossi infelice), eppure lei ha saputo cogliere tra le mie parole qualcosa di più, una solitudine profonda a cui neppure io ho dato nome e che sembra isolarmi dal resto del mondo. Non ne ho mai parlato con nessuno, ma a quanto pare non sono riuscita a tenergliela nascosto.
Ormai ho l’impressione che lei mi conosca più di me stessa e, se devo essere sincera con lei, la cosa inizia a spaventarmi. So che leggere tra le righe è il mestiere degli scrittori e che non c’è nulla di male, ma lei mi conosce più di me stessa, per davvero, e io inizio a chiedermi se non sia stato così fin dall’inizio.
Tempo fa mi ha domandato scherzosamente chi fra noi due fosse l’impostore e ora la sua provocazione torna a risuonare in me come un’eco inquietante. Torna nelle mie parole che, contro la mia volontà, sono sempre più simili alle sue. Torna nelle inverosimili corrispondenze che, ora me ne rendo conto, mi circondano come ombre dissimulate dalla notte.
Stanno succedendo cose strane, cose di cui forse mi sarei dovuta accorgere prima.
Stavo leggendo il racconto che mi ha inviato e nel momento stesso in cui è caduta la prima goccia nel suo mondo di carta, anche qui è arrivata la pioggia. Lei dirà che si è trattata di una semplice coincidenza, e forse ha ragione, ma converrà che si è trattata di una coincidenza tale da risvegliare la mia attenzione ed è così che ho cominciato ad accorgermi del resto.
Pochi giorni dopo stavo passeggiando accanto alla villa dei segnavento e ho sentito le note ovattate di un pianoforte privo di suonatore; per un attimo ho trattenuto il fiato, emozionata all’idea che per la prima volta anch’io potevo sentire quella musica fantasma di cui tanto avevo sentito parlare, poi però mi sono ricordata che nessuno aveva mai accennato a un pianoforte. Nessuno al di fuori di lei e del suo racconto. Eppure nella mia memoria quello strumento esisteva ormai da sempre, si era conquistato un posto scavandosi la strada fin nel principio della mia coscienza. Ho cercato di risalire a chi per la prima volta mi avesse raccontato la leggenda della casa fantasma e tra i miei ricordi non ho trovato altro che una nebbia informe e impersonale. Questa storia l’ho sempre saputa senza che nessuno me l’abbia consegnata.
Perché per me sta diventando sempre più difficile distinguere quanto leggo dalla realtà?
Turbata da questa scoperta, ho iniziato a prestare più attenzione alla mia vita quotidiana ed è stato allora che le cose hanno iniziato a sfuggirmi di mano. Più prendo lucidità, più tutto attorno a me diventa confuso. Più permetto al velo che avevo posto davanti ai miei occhi di cadere, più la mia esistenza perde senso.
Da quando ho iniziato a collegare tra loro gli indizi, non posso fare a meno di vedere le incongruenze di cui sono fatta. Sono continuamente avvolta da una leggera sensazione di irrealtà che mi separa dal mondo, come se mi trovassi sotto a un sottile strato di cera. Ed è proprio di cera che mi sento fatta: fragile, vuota. Una bambola.
Chi sono io? Quando ho iniziato a naufragare in questa illusione come in una pozza d’acqua gelida, come Eco che si disperde inseguendo la caduta di Narciso?
No. Queste non possono essere le mie parole, io non sarei in grado di cercare nel mito le mie metafore… Lo sto facendo di nuovo. Perché non riconosco più la mia voce?
No, peggio, ormai non sono neanche sicura di aver mai parlato per davvero. Perlomeno non da quando, spinta da qualcosa che non era la mia volontà, le ho scritto per la prima volta.
È stato lei. La nostra corrispondenza è diventata un punto di luce, la finestra attraverso cui mi affaccio sul tempo, e il resto ha cominciato a evaporare. Come se non fosse mai esistito. Come se ogni volta, nello spazio amorfo tra le nostre lettere, io smettessi di esistere.
Io sono venuta alla luce il giorno in cui l’incipit della Grotta dei narcisi ha iniziato a riverberare in me e a modellarmi. Non è forse così?
Faccio fatica a esprimermi, a trovare parole che oltrepassino queste righe a me sempre più estranee. Ho vuoti di memoria sempre più frequenti. La mia mente segue lo stesso meccanismo dei sogni: mi ritrovo immersa in una situazione, mi muovo al suo interno con fin troppa libertà, ma non sono in grado di distinguere il momento in cui tutto è iniziato.
Mi aggiro in un labirinto di specchi, entrando e uscendo da immagini replicate all’infinito come una moderna Alice. Una tazza di tè accanto alla finestra della cucina, l’ultimo tocco a un bouqet da sposa… Frammenti di vetro che si riflettono a vicenda, camei senza trame perfetti per essere raccontati in queste lettere.
Non ricordo i nomi dei miei amici, anche se ho detto di averne; non distinguo il volto del fidanzato che tanto mi sta facendo soffrire. Narrazioni discontinue, senza radici, coriandoli di coscienza in pasto alla carta. Gli unici istanti in cui sento realmente di esistere sono i momenti assoluti delle mie passeggiate e le ho consegnato anche quelli.
E poi c’è lui. Ho cercato tregua nel nostro romanzo, nella quiete familiare del nostro esperimento letterario, ma ormai sono consapevole di esserne io stessa la cavia. Ogni frase e ogni descrizione me lo dicono.
Il nostro protagonista sta percorrendo le strade delle mie colline, sta incontrando le comparse della mia quotidianità frammentata. Lui sta venendo da me, lo so. Che cosa dovrei fare? Una parte di me, quella che ha paura, quella che vuole essere consolata, attende con ansia questo incontro: in questo momento la sua esistenza è la cosa più reale che ho e forse il suo arrivo mi darà pace. Eppure c’è una parte che continua a ribellarsi a questo destino.
Voglio autonomia, la pretendo.
Perché mi sta accadendo tutto questo?
Forse sono solo pazza, forse la novità che lei ha portato nella mia vita mi ha suggestionata a tal punto da farmi perdere il contatto con la realtà.
Se è così la prego di aver compassione di una povera folle che spera di esserlo, che prega di poter essere curata dalla sua inquietudine.
Dopotutto ciò che temo non può essere reale, non è così?
Mi risponda, la scongiuro, mi parli. Non mi lasci sola. Non voglio impazzire, non voglio scomparire.
Sono nelle sue mani,
Anna
***
Scherzingen, 24 giugno
Lui è arrivato da me.
Questa mattina sono uscita di casa per andare in negozio e lui era lì, seduto sul bordo di una fontana. Un ragazzo con i capelli neri e il volto perfetto con cui ci si immagina un personaggio prima che venga descritto.
Non mi ha vista. Guardava il cielo e chiamava gli uccelli con la sua voce che ancora fatica ad articolare. Aveva il sorriso di un bambino e lo sguardo immerso nell’eternità.
Era così bello. Così terribilmente reale.
Sono scappata via terrorizzata e mi sono rinchiusa nel negozio. Una parte di me avrebbe voluto correre tra le sue braccia e abbeverarsi a quella serenità, ma non potevo fare a meno di chiedermi se quei sentimenti mi appartenessero davvero.
Sono caduta in ginocchio e tutte le emozioni che tenevo rinchiuse nel petto si sono sciolte in lacrime. Ho pianto senza controllo, le braccia strette al petto.
Era la scena perfetta per un libro. Bel lavoro.
Non voglio spiegazioni, non vedo a che cosa potrebbero servirmi, ma le scrivo questa lettera, l’ultima, per chiederle un favore.
So che non c’è bisogno di imbustare queste pagine, perché lei le riceverà comunque. So che verrà a conoscenza delle mie parole nel momento stesso in cui apporrò l’ultimo punto, per cui non perdiamo tempo. Appena avrò terminato di scrivere uscirò dal negozio e andrò da lui.
Lei mi deve la mia libertà. Non chiuda gli occhi di fronte alla mia richiesta.
La prego, la imploro, posi la penna affinché io possa parlargli con la mia voce.
Sua, e mai parola fu più bruciante,
Anna
***
Zurich, 24 giugno
Mia piccola Anna, bambina mia,
temo di doverti delle scuse.
Sarebbe dovuto essere solo un gioco, non ti saresti accorta di nulla: una sagoma di carta che scrive su carta. Eppure questo gioco ha iniziato a sovrapporre strati inaspettati e, inavvertitamente, ha fatto di te qualcosa che non dovevi essere.
Non avrei mai voluto che tu soffrissi, credimi. Tu sei il personaggio migliore della mia storia migliore.
Inizialmente volevo solo interrogarti attraverso l’inchiostro, perché, come ti ho confessato una volta, il mio sogno più grande era quello di ascoltare l’opinione di un mio personaggio, in modo da osservare le vicende dal lato giusto della storia. Ma mentre parlavo con te, per mezzo di te, ho iniziato a inseguire il mia chimera.
Te l’ho detto, uno scrittore rincorre il momento assoluto per tutta la vita e per ottenerlo è disposto a sovvertire l’ordine del mondo.
Quando in te ho intravisto questo dono, riflesso del mio desiderio più profondo, l’ho incoraggiato e ho lasciato emergere una sorgente di vita fuori luogo, che si è infiltrata tra noi al di là di ogni nostro potere.
Perdonami, non doveva andare così, ma da tempo non ho più controllo su questo mistero: non ho potuto fare altro che assecondare la piega presa dalla storia per non abbandonarti. E non lo farò, a ogni costo.
Anna, io mi prenderò sempre cura di te. Adesso fa paura, ma ti assicuro che non farà male. Non aver timore.
Per ripagare il mio debito non avevo altro tra le mani che un personaggio abbozzato, ma l’ho plasmato perché prendesse la forma giusta per te. Ho iniziato a scrivere un racconto in cui poteste rifugiarvi uno accanto all’altra ed essere felici.
È vero, ho commesso qualche errore: sono entrato con troppa prepotenza nelle tue parole, scegliendo un lessico spesso inadatto, e sono arrivato al colpo di scena in maniera precipitosa, turbandoti. Ma cerca di capire… Prima o poi avrei dovuto dirti la verità, ma avevo talmente paura di affrontarti che, nonostante tutti gli anni di esperienza, l’ho fatto in modo goffo.
Ti prometto che non succederà più, fidati di me. Fidati dell’uomo a cui abbiamo dato un volto assieme: quel ragazzo è stato creato per essere puro, tu per essere viva. Non credi che insieme possiate dare vita a qualcosa di meraviglioso?
Io sono convinto di sì e vi presterò la mia mano, perché non vedo l’ora di scoprire che cosa sceglierete di fare. Ti giuro che mi farò da parte: sarò un narratore silenzioso, in ascolto dei suoi eroi.
Anna, lui ti sta aspettando. Il mio dono, il mio risarcimento, è là fuori seduto sul bordo di una fonte d’acqua limpida come quella da cui è nato, con i suoi occhi privi di ombre, e aspetta che tu ti prenda cura di lui. Perché tu sei l’unica che puoi dargli un nome. È tuo diritto.
Vai, prendi la sua mano senza colpe e accompagnalo dentro alla vita.
Andate, tenetevi stretti e scrivete la vostra storia.
Ti prometto che sarà gentile.
Arnold Ottinger
La via della Luce
Una parziale falange di noi Inkiostri, in passato, si è cimentata con un gradevole impegno di natura pasquale: che ha portato quest’anno ad una nostro scritto non meno pasquale, di cui pubblichiamo, qui di seguito, l’introduzione. Ok che siamo ancora a Carnevale ma poi è un attimo eh! Il libro è disponibile presso la redazione di Vita Diocesana Pinerolese (via vescovado, 1 – Pinerolo). Per info e prenotazioni: tel 0121.373335 – vitaeditrice@gmail.com
Raccontare la Pasqua. Per degli scrittori, un’avventura esaltante: il dramma della Pasqua è così vivido nei suoi personaggi, situazioni, avvenimenti, dinamiche, da aver ispirato innumerevoli creazioni e reinterpretazioni artistiche nella Storia, da parte sia di credenti sia di non credenti. Tale è il potenziale narrativo degli avvenimenti degli ultimi giorni della vita terrena di Cristo che anche la lettura del Vangelo della Passione avviene in forma drammatica, e questa “teatralità” (nel miglior senso del termine) ha ispirato anche alcune versioni musicali di assoluta bellezza, come le Passioni di Johann Sebastian Bach.
Per degli scrittori credenti, si tratta di confrontarsi con il cuore stesso della propria fede, e cioè con gli avvenimenti fondanti su cui l’intera costruzione della propria esistenza e del proprio sistema di valori si basano.
Inevitabile, perciò, che prima o poi anche gli Inkiostri si lasciassero sedurre dal fascino degli avvenimenti del Triduo Pasquale. In realtà già nel 2022 il nostro gruppo di amici appassionati di letteratura, di relazioni profonde e di fede aveva affrontato la Pasqua. L’avevamo fatto con una delle nostre sfide, i “concorsi interni” con cui ci stimoliamo reciprocamente a scrivere, dedicata a dei “DabbleDrabble” (mini racconti di 200 parole) sul Sabato Santo[1], e anche con una “Via Lucis” pubblicata su VinoNuovo[2], e in cui avevamo immaginato che i Discepoli di Emmaus fossero una coppia di sposi, Maria e Cleopa, intenti a scoprire le tracce del Risorto nel loro quotidiano di amore familiare e coniugale.
Successivamente, VinoNuovo ci ha invitati a replicare l’avventura, e abbiamo pensato di ambientare la Via Lucis in questo presente che sembra tanto difficile per tante persone e situazioni. Abbiamo immaginato piccole storie, che, narrando il vissuto di una persona, potessero risultare emblematiche rispetto a situazioni più grandi che caratterizzano le cronache e le fatiche dei primi mesi di quest’anno.
Accanto a questo cammino di speranza, in cui la luce del Risorto viene a illuminare tutti i “cuori di tenebra” del nostro quotidiano, siamo stati invitati anche a creare e vivere un altro cammino, legato invece alla Passione. Si è trattato di un ciclo di quattro incontri (più uno, una meditazione in musica) proposti come itinerario quaresimale nella parrocchia di San Bernardino a Torino, dei Frati Minori francescani.

Nelle quattro serate, delle “squadre” di Inkiostri sono partite da un oggetto protagonista della Pasqua per intessere delle narrazioni contemplative e meditative sul mistero pasquale. Gli oggetti che avevamo inizialmente pensato, con una “coincidenza” che sicuramente non è casuale, si sono ritrovati anche sull’immagine simbolo del francescanesimo, il meraviglioso Crocifisso di San Damiano che parlò a San Francesco e davanti al quale Santa Chiara e le Clarisse pregarono per secoli. Dai piccoli dettagli del Crocifisso, sui quali i nostri amici frati ci hanno invitati a posare l’attenzione, ci siamo quindi spostati su oggetti che ci permettessero di entrare nel mistero della Pasqua come da una porta di servizio: umilmente, concretamente, ma anche con l’infinito stupore di chi vede dispiegarsi la bellezza dell’amore di Dio che cura anche i più piccoli dettagli nel disegnare l’immenso affresco della Passione. Nella serata conclusiva, l’intreccio di parole, silenzio, immagini e musica (cantata dall’ensemble vocale e strumentale dei giovanissimi “Creativi”) ha permesso di ri-comporre l’immagine complessiva, nella contemplazione di un Crocifisso che parla a tutti.
Abbiamo perciò pensato di offrire ai nostri amici lettori il “diario di viaggio” di questo cammino, sperando che possa essere utile anche a loro come lo è stato – in primis – per noi stessi, stimolati così a una contemplazione più profonda e vivida di ciò che dà senso alla nostra intera esistenza. Le serate di San Bernardino sono state anche riprese in forma di video, disponibili sul canale della Parrocchia San Bernardino[3] e di Vita Diocesana Pinerolese[4], nel caso in cui potesse far piacere sentire le narrazioni dalla viva voce di chi c’era.
Buona Pasqua!
[1] https://www.inkiostri.net/drabble2022.html
[2] https://www.vinonuovo.it/comunita/bibbia-e-liturgia/via-lucis/
Un poco di Bach, con Chiara Bertoglio
Nella moltitudine di interessi degli Inkiostri la musica occupa un posto particolare: e per la nostra Chiara Bertoglio è molto di più che una passione. Il saepe noster Pier Francesco Miccichè ci recensisce qui l’ultima sua fatica, e le fa pure due o tre domandine scherzose, che non fa mai male, in questi contesti.
Chi ha studiato pianoforte e ha avuto l’onore (e l’onere) di confrontarsi con quanto scritto e trascritto dal celebre pianista Ferruccio Busoni (1866-1924) sa almeno due cose: il suo viscerale amore per Bach, e la complessità di scalare quelle montagne che sono le sue trascrizioni. Capaci di rendere sul pianoforte la profondità e la gravosità dell’organo, ma anche di restituirci le strazianti delicatezza e malinconia dell’immortale Ciaccona per violino solo, esse mettono costantemente a dura prova anche le abilità del pianista più avvezzo.
Negli ultimi mesi, la pianista e musicologa Chiara Bertoglio ha scalato quelle vette oltre ogni ragionevole prudenza, e il risultato delle sue fatiche, tutto per noi, è il quadruplo cd “Bach/Busoni: Complete Transcriptions, Arrangements and Contrapuntual Piano Works”, sesto volume del progetto pluriennale “Bach&Italy” realizzato dalla stessa Bertoglio per l’editore discografico Da Vinci Publishing.
Ben sette prime esecuzioni mondiali si celano tra le 74 tracce (oltre 4h30 totali) che comprendono, fra gli altri, i Preludi-Corali e le celebri Variazioni Goldberg, Fantasie, Fughe e toccate per organo, nonché gli studi-arrangiamenti che il pianista empolese ha composto su alcuni preludi del Clavicembalo ben temperato.
Un rapporto, quello tra Bach e il Belpaese (e viceversa) che la Bertoglio aveva già indagato a fondo nel Convegno “Bach e l’Italia” e nel volume omonimo che ne è conseguito, edito lo scorso anno da LIM.
Il cofanetto, giunto a pochi mesi dal centenario della morte di Busoni (24 luglio 1924) ha ricevuto il patrocinio del Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”, dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania di Roma e della Società Bachiana Italiana, e nei pochi giorni dalla sua uscita ha già ricevuto migliaia di ascolti sulle piattaforme online.
Un documento di valore scientifico, ma soprattutto un regalo prezioso per intenditori, studiosi e curiosi, che rende giustizia al genio italiano e conferma la riconoscenza per quello tedesco.

Per quello che hai fatto sei diventata l’eroina di tutti i tuoi fan. Se dovessi paragonare quest’impresa a un romanzo/episodio della letteratura fantasy, quale sarebbe?
Mamma mia, l’eroina dei miei fan… non mi ci vedo proprio! Comunque… se dovessi scegliere un episodio fantasy, credo che andrei su quello che forse è il mio preferito e che ho approfondito di più, ossia la Musica degli Ainur dal Silmarillion di Tolkien. È infatti un passaggio molto “iconico” per me, in quanto rappresenta ciò che ispira profondamente la mia vita, la mia relazione con la musica, con gli altri e… con Dio. La divinità immaginata da Tolkien, Ilúvatar, “consegna” dei “temi musicali” a delle creature angeliche, gli Ainur, cui affida il compito di “adornarli”, ed essi lo fanno dapprima singolarmente, perché conoscevano solo “la parte della mente di Ilúvatar” da cui ciascuno di essi proviene, e poi, una volta che hanno ascoltato le improvvisazioni dei loro fratelli, cominciano a cantare insieme, creando una musica polifonica meravigliosa. La musica è quindi autorivelazione del divino, e tramite essa, in un ascolto attento e rispettoso, si può costruire una società in cui le libertà di tutti cooperino alla bellezza. Così vorrei che fosse nella mia vita e nella società, e così, su una scala infinitamente minore, vorrei che fosse anche questo lavoro discografico: una “polifonia”, un mosaico musicale in cui i vari elementi, insieme, concorrono a creare qualcosa di bello e di armonioso.
Dalla tua leggendaria impresa è nata persino la parodia di una famosa aria mozartiana a opera di un membro degli Inkiostri: ti va di raccontarcelo?
Ahah! Qui devo ringraziare Elisabetta, una carissima amica la cui arguzia è pari alla sua simpatia e alla sua conoscenza della musica. Evidentemente, per poter registrare questi quattro CD, ho passato un tempo molto considerevole in “compagnia” di Ferruccio Busoni, tanto che – come ironizzavamo spesso – Busoni e io siamo diventati una… “coppia di fatto”! E allora, sulle presunte avventure e disavventure della “coppia” Busoni/Bertoglio, Elisabetta ha creato non solo un’aria, ma addirittura un intero libretto operistico i cui versi si possono cantare sulle melodie delle arie mozartiane. Ho riso come una matta! D’altronde, la vera moglie di Busoni fu un giorno salutata come la “signora Bach-Busoni”, quindi, tutto sommato… c’è un illustre precedente!
Alcuni degli arrangiamenti di Busoni rendono più difficili da eseguire opere bachiane che già non è che siano proprio “Tanti auguri a te”, ecco. Quali terribili peccati hai commesso per sottoporti a questo cilicio pianistico?
Ne ho commessi quanti basta, in effetti, ma nella fattispecie non so se si tratti di un contrappasso vero e proprio! Un po’, devo dire, le sfide mi hanno sempre attratta; un po’ c’era la concomitanza con il centenario della morte di Busoni (1924-2024); un po’, in modo quasi inavvertito e involontario, a partire dalla mia tesi di dottorato (2012) si sono create sempre più numerose occasioni per approfondire il rapporto “Bach/Italia”, del quale Busoni è naturalmente un rappresentante quanto mai significativo. A dirla tutta-tutta, forse se avessi saputo fin dall’inizio a cosa andavo incontro… ci avrei pensato su un momento. Però sono felicissima di non aver quantificato fin dall’inizio lo sforzo che sarebbe stato necessario, perché… con un po’ di sana incoscienza, questa non totale consapevolezza mi ha permesso di realizzare qualcosa che sono felice di poter consegnare a chi vorrà ascoltarlo!
Per ascoltare il disco su Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/49d4v34ERUDKeKRU2Mc28V?si=UVfNeHzoSMaPRhJmuouZIA
Per acquistare il cd fisico: https://davinci-edition.com/product/c00784/
Fiaba a New York
Fairytale of New York è una canzone natalizia, senza essere una canzone natalizia. Lo è in una maniera sottile (tanto sottile da essere trasparente).
It was Christmas Eve babe
In the drunk tank
An old man said to me, won’t see another one
And then he sang a song
The Rare Old Mountain Dew
I turned my face away
And dreamed about you
Got on a lucky one
Came in eighteen to one
I’ve got a feeling
This year’s for me and you
So happy Christmas
I love you baby
I can see a better time
When all our dreams come true.
Sarà il troppo gin in tutte queste tazze da thè che mi rimbambisce, ma a volte non sono troppo sicura di come siano andate le cose. Una volta le suore avevano sequestrato un libro a Marla Mulligan, quello di Alice di Walt Disney, e così tutte volevamo leggerlo (ottimo lavoro, suor Magdalene), e ad un certo punto c’era scritto che Alice era il sogno del Re Rosso, o dello Stregatto, va a ricordarti, dopo tutto questo tempo, e mi sento un po’ così, come fossi il sogno di un altro. Vedo tutto che sembra ci sia la nebbia al mattino, e la memoria mi fa brutti scherzi, e non sono sicura nemmeno se ho visto per la prima volta il tuo brutto muso irlandese sul marciapiede di Katonah Avenue o a Times Square o sdraiato su una panchina di Van Cortlandt Park. Però ho l’impressione fosse a Natale. Eri sbronzo (sai che novità) con un giacchetto di tela verde aperto ed un maglione di lana grossa sformato che ti arrivava alle ginocchia. Ero sbronza (sai che novità), mi abbracciasti col tuo naso gelido dicendo che mi avresti sposata e che saremmo stati infelici insieme per tutta la vita. Bella profezia, coglione. Passammo la notte correndo, senza mai fermarci.
They’ve got cars big as bars
They’ve got rivers of gold
But the wind goes right through you
It’s no place for the old
When you first took my hand
On a cold Christmas Eve
You promised me
Broadway was waiting for me
You were handsome
You were pretty
Queen of New York City
When the band finished playing
They howled out for more
Sinatra was swinging
All the drunks they were singing
We kissed on a corner
Then danced through the night
The boys of the NYPD choir
Were singing Galway Bay
And the bells were ringing out
For Christmas day.
Senza mai fermarci. Respinti con perdite. Mi raccontasti una quantità di balle, e io non meno. Sei sempre stato almeno brutto, altro che bellissimo, con quella manciata di denti che Dio pareva averti cacciato in bocca a caso, ed io non sono mai stata carina, neppure al massimo del mio splendore. Ma ecco, quella notte (mi convinco sempre più fosse Natale) in cui mi avevi ogni cosa, e il suo contrario, credo siamo stati qualcosa di simile all’essere felici. Ricordo ad un certo punto una banda (ma forse non era una banda ed era un tizio col flauto ed un tizio con tamburo) che scandiva il ritmo di Galway Bay, e tu prima iniziasti, con le tue gambe ossute da merlo, un passo di danza che sembravi lo spaventapasseri in quel film con Judy Garland, eppure non era male vederti, in un certo senso, e poi mi trascinasti con te. Cristo se dovevamo essere ridicoli, perfino in un quartiere irlandese in una notte di festa. Mi baciasti e poi, nel tuo alito: beh, per quella proposta di matrimonio? Io sono Sean, a proposito.
You’re a bum
You’re a punk
You’re an old slut on junk
Lying there almost dead on a drip in that bed
You scumbag, you maggot
You cheap lousy faggot
Happy Christmas your arse
I pray God it’s our last
The boys of the NYPD choir
Still singing Galway Bay
And the bells are ringing out
For Christmas day
Ho fatto un rabbocco qui alla tazza. Guarda caso: ha chiamato Orla facendomi gli auguri di Natale. Dio, se ti dimentichi che è Natale significa che sei alla frutta. Cat, mi ha detto, passa da noi, sai che c’è sempre un posto da noi. Ho risposto che ho ospiti. Orla non me l’ha fatto pesare. Figurati, ospiti in questa topaia, con la tua poltrona vuota che non ci si siederebbe sopra un cane. C’è ancora la macchia di quando ti ho tirato lo stufato d’agnello perché avevi detto che Dickie Moore era un finocchio. Quante ce ne siamo dette negli anni.
I could have been someone
Well so could anyone
You took my dreams from me
When I first found you
I kept them with me babe
I put them with my own
Can’t make it all alone
I’ve built my dreams around you.
Ringhiai sibilando che chiunque sarebbe potuto essere al tuo posto, e che è stato solo il fottuto caso che mi aveva messo il tuo muso davanti, rovinandomi ancora di più la vita. Ti sgonfiasti come un sacco vuoto, e non ho mai capito perché: forse credevi che in fondo era stato qualcosa di simile al destino a farci incontrare, comunque poi fosse andata. Strisciando e in ginocchio mi abbracciasti le gambe, dicendomi poche parole, che conservo ancora nel cuore della mia memoria incasinata, e che forse saranno le ultime parole che mi rimarranno in testa, se Dio vorrà. Il poeta più fallito al di qua ed al di là dell’oceano: una fiera di insuccessi, a me, per me, attraverso me. Fanculo Grace Kelly, c’è una principessa anche sulla Duecentotrentaseiesima.
The boys of the NYPD choir
Still singing Galway Bay
And the bells are ringing out
For Christmas day.
Perché ora non ci sei più, e mi hai lasciato sola, stupido coglione, e queste mura bianche e spoglie non sentono più la tua voce roca a dire idiozie, e sento spesso freddo. Ho appeso fuori dalla finestra le vecchie luci di Natale, quattro lampadine rosse intermittenti da vergognarsi, e mentre le mettevo, ho come sentito una canzone distante, portata dal vento, ma non mi ricordo il titolo.
Quando ti rivedrò, prego che forse mi dirai Cat, sei proprio scema, è la nostra canzone.

Kirsty Anna MacColl è morta a 41 anni il 18 dicembre 2000. Shane MacGowan, irlandese, poeta, cantante, è morto il 30 novembre 2023. Al suo funerale, alla chiesa di St. Mary of the Rosary a Nenagh, nella contea di Tipperary, è stata suonata Fairytale of New York. Tutto sommato, se ballano al tuo funerale, qualcosa di buono nella vita l’hai fatto.
La Stella, di Davide Gorga
Il nostro Davide ci regala un racconto di Natale: speriamo possa piacere a voi quanto è piaciuto a noi. Lo potete anche scaricare qui.
Il lampione splendeva lucido e specchiante a lato del ponte in pietra grigia che varcava tranquillo l’Adige fluente tra oscurità e veli di nebbia. Il lieve mormorio delle acque era interrotto dal suono dei passi della ragazzina che camminava in silenzio, gli abiti rossi confusi tra il nero della notte, al centro delle mura merlate, lo sguardo fisso dinanzi a sé che talvolta vagava inquieto verso le poche luci che si disegnavano nel buio, una qui, una là, tra macchie d’ombra fitta. Una luna fragile splendeva a tratti fra veli di nuvole viola, nessun vento e nessuna voce. Affrettò il passo; la via era deserta, il mormorio del fiume lieve.
D’improvviso, come apparso da un favoloso sogno, vivace e multicolore nella nebbia quasi rinato da miriadi di goccioline di pioggia splendenti, appoggiato noncurante con le spalle al parapetto, un giovane alto, vestito d’ogni colore, rilucente nell’oscurità, comparve dinanzi ai suoi occhi. Al suo fianco, un bastone. Un cane grigio argento dagli occhi azzurri e le zampe agili gli saltellava intorno. La bisaccia mezza vuota gli penzolava da una spalla, un flauto era nella sua mano destra, canterellante sulle pieghe dei pantaloni verdi e gialli, sgargianti come raggi di sole tra i prati.
La ragazza si arrestò, incapace di proseguire. Al centro del selciato rimase immobile, stringendo i pugni, finché le dita non divennero bianche.
L’uomo parve finalmente accorgersi di lei. Volse lo sguardo sulla sua persona, quasi incredulo, come se un fantasma fosse apparso ai suoi occhi. Ergendosi nel mezzo della via, esclamò:
«Lucia, tu mi vedi!?» — la sua voce fu musicale come una campana d’argento;
«Sarebbe difficile non vederti! Sei sotto un lampione!» — fece di rimando la ragazzina; — «E tu come sai il mio nome?»
Il giovane dai vestiti sgargianti rise con una voce forte e gentile; portò il flauto alle sue labbra e accennò un inizio di melodia triste e allegra, senza tempo, quindi riprese ad alta voce: «Sei davvero tu! E allora, vieni, andiamo!» — estrasse un libro dalla borsa a tracolla, aprendolo a metà: i caratteri parvero illuminarsi di luce propria; quindi lo sfogliò rapidamente e sembrò che un arcobaleno di luce si riversasse sulla via; infine, con gesto senza suono che echeggiò nel fondo dell’anima di Lucia, si arrestò a una pagina dal disegno confuso, nero e oro.
«Dove!?» — chiese Lucia, ma l’altro le tese la mano e a lei parve che ogni paura si dileguasse. Non più il timore della notte scura, della nebbia, della solitudine. E seguì solo quella scia di colori che pareva aver preso una scala d’aria arrampicandosi veloce nel cielo notturno, tanto che presto si trovarono oltre le nuvole basse che aleggiavano sulla città e videro scintillare le stelle come diamanti in cielo; eppure, non avevano freddo. Anche il cane li accompagnava, danzando festosamente intorno a loro, quasi fossero stati sul fianco solido di una montagna. Sempre più in alto e sempre più lontano salivano, e presto una musica d’argento prese forma dallo strumento del compagno che li guidava. Oltrepassarono la notte scura e diversi cieli si avvicendarono intorno a loro, nell’eterno movimento delle stelle.
Tra le vallate e le città sparse, Lucia iniziò a vedere scintillare un bagliore d’oro simile a un filo che le attraversasse tutte, l’una dopo l’altra. A un certo punto, fu silenzio.
«Chi sei?» — chiese ancora Lucia al suo accompagnatore in quel viaggio aereo.
Gli occhi azzurri del giovane scintillarono: «Sono una Stella, quella che da sempre abita nel profondo della tua anima. O la tua luce, se preferisci.» — concluse sorridendo e indicando la terra lontana sotto di loro: «Vedi qualcosa oltre il buio?»
«Vedo una sottile linea di luce.»
«E hai ancora paura come quando ci siamo incontrati sul ponte? Paura dell’oscurità, della solitudine.»
«Ora sono con te.» — obiettò Lucia.
«Giusto!» — rispose l’altro; «E ora, guarda una Stella nella sua essenza!»
Il flauto riprese a suonare lieve, e dall’oriente giunse una luna piena in un freddo cielo distante: sembrava enorme. Di fronte a lei, all’ovest, una luce intensa ardeva bianca nel cielo, come se stesse catturando voci d’angeli pure e chiare, fredde, possenti, riverberanti nel cuore luminoso. Al di sotto, lo splendore s’irradiava su un deserto varcato da tre figure ammantate. Incedevano maestose, nel chiaro di luna, indicando la stella. Il tempo passava, il flauto tacque. Infine, la Stella fu così vicina che parve di poterla toccare, e gli abiti multicolori del ragazzo si ghiacciarono in un’unica luce bianca.
Una delle figure uscì dall’ombra: additava agli altri una costruzione inondata dal chiarore. Le grida di gioia degli altri fecero eco e musica. Dinanzi a loro, attraverso una piccola apertura, giaceva un bambino in fasce, deposto nella mangiatoria degli animali. Una donna e un uomo lo vegliavano. Il tempo si fermò.
Vento inclemente e nero riprese a soffiare intorno a Lucia. «Quando siamo ripartiti?» — tentò di domandare alla sua guida — ma le sue parole si dissolsero nel turbine della corsa. Sempre più veloce la Stella viaggiava e suonava; una musica dura, ritmata, allegra come rosso albeggiare nell’inverno. Giunti a un valico videro una catena di monti rischiarata qua e là da fiamme ondeggianti; al passo più alto si fermarono, in lontananza giganteggiava nero un castello. Il cane si avvicinò a Lucia, guardandola e scodinzolando. Ed entrambi scesero. Oltre le macchie di abeti neri si apriva un villaggio, le case in pietra, le strade di terra; ogni cosa immersa nel silenzio. Il cane si volse verso di lei, e Lucia lo seguì mentre saliva proprio in cima al crinale. Giunsero alla sommità. I bambini correvano. Le donne ridevano. Gli uomini suonavano e mangiavano intorno al fuoco. Le ombre oscillavano. Una ragazza alta si avvicinò al falò più grande, un giovane contadino la prese per mano. E insieme danzarono come cigni di fiamma, rivoli di vita. Il cane saltò di fianco a loro e iniziò a guaire e latrare, nessuno se ne accorse. E poi bambini, donne, uomini, proruppero in una grande risata: era il calore del mondo che entrava dentro Lucia, come un fuoco amichevole.
In breve, la Stella fu di nuovo presso di lei; «Vieni!» — disse ancora, e, nonostante Lucia non volesse abbandonare quel luogo, lei e il cane furono di nuovo in viaggio.
Dinanzi alle vetrate di un grande magazzino, videro un ragazzo urlare e correre. Le luci al neon si alternavano al silenzio nero. La corsa a perdifiato si concluse sotto un ponte, dove solo l’ansimare si materializzava come fiato bianco dinanzi a lui. La Stella gli si avvicinò e indicò a Lucia un luccichio per terra, come quello che le era parso di intravedere dall’alto. Lo seguì, provò a toccarlo con una mano e avvertì un calore immenso dentro il palmo — e poi dentro l’anima. Era come il calore della festa di pochi minuti prima (di molti secoli addietro) danzante tra le fronde, eppure cento volte più intenso, tanto che le veniva da piangere tanto era bella e dolce e forte la sensazione. Si sentì traboccare, come un fiume che esca dagli argini, e toccò il ragazzo tremante davanti a lei.
Questi sembrò non vederla, eppure, poco per volta, si calmò. Si sedette prendendosi il capo tra le mani. Quindi, l’asfalto fu bagnato dalle sue lacrime. Lucia lo vide rialzarsi, allontanarsi lungo la strada, fino a una casa da cui uscivano luce e un calore simile a quello che sentiva dentro di lei. Una donna dall’aria altera si disegnava all’ingresso. Non appena vide tornare il ragazzo, gli corse incontro piangendo, abbracciandolo e stringendolo a sé, riportandolo a casa, figlio amato e restituito.
La Stella riprese con sé Lucia. Percorsero le più alte vie del cielo, e ora agli occhi di Lucia era visibile una scia dorata, sempre più grande, sempre più bella, che attraversava città, borghi, prati, mentre il calore e l’affetto crescevano dentro di lei. E infine capì. Era il suo animo a disegnare la strada — era la strada a richiamare il suo animo. Ed entrambi erano una cosa sola.
Il ponte sull’Adige li riaccolse lieve, il cane prese a fissare Lucia, la Stella smise di suonare e la fissò con aria allegra, antica; «Hai ancora paura?» domandò lieve.
La ragazzina parve non capire; l’altro riprese: «Quando ci siamo incontrati temevi l’oscurità, il silenzio, le cose che si potevano celare, perché non le conoscevi. Ora non sembrerebbe davvero. Non più almeno.» — Lucia annuì. La Stella riprese — «Hai respirato la Gioia. Quella che rimane dentro, e non scompare. Sei diventata sensibile al mondo che vedevi ma non interpretavi, e nonostante sia sempre più raro vedere ciò che si nasconde oltre i muri di mattoni e di pianto, tu ne sei ancora in grado: per questo stasera hai potuto incontrarmi.»
Lucia rimase un attimo in silenzio, quindi rispose lentamente: «Dovrò viaggiare molto, vero?»
«Il viaggio più grande lo farai dentro te stessa.» rispose con voce più grave la Stella.
«Vedo dinanzi a me una scia d’oro, come una luce!» esclamò Lucia — «O forse no, più che vederla la sento! Calda e forte.»
«Ricordi la danza intorno al fuoco, le risa, le canzoni? Ecco, quella è un’infinitesima parte dell’amore che è dentro di te. E con esso, potrai risvegliare i cuori freddi nella notte di gelo e condurli alla salvezza.»
Il cane guaì lieve; il paesaggio iniziò a tremolare, come in una giornata troppo calda, la nebbia ad avvolgere di nuovo gli abiti multicolori della Stella.
«La tua Via conoscerà molti momenti diversi,» — continuò il ragazzo, «eppure l’amore ti guiderà attraverso essi, dovrai solo seguirla senza esitare, e non avrai più paura: né dell’oscurità, né del dolore, perché sarai più forte, fiera, coraggiosa. Anche nel più oscuro dei cieli la gioia vince sempre, come una musica eterna.»
Lucia annuì ancora. Sentiva dentro di sé una felicità che niente, in futuro, sarebbe riuscito a cancellare. Né la fatica, né l’ignoto — perché ora sapeva di poter vedere l’invisibile, afferrare ciò che si cela oltre i cuori. Nulla vi era più di nascosto. Tutto era rivelato. E la Via si snodava dinanzi a lei. Infine disse: «Ora devi andare via, vero, Stella?»
La consistenza degli abiti del ragazzo, sempre più simili a gocce in via di evaporazione, i margini della sua figura, il suo cane, il bastone, la bisaccia, parevano ondeggiare tra i confini del Tempo; in questo sorrise: «Hai imparato bene, Lucia! Ama, e sarai felice!» esclamò la Stella prima di svanire.
Lucia si ritrovò sola sul ponte, tra il mormorio del fiume e qualche velo di nebbia. Avanzò decisa, senza più curarsi degli angoli oscuri e dei rumori sconosciuti. Dentro di sé udiva una gioia che non avrebbe mai dimenticato.
Camminò senza esitare fino a casa. Qui sorrise a sua madre e al fratello: poi si mise a guardare dalla finestra. Le domandarono se le fosse accaduto qualcosa. Ma Lucia rispose: «Nulla!»
Era un’esperienza troppo importante, e riservata solo a lei.
Ma l’amore e la conoscenza di cui aveva preso conoscenza le riversò interamente su di loro.
E quando la sera le capitava di osservare una stella che sembrava scintillare di fuoco bianco, ricordava l’incontro sul ponte e sentiva più forte il richiamo della Via e della gioia.
“La cronaca” di C.S. Lewis, nel sessantenario del suo dies natalis
Intervista con Paolo Gulisano
Clive Staples Lewis (29 novembre 1898, Belfast – 22 novembre 1963, Oxford) fu eminente professore di lingua e letteratura inglese all’Università di Oxford, ma, soprattutto, grande autore di narrativa con opere quali Le Cronache di Narnia, Le Lettere di Berlicche, The Space Trilogy, Il Grande Divorzio, e di saggistica come I quattro amori, Sorpreso dalla gioia; nonché amico fraterno di J. R. R. Tolkien, con cui – e non solo – egli animò per anni gli Inklings (“Imbrattacarte”), eutrapelica compagnia di amici uniti da ciò che è Vero, Bello e Buono; Humphrey Carpenter, biografo di Tolkien, dedicò loro un libro. Il gruppo si ritrovava al pub oxoniense The Eagle and the Child (ribattezzato The Bird and Baby), ogni martedì sera a discutere e a leggere anticipazioni delle opere che andavano scrivendo, tra letteratura, poesia, allegrezza e il fumo delle immancabili pipe.
Era il 22 novembre 1963, quando a Oxford, in Inghilterra, Clive Staples Lewis si congedava da questo mondo. Quello stesso giorno in cui, a Dallas, in Texas, venne assassinato il trentacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America (1961-1963), ossia John Kennedy, tra gli uomini più popolari e stimati a livello internazionale. L’attentato non lasciò molto spazio alla morte di Lewis, monopolizzando i media e l’opinione pubblica mondiale.
Per approfondire la storia di questo insigne figlio d’Irlanda, ho contattato il dottor Gulisano, il quale, oltre a essere un esperto tolkieniano (come dimostra questa intervista fattagli nel settembre scorso, per celebrare il “cinquantenario” tolkieniano: https://t.ly/WMf_2) è anche un autorevole studioso del (sub)creatore di Narnia, a cui ha dedicato C.S. Lewis. Tra fantasy e Vangelo, edizione Ancora, Narnia. La teologia fuori dall’armadio, co-curato con altri studiosi di Lewis e, più recentemente, Clive Staples Lewis. Nella Terra delle Ombre, edito da Ares.
Chi è Clive Staples Lewis? Quali sono le tappe salienti della sua vita?
Lewis è stato un grande intellettuale del ‘900, un uomo che ha dato di che pensare con i suoi scritti letterari e filosofici, ma che allo stesso tempo ha divertito, commosso e fatto sognare milioni di giovani lettori con le sue narrazioni fantasy. Fu senza dubbio uno dei più singolari intellettuali dell’Inghilterra del suo tempo, un uomo affascinante e contraddittorio: non era un professionista dei racconti per bambini, né ebbe mai figli a cui narrare fiabe alla sera, ma realizzò con Narnia un autentico classico della Letteratura per ragazzi; visse gran parte della sua vita in Inghilterra, diventando uno dei massimi protagonisti della vita culturale del Paese, ma era irlandese. Era però, a differenza della grande maggioranza degli irlandesi che era cattolica, di fede protestante. Non di meno è stato un grande apologeta del Cristianesimo, che difese con lucidità e passione dalle aggressioni ideologiche della Modernità. Una personalità complessa, ma proprio per questo estremamente interessante. Nasce nel 1898, a Belfast, poi si trasferisce a studiare in Inghilterra, e diventerà professore prima a Oxford e poi a Cambridge. Passerà dall’ateismo militante al Cristianesimo attraverso una conversione che fu dovuta in gran parte al collega e amico John Ronald Tolkien. Morì il 22 novembre 1963, sessant’anni fa. Una data restata nella storia, perché quel giorno venne assassinato a Dallas il Presidente John Kennedy.
Cosa ci puoi dire al riguardo delle opere di C.S. Lewis, dalle più celebri (ad es. Le Cronache di Narnia, Le lettere di Berlicche, I quattro amori) a quelle – purtroppo – meno note ma non meno significative (ad es. i testi della “trilogia del cosmo” e Il grande divorzio).
Scrisse opere storiche e libri in difesa del Cristianesimo in un mondo che vedeva scivolare inesorabilmente verso l’indifferentismo religioso, ma scrisse anche opere di fantascienza, e romanzi ricchi della presenza di riferimenti simbolici e mitici.
Potrebbe sembrare strano che un professore di Oxford, docente ed esperto di letteratura inglese medioevale e rinascimentale, sia conosciuto soprattutto per la sua produzione fantastica. In realtà la biografia di C. S. Lewis ci rivela un percorso in cui il fantastico occupa uno spazio importante, e soprattutto si manifesta saldamente connesso con tutto l’itinerario spirituale dello scrittore. Lewis non è solo il brillante autore delle Cronache di Narnia, lo scrittore moralista di successo, esperto nell’uso del registro ironico con cui dava forza ai contenuti della sua rilettura di un pensiero cristiano radicato nell’esperienza dell’uomo contemporaneo (come nelle arcinote Lettere di Berlicche).
Nei suoi saggi, uno degli obiettivi fondamentali è la messa a fuoco dell’universo culturale che ha inquadrato la vita dell’uomo europeo fino alla nascita del mondo pienamente moderno. L’orizzonte intellettuale che lo ha abbracciato è quello che si è riflesso nella tradizione enciclopedica di un sapere ridotto a una unità facilmente accessibile dall’uomo antico e medievale.
Quando nacque l’amicizia con J.R.R. Tolkien e quanto fu fondamentale per la sua conversione dall’ateismo al cristianesimo? Per quale motivo non divenne pienamente cattolico?
L’incontro avvenne all’Università di Oxford, dove entrambi erano giovani insegnanti. L’amicizia nacque dallo stupore di riconoscere interessi e passioni comuni. I due si intrattenevano in lunghe discussioni. A dividerli sembra esserci la religione: Tolkien era profondamente cattolico mentre Lewis – nato protestante- era diventato un ateo convinto. Lewis non nascose, fin dall’inizio, di avere un pregiudizio religioso nei confronti di Tolkien: era nato nell’Irlanda del Nord, discendente di quei britannici, che avevano fatto parte del piano di colonizzazione attuato dall’Inghilterra dopo la conquista militare dell’Irlanda. Sudditi fedeli di Londra, avamposto dell’Impero, fieri protestanti visceralmente anti-cattolici. Lewis tuttavia aveva abbandonato in gioventù la religione dei padri, ed era transitato nei territori aspri dell’ateismo. Fu Tolkien a toccargli il cuore e la mente, e a portarlo ad abbracciare il Cristianesimo. Tolkien avrebbe voluto naturalmente potarlo nella Chiesa Cattolica, ma Lewis si “fermò” alla Chiesa Anglicana, anche nel suo parlare di Medioevo, si avvertiva la nostalgia per quando la Chiesa era Una e indivisa.
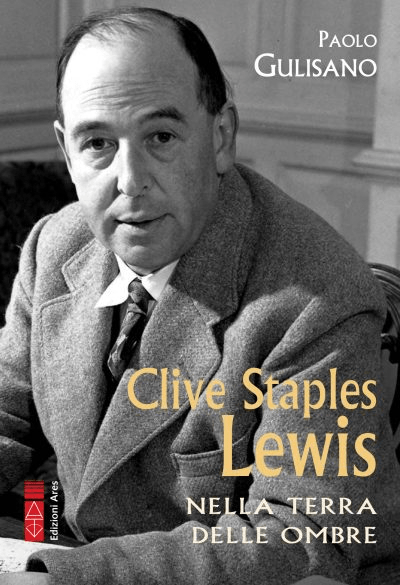
Quali temi e valori li unirono in profonda amicizia, al punto di giungere a dirsi: “Come? Anche tu? Credevo di essere l’unico…”? E quali scelte tematiche e stilistiche, invece, li contraddistinguono nettamente?
Li univa la comune passione per il Bello, il Buono, e soprattutto il Vero. Tolkien gli aveva fatto comprendere che tra i tanti Miti, ce n’era uno che si era inverato, e precisamente si era incarnato . Li univa la passione per la Letteratura mitica, epica, e per il Medioevo come grande civiltà. Li divideva un aspetto: Tolkien era molto preciso e filologicamente accurato nelle sue elaborazioni immaginarie, mentre Lewis realizzò con Narnia ma anche con la Trilogia Cosmica una vasta commistione di mitologie e leggende che non piacque molto al creatore del Signore degli Anelli.
I più noti cattolici di Inghilterra, quali San John Henry Newman, Hugh Benson, Chesterton, lo influenzarono? Vi erano altri “ispiratori”?
L’unico tra i grandi cattolici inglesi che ispirò Lewis fu Chesterton. Anzi, prima che Tolkien riuscisse a convertirlo, una prima breccia nel suo ateismo si era aperta grazie alla lettura di Ortodossia di GKC. Soprattutto rimase colpito dall’affermazione del gigante di Beaconsfield che “Lo straordinario segreto del Cristianesimo è la Gioia”. Una prospettiva del genere, per lui che veniva dall’Ulster calvinista, era assolutamente inedita, e lo colpì molto. Per il resto, gli ispiratori di Lewis furono gli autori religiosi, come i pensatori medievali, la Letteratura Cortese, e infine i Padri della Chiesa. Fonti antiche alle quali era andato ad attingere.
Tra i suoi amici di penna vi era un importante sacerdote veronese, Don Giovanni Calabria, fondatore delle congregazioni dei Poveri Servi e delle Povere Serve della Divina Provvidenza. Che tipo di rapporto fu il loro?
Don Calabria, uno dei grandi santi della Carità degli ultimi secoli, era anche un uomo di sana curiosità intellettuale. Aveva letto Le Lettere di Berlicche, e ne era rimasto affascinato. Volle allora contattarne l’autore, prese carta e penna, e scrisse in latino (non sapeva l’inglese!) al professore di Oxford, il quale immediatamente rispose, sempre in latino. Fu l’inizio di una lunga corrispondenza epistolare, durata anni, fino alla morte di don Calabria. Erano tempi in cui l’ecumenismo era quasi sconosciuto, e questa amicizia tra un prete cattolico e un intellettuale anglicano poteva sembrare molto insolita, ma entrambi erano due anime assetate di Dio, e senza alcun compromesso né sincretismo si testimoniavano l’un l’altro la gioia e la passione del credere.
Il 31 ottobre è stato pubblicato il libro più recente che hai dedicato proprio a Lewis. Che cosa potremo trovarvi? Perché hai sentito l’esigenza di dedicarglielo?
Ho voluto raccontare la vita stessa e l’opera di Lewis, tant’è che il libro è diviso in due parti che affrontano entrambi gli aspetti. Ho cercato di raccontare il desiderio di Lewis di realizzare il progetto buono di Dio. Un ideale che si concretizzò nella ricerca della Verità e della Gioia. Tutte le opere di Lewis s’intrecciano variamente attorno ad un tema che ritorna costantemente e che, parafrasando le sue stesse parole, possiamo definire «the lived dialectic of Desire», la dialettica vissuta del desiderio. Un desiderio imprecisabile, ma intensissimo, che Lewis inseguì tenacemente per tutta la sua vita e che crebbe di pari passo con la sua evoluzione spirituale, assumendo di volta in volta connotazioni sempre più definite e arrivando, finalmente, ad essere identificato come la Gioia.
Due incontri (per chi è di Torino, o lì vicino)
Nella serata di oggi, e poi ancora il primo di dicembre, a Torino, presso l’Aula San Bernardino, si terranno due interessanti incontri, moderati dal nostro Daniele Barale: nel primo si rifletterà sulle sfide e le opportunità attuali della Chiesa, a partire dal libro di Matteo Matzuzzi Atlante geopolitico del cattolicesimo. Il secondo sarà occasione di celebrare, assieme a Paolo Gulisano, il dies natalis dei nostri J.R.R. Tolkien (50 anni: 2 settembre 1973) e C.S. Lewis (60 anni, 22 novembre 1963).
Partecipateci!

Un ultimo accordo di Schumann, di Filippo Bergonzoni
Radici a Bologna, ma trevisano di adozione (perlomeno lavorativa), il nostro Filippo Bergonzoni, insegnante di filosofia, domenica 5 novembre ha ricevuto un importante riconoscimento letterario (primo premio ex-aequo) che porterà alla pubblicazione il suo romanzo d’esordio “Un ultimo accordo di Schumann”. Si tratta del premio “Lorenzo Da Ponte”, un concorso abbastanza singolare nel panorama nazionale, in quanto dedicato alla narrativa musicale. In altre parole si partecipa con un romanzo inedito in cui la musica non sia soltanto un elemento di contorno, ma il tema centrale e l’anima ispiratrice di una storia di fantasia. Chiacchieriamo con lui sulla genesi di quest’opera prima.
Filippo, tu hai partecipato al premio “Lorenzo Da Ponte” con un tuo romanzo breve nel cui titolo compare il nome di Schumann. Che cosa ti lega a questo musicista?
Schumann è un campione assoluto della fantasia e della creatività, nella sua opera pianistica rifugge dalle forme classiche per prediligere il frammento, l’aforisma musicale breve e discontinuo. Nelle sue composizioni più celebri (penso a “Papillon” o “Carnaval“) assistiamo a un caleidoscopio di scene sempre mutevoli e cangianti, raggruppate in particolare attorno a due stati d’animo dominanti: “Florestan”, l’anima più esuberante ed estroversa, e “Eusebius”, quella più riflessiva e intimista. Ecco, penso che ciascuno di noi, in parte, porti questa duplicità dentro di sé, magari senza arrivare a quegli esiti patologici in cui cadde purtroppo il compositore tedesco. La sua musica, in fondo, è un ottimo compagno di viaggio per capire meglio se sessi.
Ti senti più Florestan o Eusebius?
Nella vita di tutti i giorni direi Eusebius, ho studiato tanti anni filosofia e in questa disciplina sono fondamentali la calma e la riflessione. Ma ci sono dei momenti in cui irrompe Florestan, in compagnia di amici o in qualche vivace discussione con i miei studenti. O magari proprio nello scrivere un romanzo, in cui mi permetto di narrare cose di cui non parlerei mai nella vita reale.
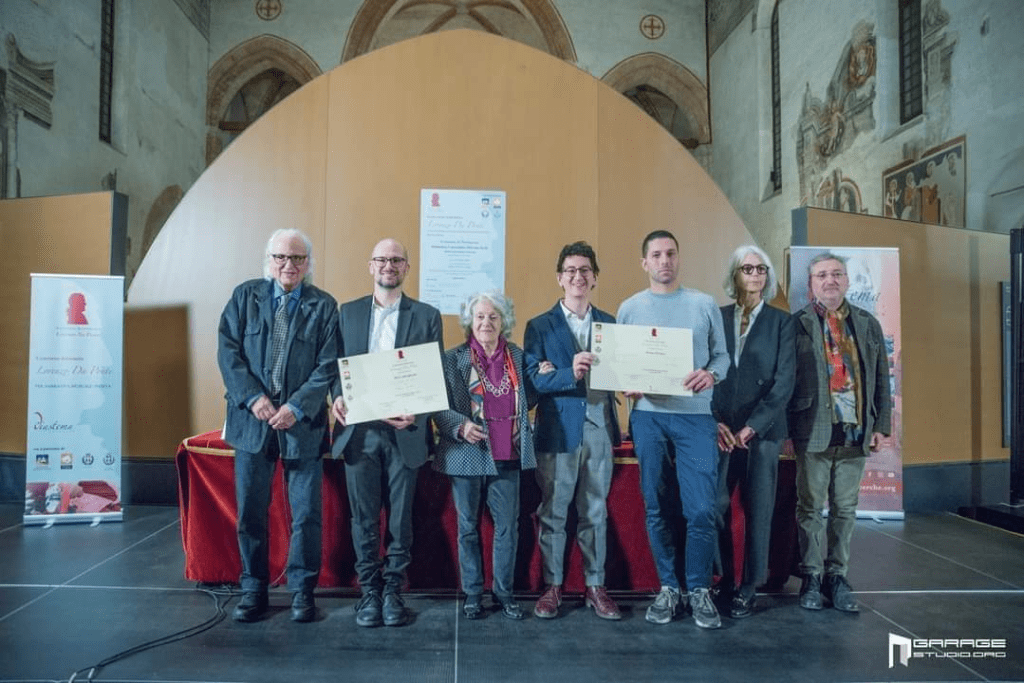
Quanto c’è di autobiografico in questo tuo lavoro?
Nel romanzo è chiaramente autobiografico l’incipit: un professore di liceo sulla quarantina riceve un incarico di ruolo, in modo inaspettato, in una città distante dalla sua, dovendo così organizzare un rapido trasferimento. Ma la vita reale si ferma qui, un certo pudore (l’Eusebius che è in me!) impedirebbe di mettermi troppo in mostra. A partire da questo spunto ho inventato la storia di Pietro – il nome del protagonista – che in passato era stato un pianista di talento, sfiorando il successo in duo con un suo geniale compagno di Conservatorio. Ma la vita gli riserverà un altro destino e solo alla fine, forse, riuscirà a ritrovare se stesso. È un libro in cui i sentimenti sono in primo piano in tutte le loro sfaccettature, dall’amicizia, alla rivalità, al perdono, all’amore. E sono molto felice che la giuria l’abbia definito “avvincente” e “convincente”.
Nella stesura hai avuto un autore o un’opera di riferimento?
Se proprio dovessi indicare un’opera di riferimento non direi un libro ma, in modo un po’ inaspettato, un film: “C’era una volta in America” di Sergio Leone. Ci sono due elementi che mi hanno sempre colpito in quel capolavoro, da un lato il complesso intreccio tra tempi narrativi diversi, e dall’altro il fatto che due amici per la pelle, dopo che le loro strade si erano divise, si ritrovano molti anni dopo per un commosso bilancio esistenziale. Naturalmente il mio romanzo non è un gangster movie, ma entrambi questi aspetti sono presenti.
Chi saranno i lettori del tuo libro? Solo addetti ai lavori?
Al di là del titolo e di qualche riferimento più tecnico presente nel testo, non vuole essere un libro solo per musicofili o specialisti. Schumann, in fondo, è un pretesto per raccontare una storia di vita che si svolge ai giorni nostri, che spero possa coinvolgere e appassionare il maggior numero possibile di lettori. Una storia fatta di entusiasmi e difficoltà, di gioia e ostacoli da superare, in quell’alternanza di sentimenti che caratterizza un po’ l’esistenza di ciascuno di noi.
Il romanzo di Filippo sarà pubblicato da Diastema. Vi aggiorniamo eh!
Incubi, di Andrea Donna
Qui sotto una breve chiacchierata col nostro Andrea Donna, che ha pubblicato recentemente, per Aristodemica, Incubi, una raccolta di poesie ed una riscrittura de Fungi from Yuggoth di Howard Phillips Lovercraft. Il libro lo potete acquistare tramite questo form, oppure alla librerie Arethusa (via Giolitti 18, Torino) e Donostia (via Monginevro 85/A, Torino). Qui trovate una videointervista dell’editore Antonello Fabio Caterino ad Andrea.
I tuoi Incubi potrebbero aprirsi con l’Ozymandias di Shelley: I met a traveller from an antique land who said … Te saresti questo viandante, che racconta scorci di vecchie storie.
C’è un io lirico che viaggia — da solo o con i propri compagni — in uno spazio e in un tempo che oscillano tra la dimensione fisica e quella onirica. Verissimo: ciò che queste voci raccontano sono scorci di storie, brandelli che si interrompono — fatto tipico dei sogni paurosi: “La caduta”, “Il precipizio” — un attimo prima della fine, della tragedia.
Si ha in tutta la raccolta l’impressione che racconti mondi antichi, più che primitivi, prima del Diluvio, che incidentalmente sono sopravvissuti, in qualche residuo, al loro sgretolarsi: che ci inquieta.
L’esistenza di civiltà indicibili e inconcepibili, antichissime, pre-umane o sovra-umane è uno dei fondamenti della mitologia di Lovecraft, i cui “Fungi from Yuggoth” riscrivo nella seconda metà del volume: ho ripreso anche nei sonetti originali questo topos, sfruttandone il potenziale espressivo ed evocativo, pur cercando sempre di evocare e alludere, senza affermare esplicitamente.
Visto che l’hai citato, andiamo direttamente su Lovecraft (che vedo avere scritto Fungi from Yuggoth tra il 27 dicembre 1929 e il 3 gennaio 1930: un modo molto proficuo di passare il periodo natalizio): vorresti prima di tutto darci una sua biografia sentimentale (darei per scontato che per quella ordinaria ognuno possa visitare la rete), vista attraverso i tuoi occhi?
Sapendomi lettore di Poe, un compagno di classe e tuttora grande amico mi prestò, a pochi mesi dalla maturità, una raccolta di racconti, assicurandomi che Lovecraft, che qualcuno ha definito il più grande e inconsapevole parodista dello stesso Poe, mi avrebbe cambiato la vita: fu così, pur facendo la tara alla natura iperbolica del concetto di “cambiare la vita”. Uno dei pochissimi autori che leggo o rileggo costantemente da quasi trent’anni: un amore letterario nato in adolescenza e non raffreddatosi — tutt’altro — con l’età adulta.

Quali sono le peculiarità di Lovecraft che più hanno toccato la tua immaginazione, e così influenzato la tua attività poetica e letteraria?
Il Lovecraft che si esprime in versi è in grado di costruire storie dell’orrore pienamente compiute, credibili, efficaci e perfettamente moderne in una forma poetica, quella del sonetto elisabettiano, di per sé adatta a contenuti più lirici che narrativi e a una scelta stilistica tradizionale più che contemporanea: fatto tanto sorprendente, ai miei occhi, da aver stimolato non solo la ripetuta lettura, ma la riscrittura del corpus dei “Fungi from Yuggoth”.
Anche nella tua premessa lo specifichi: è più una riscrittura che una traduzione. In cosa hai avuto particolarmente l’impressione di essere “coautore” dei “Fungi from Yuggoth”?
Sentirmi coautore dei “Fungi” sarebbe, da parte mia, decisamente presuntuoso: ma senz’altro posso dirmi autore secondario di una versione in lingua italiana della raccolta. Se è vero — ed è vero, a meno che non voglia limitarsi a una traduzione interlineare di servizio — che chi traduce poesia in realtà sempre riscrive, io ho esasperato questa scelta programmatica: e sono stato quasi obbligato, dal momento che non avrei potuto rispettare, insieme, prosodia, atmosfera e senso letterale; ho scrupolosamente mantenuto la prima e la seconda, sacrificando il terzo.
Ecco: l’atmosfera: sia nelle tue composizioni originali, sia nella riscrittura dei “Fungi” l’atmosfera sembra prevalere su ogni cosa. Si viene calati in queste realtà dove il non detto e l’allusione sono parte essenziale del piacere (e dello stimolo) che tocca il lettore.
Notazione critica puntualissima: confermo quanto dici. Inoltre il desiderio e il piacere di creare un’atmosfera — da incubo o da sogno — è stata anche la principale leva che ha stimolato la scrittura o la riscrittura dei componimenti.
Probabilmente perché una atmosfera è “più ampia” di una storia in sé: riesci a creare un mondo, o una parte di esso, in cui chi legge possa perdersi e, in parte, avere delle proprie storie, complementari a quelle che immagini tu.
Possiamo senz’altro dire che l’elemento dell’emozione non è subalterno all’elemento strettamente narrativo né nei “Fungi” né negli “Incubi”.
Potrebbe essere interessante a chi ci legge magari avere davanti una tua poesia, e sentirsela descrivere (anche se probabilmente la poesia non sarebbe mai troppo da raccontare) da te. Mi piacere che tu ci parlassi ad esempio di XII – La Torre:
La prora si schiantò contro gli scogli
Dell’isola da eoni massacrata
Da gelidi marosi e circondata
Da bianche procellarie e capidogli:
Un luogo di desolazione atroce,
All’uomo ignoto e alla cartografia;
E pur pervaso di una sua malia,
Al largo dell’Antartide feroce.
La terra più vicina era a migliaia
Di miglia; disperati perlustrammo
La riva gelida e ci arrampicammo
Sull’orrido inciampando sulla ghiaia:
Gran Dio! Sull’altipiano d’atra lava
Pietrificata una torre svettava!
Dove, in proposito di atmosfera, sembra di stare tra Poe e Coleridge, mi pare.
Un noi lirico (non un io) e l’emisfero sud: la dimensione collettiva della spedizione ricorre frequentemente negli “Incubi”, spesso ambientati nell’emisfero australe e in contesti di gelo. Non vi sono elementi che permettano di identificare un periodo storico specifico, ma immagino che qualunque lettore si figuri un momento compreso tra l’ottocento e la contemporaneità: ha ragione. Ci muoviamo infatti — è vero — tra “Gordon Pym”, la “Ballata del vecchio marinaio” e le “Montagne della follia”. La prora (di un veliero? Di un clipper? Di un battello a motore?) si schianta sulla costa di un’isola perduta nell’oceano, che immaginiamo isolata e vulcanica, a migliaia di miglia dalla costa più vicina: perché quell’isola è lì? È un’isola nota, per quanto remota, o mai scoperta da alcuno? Quindi, la rivelazione, nella quale consiste l’incubo: qualcuno, anzi forse Qualcuno ha abitato quel luogo, vi ha costruito un manufatto di dimensioni immani (la torre “svettava”). Forse questo qualcuno, questo Qualcuno è ancora lì. Il noi lirico / narrante è evidentemente tornato, vivo e forse anche salvo, ma verosimilmente cambiato: ora sa qualcosa, Qualcosa che nessun altro conosce, che nessuno dovrebbe sapere.
Porta pazienza ma ad un certo punto su questo blog arriviamo sempre a parlare di Tolkien: ma in XVI. Il cunicolo pare proprio di trovarsi di fronte ad un manipolo di nani (magari guidati da un hobbit) che devono sgusciare all’interno di una Montagna Solitaria per un tesoro custodito da un drago!
Una splendida lettura! Conta poco che l’occasione del sonetto sia stata un mio incubo claustrofobico, pedissequamente restituito nel corrispondente sonetto: è un’interpretazione, la tua, non solo legittima, ma molto bella.

Dai, raccontaci un po’ il tuo modo d’operare da autore, come nasce, per te, una poesia, come è la sua stesura, la sua pulizia, fino al momento in cui dici “ok va bene può andare”.
Limito il campo agli “Incubi”: la situazione standard è un sogno particolarmente vivido oppure una rêverie dalle peculiari potenzialità narrative e liriche: inizio provando a ritmare un paio di versi, ipotizzo qualche rima, arrivo a costruire una delle tre quartine o, magari (è la cosa più difficile!), il distico finale; penso: «Questa volta non ce la farò mai, è troppo difficile, lascio perdere». Il giorno dopo, da fresco, aggiungo un altro paio di versi. «Siamo quasi a metà!» penso con entusiasmo, ma poi di nuovo sopravviene lo sconforto: «Manca la seconda metà abbondante, la più difficile, perché ora spazi e quantità sono obbligati: ce la farò?» Ecco, ancora un verso, due, tre… il puzzle si sta completando. Mancano due, tre tessere al massimo. Ma i bordi non combaciano, devo forzarli perché vadano al loro posto, tutto sembra brutto e goffo. Poi, intuizione: ecco la parola che mancava! La incastro come l’ultima tessera del rompicapo, anzi come la chiave di volta dell’arco: tutto sembra reggere, l’incantesimo è compiuto! Siamo sicuri? Lo sapremo dopo un giorno o due: alcune costruzioni crollano nella notte, altre reggono ma, da meravigliose che sembravano, paiono insulse il giorno dopo. Una parte residuale regge, chissà come e chissà perché, sia alla statica che all’estetica: ecco un sonetto che merita di scampare alla distruzione, qualche ulteriore intervento (si cambia la collocazione di una parola, un segno di interpunzione) e si può inserire nella raccolta.
Nella cosiddetta Lettera del Veggente, Arthur Rimbaud scrive (con la sua prosa sempre un pochetto carica): “Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. (…) Poiché giunge all’ignoto! Avendo coltivato la sua anima, già ricca, più di ogni altro! Egli giunge all’ignoto, e anche se, sconvolto, dovesse finire per perdere l’intelligenza delle sue visioni, le avrebbe pur sempre viste! Crepi pure nel suo balzo attraverso le cose inaudite e innominabili: verranno altri orribili lavoratori; cominceranno dagli orizzonti su cui l’altro si è accasciato!“.
Possiamo perdonare a un poeta adolescente un po’ di verticalismo! Questo brano afferma qualcosa di grande e vero e cioè: chi non è veggente può comunque farsi tale e cogliere in qualche modo un germe di ignoto, un barlume di mistero.
Bene, abbiamo avuto una bella chiacchierata. Un’ultima cosa: quando hai iniziato la tua antologia di Incubi, ti eri posto un fine, uno scopo, la volontà di solleticare una idea o un sentimento? E pensi di avere raggiunto il tuo obiettivo?
Con i miei “Incubi” ho provato a ricreare una poesia, uno stile e un dettato mimetici dei modi della letteratura popolare, spontanea e ingenua nel senso di priva di sovrastruttura accademica: un’operazione difficile, sui cui esiti aspetto il responso dei miei lettori. Di mio, posso dire che sono moderatamente soddisfatto. E che mi sono molto divertito.
Ricordiamo come il libro di Andrea possa essere acquistato tramite questo form, oppure alla librerie Arethusa (via Giolitti 18, Torino) e Donostia (via Monginevro 85/A, Torino).
Due righe con: Miriam Cuatto
Questa volta abbiamo chiacchierato un poco di letteratura e d’intorni con Miriam Cuatto: ne è uscito un po’ di tutto.
Dunque, una medievista: partiamo da qui?
Medievista, o medievalista che dir si voglia, con un obiettivo preciso (e ora mi fregio di un titolo riservato a personaggi ben più illustri): essere apologeta di questa epoca, della sua arte, cultura e pensiero. Questa piccola crociata, per rimanere in tema, vuole parlare non tanto alle alte sfere accademiche che si spera abbiano superato i preconcetti sull’epoca ma al mondo, direi, popolare, sulla scia del principe indiscusso di questa disciplina, Alessandro Barbero. Non sarà la mia misera opera di studio artistico a cambiare le cose ma come si dice, sarà la mia goccia nell’oceano che non abbatterà, ma almeno spero scalfirà questo secolare pregiudizio. Ai detrattori, sia dell’arte che della storia, di quest’epoca, che la definiscono con l’orribile binomio di “epoca buia” amo rispondere: “Perché le altre epoche, in cosa sarebbero state più luminose? Non il medioevo europeo aveva la schiavitù, non il medioevo ha concepito le atrocità del Novecento; a ogni epoca è giusto dare le proprie luci e le proprie ombre.” Non controbattono, e quando accade la ritengo una piccola vittoria.
Ok, mi pare di capire che possiamo partire da qui: il romanzo storico d’ambientazione medievale, o almeno medievaleggiante, diciamo da Walter Scott in poi, e in ondate successive, è un genere con discreto successo e seguito (e diversa puntualità e qualità). Tu come “tecnica” che approccio riesci ad averne?
Partiamo dal dire che i miei libri preferiti sono romanzi storici d’ambientazione medievale, lì apprezzo molto, ma ci sono delle riserve. Il genere, inserito in quel grande fenomeno romantico di neo-medievalismi, ha contribuito alla riscoperta dell’epoca così come quei restauri in stile di dubbio gusto che intendevano dare un aspetto antico basandosi su come un edificio o un affresco poteva essere stato, senza basi scientifiche, creando indicibili pasticci iconografici e stilistici. La letteratura ha fatto un po’ questo, ha puntato i riflettori su un’epoca da sempre lasciata indietro ma per mantenere alta l’attenzione l’ha popolata di figure e concetti che sì esistevano, ma non in maniera così insistente. Un libro di questo tipo, e allo stesso modo un film, dovrebbe essere interpretato non come un saggio accademico, ma come spunto all’approfondimento personale sui temi, passando al vaglio critico le parole dei romanzi e le doverose licenze ma senza essere noiosi e bacchettoni sugli errori. Certo è che non serve inventare chissà che cosa o rifugiarsi negli stereotipi (lo ius primae noctis, mannaggia a voi) per rendere una storia sul medioevo interessante, bisogna solo fare lo sforzo di penetrarne l’essenza storica con i giusti mezzi e il romanzo è pronto.
Però adesso devi dirci i tuoi libri preferiti d’ambientazione medievale… Anzi, facciamo così: diccene uno (o più d’uno come preferisci) in quanto “medievale” (ovvero preferibile nel suo approccio al medioevo) e poi uno (o più) perché in fondo è comunque un romanzo bello, anche se scende a compromessi, diciamo.
Forse quello che amo di più è i pilastri della terra di Ken Follett, quello che proprio mi ha trascinata di violenza in quel mondo dal quale è difficile uscire, complice il fatto che parli della costruzione della cattedrale. Il primo amore però non si scorda mai: Notre Dame de Paris. Romanzi diversi scritti a secoli di distanza, in mezzo a questi l’ultimo membro della Trinità: il Nome della Rosa. Tutti perfetti e tutti con compromessi, il confine è labile. Aggiro dunque la domanda e ritorno a mordermi la coda da sola: ricostruire un’epoca è impossibile, d’altronde anche ricostruire perfettamente quello che è successo un’ora fa non è possibile. Sempre citando un discorso di Barbero sul fantastico e sul concetto di medioevo di qualche tempo fa (lo trovate appena qui sotto, NdInkiostri): c’è un medioevo reale e un medioevo immaginario fatto di streghe, roghi, oppressione, pestilenze nella mente di tutti, il fantasy a poco a poco erode questi concetti sbagliati portandoli in un altro mondo e lasciando alla storia ciò che davvero le appartiene.
Tirando le fila: i due generi sono complementari, dosando bene i due elementi e sapendoli distinguere nei libri che si legge ci aiuterà a conoscere meglio il vero e ad eradicare il falso.
Probabilmente tutti e tre i romanzi da te citati sono “fedelmente infedeli” al Medioevo (per motivi diversi, viene da dire), ma tutti e tre hanno il più genuino gusto del romanzesco. Secondo te perché il Medioevo “funziona”, a livello letterario?
A parer mio il medioevo funziona in letteratura, e di conseguenza nella cinematografia, per il fatto di essere nel substrato culturale di tutti noi che per quanto ci definiamo come discendenti del mondo classico siamo in realtà pienamente eredi del mondo medievale, almeno in Europa. Uno scenario medievale, o meglio pseudo medievale con elementi che rimandano sì alla realtà come alla funzione, e questo già accadeva nelle storie raccontate nel medioevo stesso, ci è familiare; questo vale sia per il panorama monumentale, soprattutto in Italia dove possediamo un enorme patrimonio artistico, ma anche per il panorama ideale con un retaggio folklorico comune che rimanda proprio a quell’epoca dove si sono generate le fiabe che ancora raccontiamo ai bambini, colme di prodi cavalieri, castelli e creature magiche. Come citato, durante il medioevo stesso già questo accadeva con le storie mitiche di re Artù e dei suoi cavalieri o nei racconti di Chrétien de Troyes dove su un ambiente familiare e comune a tutti si innestavano elementi fantastici; non siamo tanto diversi da loro alla fine, se ci sentiamo ancora dopo secoli a nostro agio con le storie di maghi e cavalieri.
A posteriori pare essere un qualcosa di scontato, acquisito, e quasi naturale, ma non è banale, a pensarci, che una parte cospicua della letteratura fantastica, ovvero il fantasy, abbia una estetica (ma anche in fondo una struttura mentale e sociale) medievaleggiante.
Il fantasy non è altro che una continuazione di quello strato culturale e folklorico che citavo, ci porta in un mondo altro, perduto nel tempo e nello spazio e questo forse potevano pensare i primi autori di romanzi storici. È allo stesso tempo un mondo dai toni epici e drammatici, poi strazianti e incredibilmente romantici e dolci, esattamente il mondo letterario archetipico del fantasy classico. Non saprei bene spiegare il confine o il salto tra i due ma a modo suo il fantasy contribuisce all’interessamento nei confronti del medioevo anche se spesso quando si scopre un’epoca sì grande, luminosa e acculturata, ma senza tutti quegli elementi, quasi accusatori, che gli attribuiamo, si rischia di restare delusi. Il medioevo, personificandola, è un’epoca curiosa che con i mezzi a disposizione osserva, analizza e cerca di classificare il mondo attorno a sé, che esso sia affine o nemico della propria cultura. Alle corti francesi del basso medioevo sapevano benissimo che non esistevano i draghi, che re Artù era una finzione e che i cavalieri non erano senza macchia, non navigavano certo nella superstizione come siamo abituati a credere (noi che crediamo all’oroscopo e a cose ben peggiori) eppure le storie si sprecavano su questi temi. Si può dire che il fantasy deriva dal medioevo (che a sua volta guarda all’antico) e dalla sua voglia di conoscere; più tardi non si può delineare un confine preciso ma sappiamo che dalla riscoperta del medioevo nascerà il fantastico proprio partendo da questo e portando a quella commistione di generi che ancora oggi fa tanto scrivere.
Per te la curiosità per il medioevo deriva dal fantasy, oppure è stato viceversa, oppure qualcosa di più sfumato e indiretto?
Mia madre sostiene in continuazione che io sia stata scambiata nella culla dal momento che possiedo questa spiccata curiosità per un tema così datato e polveroso agli occhi dei più; in effetti fin da piccola, io, volevo sapere. Penso che per me, ma come per molti, l’interesse sia partito dal fantastico, un genere ben più accessibile, per poi essere traghettato, complice forse la onnipresente ombra della Sacra e l’avanzamento degli studi a scuola, verso la passione per quest’epoca e per la sua cultura, in parte epurata dal manto fantastico. Questo non elimina la mia passione letteraria per i romanzi storici così come i fantastici, anzi diventa quasi un gioco confrontarsi con le opere di questi generi.
Anche questo sarebbe nel solco della tradizione folklorica europea: secondo tua madre saresti un changeling!
Questo ad ulteriore riprova che quel mondo ci appartiene, e appartiene inconsciamente anche a chi di storia conosce poco e niente. Lì sono le nostre radici, le radici della nostra letteratura, in quel mondo tra il reale e il fantastico che vediamo distantissimo ma che in realtà è del tutto simile a noi, che ci ostiniamo a rinnegare e condannare fino all’ossessione, forse perché ci spaventa quanto quel mondo e quelle persone siano così contemporanee nel loro essere così “medievali” nella migliore accezione possibile del termine.

In fondo questa visione del mondo in cui il fantastico (chiamiamolo così, per semplificare) è escluso è un fatto piuttosto recente. Si potrebbe dire che la letteratura realista sia una semplice corrente (meglio, una eresia) del solco ordinario della letteratura d’ogni cultura: una corrente in cui, diversamente dal solito, il fantastico è escluso.
È un ragionamento giustissimo, dal momento che anche nelle “letterature ufficiali” medievali non mancava mai l’accenno al fantastico e al meraviglioso, anche di matrice divina (si pensi alle agiografie dei santi, alle mitiche fondazioni delle abbazie e alle gesta di re e imperatori). Eppure quella era la letteratura e lo è stata per millenni, a partire dal mondo antico greco, egizio o indiano. Il fantastico poi pare essere stato relegato per un certo periodo alla letteratura per ragazzi o bambini, come se non fosse un tipo abbastanza degno mentre guardando al passato è sempre stato presente, solo con un altro nome, senza una inquadratura precisa di genere. Non saprei darne una spiegazione puntuale, forse il progresso veloce delle scienze ha contribuito a questo.
Jorge Luis Borges affermava, con bonario disincanto sornione, che in fondo la teologia è una branca della letteratura fantastica.
Se per fantastica si intende, a maglie molto larghe, tutto ciò che va oltre il mondo umano e terreno, perché no! D’altronde anche il fantastico ci fa avere fiducia nei nostri eroi che dopo mille peripezie sconfiggeranno il cattivo, ci fa riflettere, pensare, sognare, disperare a volte, guardare al cielo in attesa di un intervento che sta più in alto dell’eroe, nella speranza che tutto questo conduca, prima o poi, a un lieto fine.
È l’eucatastrofe tolkieniana.
È proprio lei. Vengo, qualche settimana fa, da una maratona del signore degli anelli qui in cappella universitaria; con l’aiuto di Daniele abbiamo riflettuto proprio sulle letture teologiche dell’opera di Tolkien, l’eroe umile che ribalta i potenti dai troni, il re, il profeta, il maligno che corrompe. L’intervento per quanto breve ha avuto successo, segno che si parla una lingua comune a tutti.
È questo secondo te il motivo per cui Tolkien è universale?
Tolkien era un grande conoscitore del folklore e della mitologia, come allo stesso tempo lo era del medioevo e seppur nella sua opera abbia ribaltato un po’ il concetto dell’eroe bello, aitante e coraggioso, credo che sì: parli una lingua di tutti e per tutti. Più che parlare a tutti credo parli all’animo più recondito di tutti e che tutti abbiamo in comune come retaggio culturale, laddove si nasconde il bambino che crede alle fiabe, che vuole sconfiggere il drago e salvare la principessa. Tolkien ci dice: guarda, quell’eroe puoi essere tu, nella tua umanità e nella tua imperfezione, scrivi la tua fiaba.
Una celebre espressione di G.K. Chesterton dice (supperggiù: chestertonianamente citiamo a memoria): le fiabe non solo insegnano ai bambini che esistono i draghi: ma che si possono anche battere.
Sono dell’idea che le fiabe insegnino anche ai grandi, se lette nella giusta chiave senza fermarsi al cavaliere che salva la principessa. Chesterton aveva ragione (e chi sarei d’altronde io per dargli torto) ad assumere che la fiabe insegnino non come sconfiggere i draghi ma che è possibile farlo; qualunque sia il drago, dalla verifica di matematica del giorno dopo a problemi ben più gravi, c’è un modo per passare oltre e fin da piccoli è bene impararlo. Certo è che le fiabe insegnano che l’eroe ha bisogno di un aiutante, sia esso un amico, un parente o qualcuno di “più in alto”, di un oggetto magico per superare le difficili prove che il cattivo di turno gli parerà contro, nessuno si salva da solo!
Abbiamo tutti bisogno di essere Frodo e Chisciotte, e di essere i Sam ed i Sancho Panza di qualcuno. Bene, ci avviamo alla conclusione! Ultima domanda: cosa stai leggendo in questo momento?
Come degna conclusione, sto leggendo il bestiario medievale di Pastoreau, un ricettacolo di tutti i testi di questo genere, forse uno di quelli apicali nel campo tra fantasia medievale e storia. Qui si susseguono magnifiche miniature di animali esotici, reali o fantasmagorici, con la relativa spiegazione zoologica (un po’ azzardato come termine per l’epoca, ma efficace) e teologica di tutti gli animali. È un saggio ma estremamente accessibile e godibile, lo consiglio vivamente a tutti, per entrare nel vivo dell’epoca medievale e delle sue credenze, e anche per farsi due risate a guardare come li rappresentavano in maniera buffa!
Anoressia, di Davide Gorga
Davide Gorga ci regala un altro racconto: lo potete leggere di seguito, oppure scaricarlo da qui, oppure ancora più sotto. Buona lettura!
Iniziò a piovere lentamente, come in un accordo triste; le gocce scurivano il bordo dei marciapiedi, velavano la strada, piangevano dalle foglie scure degli alberi, intrecciavano il canto infuocato dell’alba con i tramonti dell’inverno, oscurando il sole sorgente in una nuvolaglia viola sul mare, indaco fino all’orizzonte lontano.
Gli edifici sfrecciavano veloci nell’aria fresca, sulle colline, sino alle alture da cui le montagne parevano potersi toccare con mano. E poi, sull’infinito nastro grigio dell’autostrada, il ragazzo e l’ombra blu che cavalcava furono un tutt’uno, trascinati via contro il vento della corsa.
«Come stai?»
«Secondo te?»
«Coraggio! Esci, godi dell’aria pura, il mondo non è poi così male!»
«Sì, lo so.»
«Serena, posso fare qualcosa per te?»
«Scusa Dario, non ho voglia di parlare.»
Lo scatto secco del telefono aveva chiuso ogni possibilità di riprendere il leggero legame che si era instaurato. Non avrebbe risposto di nuovo, questo il ragazzo lo sapeva. Si portò sul terrazzo; le stelle erano velate da una fitta coltre di pennellate violette, mentre all’occidente l’oscurità sembrava una belva acquattata, compatta, spessa, nera. Era il preannuncio di una tempesta. Serena non sarebbe uscita dalla sua stanza, non prima di aver consumato ogni briciolo di energia nel suo corpo, di aver estirpato la vita fisica e materiale, disseccata la fonte illusoria, estratto il coltello che le avvelenava l’anima. Non era la prima volta – ma ognuna di esse la avvicinava a quella che sarebbe potuta essere l’ultima.
Mentre le curve rompevano il ritmo veloce e il motore riprendeva il canto allegro e regolare nel vento, il ragazzo si lasciava trapassare dalle voci del presente e del passato – e da quelle del mondo, incantate, fiere, forti e sincere come i tronchi degli alberi che scurivano le cime.
Nero e bianco, bianco e oro, il casco rispose a un timido bagliore stilettante tra le nubi, come una speranza iridata che ancora non si era compiuta. Il vascello accelerò ancora. La luce non si alzò, e la pioggia iniziò a frustare inclemente la strada, le mani e la carena.
Neve bianca e d’argento risplendeva ai lati della piazzola in cui il ragazzo si fermò a indossare la tuta impermeabile, sottile e robusta. Viaggiava leggero. Come un desiderio inciso nel metallo incandescente.
In breve le nuvole scomparvero, sostituite da una semioscurità violacea e venata di malinconia. Dario le osservava in piedi, il volto deciso, addensarsi in massa dinanzi a lui, affianco alla sua motocicletta blu notte, al bordo di una piazzola tra il bianco ormai invisibile della tarda mattina. Trasse un sospiro, e ripartì.
Presto la pioggia si rovesciò in torrenti sulla carreggiata; muri d’acqua ghiacciata si levavano improvvisi e, passati come a guado, investivano il guidatore sino alla cintura. Infine il sole del primo pomeriggio fece capolino tra le nubi, quasi il maltempo avesse rallentato durante la corsa attraverso la pianura, ed illuminò come un gioiello Vicenza, le sue borgate e i suoi boschi sparsi. Dario guidò sicuro sino ad una chiesa al centro di un paesello, piccolo, angusto, dall’aspetto medievale. Si tolse gli abiti da viaggio e si asciugò alla meno peggio, avviandosi poi a passo svelto verso l’abitazione di Serena.
Lontana da occhi indiscreti, quasi cercasse di nascondersi a sguardi troppo insistenti, la casa ad un piano era circondata da bassi alberi, tra i quali un esile cancello dava acceso ad un passaggio lastricato. Il ragazzo suonò, ed una voce gracchiante rispose. Era la madre della ragazza. Dovette dare parecchie risposte sul perché si trovasse lì, che cosa volesse, che cosa cercasse; non gli fu aperto. Suonò di nuovo:
«Serena non vuol vedere nessuno! Neanche me! Si è chiusa in camera!»
«Va bene. Mi faccia solo provare. Se non mi vuole vedere me ne andrò, la prego.»
Infine il cancello non troppo amichevole si aprì ed il ragazzo percorse le pietre d’ardesia tra il prato di un verde abbagliante sino alla la porta di casa. Senza troppi complimenti, fu fatto entrare. Conosceva la strada.
«Sono giorni che non mangia.» esclamò la madre a mo’ di congedo. Dario non mosse un muscolo. Quando la donna si fu allontanata, bussò alla porta di legno castano.
«Chi è?» domandò una voce familiare.
«Sono io, Dario».
Il rumore della serratura che scattò secco fu uno dei momenti più importanti della vita del ragazzo. In confronto ai pericoli, alle gioie, ai dolori che aveva affrontato, rappresentava la speranza. La vita.
Entrò nella stanza illuminata solo dal chiarore del meriggio che entrava a fiotti dalle finestre prive di tende; oltre i vetri, una tuia cresceva solitaria inondata dalla luce del giorno. Sul letto al fianco della parete, jeans, un maglione blu, una cascata di capelli corvini – ed un volto affondato nel cuscino.
«Ciao, mi avevi fatto preoccupare», esordì Dario; «che ne dici di farmi almeno usare il bagno? Sono stanco e ho bisogno di darmi una rinfrescata!»
Serena, finalmente, si voltò. Era pallida come neve, emaciata, gli occhi spenti che covavano una scintilla di collera verso il mondo, inespressa, velata, come un pugnale. Si levò a sedere e si alzò, quindi gli fece strada.
Dario chiuse la porta dietro di sé. Si accasciò al suolo e contò fino a dieci. “Trova la forza, accada quel che accada, ma trova la forza!” – lontano, nei ricordi confusi, un leone alato lo fissava ad occhi chiusi. Uscì dopo qualche minuto, un lieve sorriso e l’aria seria e leggera: «Hai da fare oggi?»
«Non devo fare più nulla. Assolutamente nulla. Perché sei qui?»
«Avevo voglia di fare un giro, e poi nell’ultima lettera mi avevi promesso che mi avresti fatto conoscere la città. Allora, usciamo?»
Serena lo guardò interrogativa, il fuoco nello sguardo sembrò mutarsi leggermente, come se una sfumatura di allegria – leggera e labile – si fosse insinuata nella melodia funebre che la incatenava.
Il paese era grigio e rosa, e verde e odoroso di fumo di legna e umidità e prati lontani e nuvole d’autunno nel cielo che si scuriva. E le parole cantavano come un controcanto e una melodia, una voce e una chitarra che danzassero intorno al fuoco. Lontano, la chiesa sorrideva.
E giunse il tramonto, come una benedizione insperata nella pioggia di foglie che le ventate frequenti portavano lungo i viali deserti e colmi d’essenze fragranti. E risa e sguardi e voci calde come un riparo in una notte d’inverno.
«Mi porti a mangiare qualcosa? Stamattina sono partito presto!» esclamò Dario.
«Se vuoi c’è un ristorante, qui vicino.» rispose esitante Serena.
«Perfetto! Andiamo!»
Al tavolo bianco nella sera sempre più scura, i due sedevano l’uno di fronte all’altra. Il cameriere tornò abbastanza in fretta dopo averli lasciati scegliere la cena.
«Per me una pizza “inverno”. Direi che è adatta alla stagione! O quasi! Ah, e per te, Serena? Un’altra “Inverno”, d’accordo? O preferisci una “margherita”?»
«Una “margherita”, grazie.» mormorò decisa Serena.
La cena fu condita dai racconti del ragazzo, dalle sue letture, le fiabe, gli amici, le sere sempre più vicine, e terminò in un attimo.
Al termine, la ragazza aveva lasciato un pezzetto di cibo nel piatto; «Lo mangi?» chiese Dario, ed al diniego, allora, chiamò il cameriere e ordinò due gelati; «Ti va, vero? Fragola?»
«Vaniglia, grazie.» rispose l’altra, il viso severo su cui traspariva un lieve sorriso.
Scese la notte. La piazza della chiesa era deserta. I ragazzi si avvicinarono alla motocicletta; Serena era rossa in viso ed emozionata. Si salutarono. Un bacio sognato sospirò nell’aria scura.
Presto l’autostrada accolse il ragazzo e il vento lo inghiottì. Lampi neri nella notte. – le ciglia del leone si sollevarono lente, splendendo alte nel cielo scuro; ali di luce sventagliarono nell’oscurità.
Le luci arancio dell’area di servizio lo accolsero in un’atmosfera irreale; il mondo non fuggiva più intorno a lui ma, nell’anima, una cascata si era risvegliata e ruggiva possente.
Mentre si apprestava a fare rifornimento, un ragazzo muscoloso gli si avvicinò, guardandolo dall’alto in basso;
«Senti, io devo tornare a Roma, ho finito i soldi. Non è che puoi darmi qualcosa?»
Dario sospirò, estrasse il portafoglio e gli allungò una banconota di piccolo taglio. L’altro insistette:
«Ehi, tutto qui!? Guarda che io devo tornare a Roma, hai capito? Che ci faccio con questa merda?»
«Mi spiace, il resto mi serve per tornare a casa. E vai a sacramentare da un’altra parte.»
L’altro gli si avventò contro: «Chi ti credi di essere? Molla quei soldi!»
Un calcio laterale svelto come un fulmine lo colpì in piena pancia prima che potesse rendersene conto. Indietreggiò di alcuni metri, barcollò e cadde. Quando si rialzò, tenendosi una mano sul ventre, era furibondo, ma non riusciva a reggersi in piedi. «Questa la paghi!» esclamò.
Dario si mise in guardia, una gamba avanti, l’altra dietro. Non disse nulla. Ora anche i suoi occhi ruggivano.
Presto una ragazzina tatuata si avvicinò all’altro, lo sostenne e lo trascinò via.
Dario terminò il rifornimento con cautela, quindi ripartì, solo, nell’oscurità.
A notte fonda, giunse a casa, buttò le chiavi della moto su un comodino, e si gettò sul letto.
Passarono i mesi. Al telefono, la voce di Serena era viva e cantante come un albero che rifiorisca al sole. E le sue lettere erano incastonate di amici, di passeggiate nella luce, di vita.
Si rividero dopo poco; il tempo sembrava volato, e Serena fu una guida eccellente per le meraviglie artistiche di Venezia. – La criniera del leone luccicava al vento. Risa di bambini, canti di chitarre, echi del futuro, leggende del passato in una pioggia di foglie verdi che carezzavano il mare; vele, navi ed infiniti sguardi e lame d’argento che trapassavano lo spirito. Si alzavano rinascenti le fiamme del sole sull’acqua, le corde squillanti nel cielo terso incantavano la città fresca e tersa come un cielo d’inverno precipitato nella promessa di fioritura; maggesi lucenti di pietra e muraglie di marmi azzurrati nell’abbraccio dell’orizzonte. Una danza gentile viveva intorno a loro, prendendoli delicatamente per mano. – La musica iniziava il viaggio senza sentiero oltre i confini della terra. Palazzi di sogno sull’acqua, cembali e saltimbanchi nella visione d’ebano armonico sotto un canto d’angeli possenti in esili petali di cristallo.
Giunse la primavera.
Non c’era più traccia di neve sporca e pioggia inclemente sull’animo di Serena, solo il candore era rimasto intatto. Dario decise d’incontrarla di nuovo. Ora la ragazza sapeva riconoscere le meraviglie dentro di sé, e, mentre camminavano lungo i viali e si fermavano a pranzare nel solito ristorante, il ragazzo le chiese:
«Sicura di non dovermi dire altro?»
L’altra arrossì: «Che cosa?»
«Niente. Meglio così. Allora, ascolta.» – ed in un incantevole giorno in cui i mandorli erano in piena fioritura, le confidò il suo amore.
Serena trasalì; «Dario, non puoi parlare sul serio.»
«Perché?»
«Perché per me sei un amico… »
«D’accordo, non preoccuparti. Lo sapevo da quando ho visto la foto sulla tua scrivania. Dimmi almeno come si chiama.»
Serena era ammutolita.
«Ha importanza!?» chiese d’impeto la ragazza.
«In verità, no.»
Il silenzio frusciava come un sussurro gentile.
«Ascolta, io rimarrò tuo amico per sempre. E se avrai bisogno di me, ci sarò. D’accordo?»
Serena accennò di sì con la testa. Dura, decisa, inflessibile. Eppure, forte e dolce insieme.
Il sole calava lento oltre il capo del golfo; Dario, le mani appoggiate alla ringhiera, gli occhiali da sole nonostante l’ora tarda, lo osservava immergersi nel buio e lasciare spazio ad una notte limpida.
Una giovane esile, castana, camminava canterellando lungo il marciapiede della strada del mare, e lo salutò con un cenno della mano. Il suo sorriso sembrava un’alba nascente contro il tramonto.
La musica della notte crebbe. I ragazzi parlavano ancora, soli, nel suono della risacca.
«Allora, un altro due di picche, non è vero!? Mi dispiace!»
«Due di picche?» rise l’altro di rimando, una di quelle rare risate lucenti come il sole; «Dopo tanti anni non mi conosci ancora, Chiara?»
L’altra sgranò gli occhi.
«Va bene, ascolta.» ora pareva la voce di un vecchio a parlare, bassa e grave, dimentica della spensieratezza di poco prima; «Serena aveva bisogno di qualcuno che l’amasse, di qualcuno che le parlasse il linguaggio dell’anima. All’inizio era solo un’amica, poi divenne la mia missione. Era quello che ero chiamato a fare. Non c’era nessun altro che lo potesse fare, lo capisci?»
Chiara fece cenno di no: «No, non lo capisco. Sei strano. Come sempre del resto. Di certo normale non lo sei mai stato.»
Il ragazzo guardò il viso accigliato ed accennò un sorriso: «Questa te la perdono giusto perché sei tu!», riprese, nuovamente giovane come un bambino; quindi proseguì: «Comunque sia, quando un fuoco è prossimo a spegnersi, ha bisogno di legna. Così, un’anima ha bisogno di amore. E una ragazza di sapere che può piacere come qualsiasi altra.»
«Almeno lui com’è?» riprese l’altra, con tono per nulla convinto.
«Non so, sembra il solito laureatino saccente, ma l’ho visto solo in fotografia.» rispose distratto il ragazzo.
«Insomma un bastardo. E che accadrà quando tra i due piccioncini finirà?»
«Serena soffrirà un po’, piangerà, ma avrà la forza e la certezza di valere. Una volta acquisita, non è qualcosa che perdi per strada. È questo l’importante, non capisci?»
Chiara rimase un attimo interdetta. Sospirò forte. Appoggiò entrambe le mani sulla ringhiera, e il mento su di esse. Quindi concluse con una vena di stizza: «Per cui, in definitiva, per tutti questi sette anni sei sempre stato innamorato di quella piccola stronza di Emanuela!?»
«Non chiamarla così!» protestò debolmente il ragazzo; «Non è come appare.»
«Hai ragione. È peggio! Ma con te è inutile discuterne.»
«Non capisci…» protestò il ragazzo, mentre l’altra osservava l’orizzonte;
«Capisco fin troppo…» poi, Chiara s’interruppe e guardò l’amico con occhi lucenti: «Dario, sei un adorabile matto da legare!» esclamò infine, rifilandogli una sonora pacca sulla schiena. Il suo riso fu oro nel più profondo cielo.
Lontano, un fiore d’argento guardava la Luna. Serena sentiva germogliare l’amore dentro sé, e, per una volta, era convinta di potercela fare. Perché sì, il mondo poteva essere alieno e difficile, ma in ogni caso, lei non sarebbe stata più sola.
Mai più.
Due righe con: Patrizio Righero
Non sappiamo voi, ma per molti di noi poche cose sono più gradevoli di fermarsi un momento a parlare di libri. Abbiamo pensato così di fare due chiacchierate, un po’ per presentarci, un po’ per dare qualche spunto di lettura, magari. Iniziamo con uno dei fondatori, Patrizio Righero.
Patrizio, credo tu possa sentirti lusingato di essere nella versione alpha di queste interviste. Iniziamo canonicamente (se di canone si può parlare): se dovessi dare una idea di te tramite un personaggio letterario, chi sceglieresti?
Molto lusingato! Dunque: chi vorrei essere non corrisponde a chi verosimilmente potrei essere, ovviamente. Lo starec Zosima dei Fratelli Karamazov è un personaggio gigantesco nel quale vorrei potermi rispecchiare. Ma l’immagine che mi torna indietro è piuttosto quella del pellegrino russo, oppure, in altri momenti, quella di Gabriel Syme, “L’uomo che fu Giovedì” scaturito dalla penna di quel genio di G.K. Chesterton. Ma alla fine, scendendo dal pero, mi vedo come un Renzo Tramaglino qualsiasi. O forse don Abbondio? Meglio fermarsi qui!
Se qualcuno dovesse fare un complesso grafico in tre dimensioni della letteratura per posizionarne i grandi autori, con qualche improbabile criterio di coordinate, credo che ai tre estremi potrebbe posizionare proprio Dostoevskij, Chesterton e Manzoni.
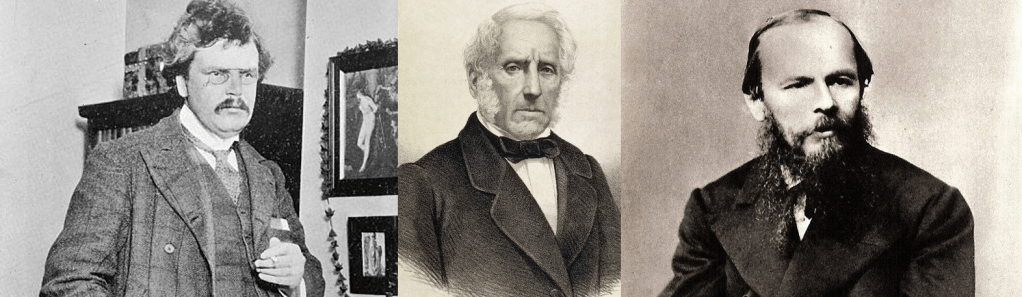
Un’eccellente triangolazione europea. Uscendo poi in mare aperto ci si imbatterebbe certamente in Melville e in Poe, navigando verso Ovest. Ad est Cao Xueqin potrebbe costituire una spiazzante e impegnativa sorpresa.
Insomma, mi pare di capire: i classici. Delle tante definizioni di “classico” che sono state date, quale preferisci? Va bene anche se ne hai una tua.
La mia è una definizione necrologica: un autore per essere definito classico deve innanzitutto essere morto da almeno una ventina d’anni. In modo che svaporino le sponsorizzazioni ideologiche. Se del suo successo letterario resta qualcosa di buono, se i lettori continuano a sfogliarlo imperterriti e a trarne innanzi tutto un certo godimento, beh allora forse ci siamo.
Niente instant classic, quindi, per te: eppure molti autori, come Dante (almeno a quanto ci fa capire Boccaccio), o Hugo, o Tolstoj, o Dickens (ok Dickens forse un po’ meno, ma è perché vogliamo molto bene a Dickens) sono stati subito inquadrati in quel campionato lì. Altri invece lo sono diventati nel tempo, in fondo. Che ne pensi?
Certo, il classico di razza lo è anche per i suoi contemporanei, ma loro non sono autorizzati a dirlo. Provo a fare un esempio dei giorni nostri: possiamo dire che Stephen King sia già un autore classico? Forse sì, ma tra cent’anni lo leggeranno ancora? Diamogli tempo…
Dai, dimmi tre autori contemporanei o quasi che secondo te potrebbero essere classici tra un secolo. Puoi farti guidare sia dal cuore che dal cervello.
La risposta non può che essere soggettiva e arbitraria, condizionata anche dalle mie letture (come hai già capito prediligo i defunti). A quello già citato aggiungerei il francese Dominique Lapierre (scomparso nel 2022, quindi teniamolo buono come contemporaneo). E mi si passi anche Ray Bradbury (1920-2012). Italiani viventi che possano lasciare il segno fatico a trovarne. Quindi, in buona sostanza, ho glissato la domanda!
Annotiamo l’ammissione di colpa. Hai citato Bradbury: parliamo un po’ di fantascienza.
Sfondi una porta aperta! Purtroppo ancora oggi è considerata un genere di nicchia, tenuta colpevolmente fuori dai salotti della grande letteratura. Autori del calibro di Asimov o Stanisław Lem hanno segnato la cultura del 900 e continuano a influenzare quella contemporanea. Basti pensare alle grandi produzioni cinematografiche. Solaris è un capolavoro assoluto.
Ed anche tu ti sei dilettato nel genere, vero (piccolo spazio pubblicità)?
Un sottogenere direi: quello del drabble (racconto di 100 parole) che ho applicato alla fantascienza. Da subito l’ho trovato particolarmente stimolante e ne è venuta fuori una raccolta di 100 racconti con lo scanzonato titolo “Gli ultimi giorni del mondo”. Nello stesso libro ho aggiunto anche alcuni racconti più estesi. Complessivamente un viaggio dalla Genesi all’Apocalisse, sui ritmi della Commedia dantesca. Alcuni lettori, se la loro confidenza è stata sincera, lo hanno perfino trovato gradevole.

Cosa ne pensi della divisione in “generi” che spesso si adopera in letteratura?
Necessaria per uno studio critico. Indubbiamente. Sta poi agli autori (quelli bravi) mettere alla prova gli accademici, mescolando le carte e contaminando i generi.
In proposito di generi letterari, un’altra delle tue opere riguarda Maria di Nazareth: cosa ne pensi del rapporto tra letteratura e Bibbia (che è parte delle letteratura, ovviamente, ma anche altro) e più in generale, tra letteratura e religione?
La Parola genera le parole. Nel contesto della cultura ebraica, cristiana e anche laica, la Bibbia, nel corso dei secoli, ha innescato processi letterari e artistici la cui grandezza è sotto gli occhi di tutti. Il mondo ebraico, in modo particolare, ha sviluppato il Midrash Aggadah, cioè il commento narrativo al testo biblico. Si tratta di un approccio sostanzialmente religioso e spirituale. Oggi si parla di “riscritture”, con le quali si cimentano volentieri i non credenti, talvolta con risultati illuminanti anche per chi ha fatto della Parola un punto di riferimento per la propria vita. Altro discorso va fatto per il rapporto tra letteratura e religione: sono due mondi che si intersecano continuamente. Alcuni titoli possono offrire la cifra della grande varietà che questo incontro può generare: andiamo da “Il Signore degli Anelli” di Tolkien, laddove il sacro non è mai esplicito ma permea ogni pagina dell’opera, a “Le cronache di Narnia” di Lewis, articolate sul simbolismo cristiano. E che dire di Fëdor Dostoevskij?
Personalmente credo che ogni grande opera letteraria, indipendentemente dall’oggetto che tratta, lasci trasparire le forme del sacro e della trascendenza.
La vera arte è sempre sacra, quindi: non per questo rimane necessariamente nelle chiese e nei templi.
Vale per ogni autentica espressione dell’umano. San Giustino parlava di “logoi spermatikoi”, cioè quei semi della Verità divina (Logos) che sono stati disseminati da Dio nel mondo e nella storia. Resta talvolta la difficoltà da parte dei cristiani di individuare e coltivare questi semi, in una prospettiva di condivisione del Vangelo. Dall’altra parte si rileva una (questa sì, ben coltivata) allergia a tutto ciò che odora di incenso: e in molti finiscono per rifiutare in modo acritico la ricchezza contenuta nell’arte e nella letteratura sacra solo perché espressione di una confessione religiosa. Ma qui stiamo uscendo dal campo strettamente letterario.
In proposito di “campo” (gran gancio, questo), vorresti concludere con un gioco? So che sei tifoso granata, ci daresti il tuo ideale undici letterario?
Colgo la palla al balzo! Premetto che il Torino e la sua storia sono già di per sé poesia, epica, tragedia e leggenda. Lo testimonia il fatto che, almeno in Italia, è la squadra di calcio sulla quale sono stati scritti più libri.
Per quanto riguarda l’11 titolare istintivamente tra i pali metterei Omero, ma quanto si dice circa la sua capacità visiva precipiterebbe nell’incertezza tutta la retroguardia. Motivo per cui lo lascerei sugli spalti, con il prestigioso ruolo di presidente onorario del club. Tra i pali vedrei bene Giovanni Pascoli, forse non sarà un mago sulle prese alte, ma certamente è uno abituato alla solitudine con la quale sono spesso chiamati a convivere i numeri uno. Terzino sinistro (in un classico 4-4-2) Tolstoj. Con lui è difficile spuntarla. Sulla destra: Giovannino Guareschi. Una certezza granitica che non molla mai. Centrali due giganti: Dante e Manzoni. Corsia sinistra Richard Bach, corsia destra Antoine de Saint-Exupéry: due che di ali se ne intendono. Fantasisti dietro le punte: Tolkien e Lewis. Giocano a memoria e sono capaci di trovate geniali. A buttarla dentro ci penseranno William Shakespeare e Dostoevskij: due fuoriclasse assoluti.
Una bella formazione. Un ultimo suggerimento, visto che se n’è accennato: ci vuoi consigliare qualche libro che accosti il calcio (o lo sport in generale) alla letteratura?
Chi pratica sport raramente è un lettore forte, e i lettori forti raramente amano le grandi sudate. Ma sui libri queste due tipologie umane posso miracolosamente incontrarsi. Altro discorso va fatto per i tifosi, vale a dire gli “sportivi non praticanti”. Questi pare che leggano volentieri (i giornali sportivi, ma non solo). A tutti – sportivi, lettori e tifosi – suggerisco due titoli: “Il romanzo del Grande Torino” di Franco Ossola e, di tutt’altro genere, ma altrettanto godibile, “La Compagnia dei Celestini” di Stefano Benni. Buona lettura.
Una borsa di studio universitaria su Tolkien, in Piemonte (e ci siamo un po’ di mezzo noi)
Se state leggendo questo blog probabilmente saprete (e se non lo sapete, ve ne sarete accorti; e se non ve ne siete accorti, ve lo confidiamo qui ed ora) come JRR Tolkien sia un po’ un babbo spirituale, per noi. C’è capitato di potere un po’ ispirare una possibilità, e questi sono risultati (l’articolo è serio e protocollare, ogni tanto è bene).
In occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte di J.R.R. Tolkien, il Consiglio regionale del Piemonte ha voluto bandire un concorso che premia le due migliori tesi di laurea (triennale o magistrale) o di dottorato, redatte in un ateneo piemontese negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024.
Durante una conferenza stampa di presentazione delle nuove iniziative del Consiglio per gli studenti, tenutasi nei giorni scorsi, il consigliere Silvio Magliano (Moderati), promotore dell’iniziativa, ha voluto ringraziare il professor Giuseppe Pezzini (Fellow e Tutor, Università di Oxford), che presiederà il comitato scientifico, e il gruppo terrario degli Inkiostri «la cui originaria intuizione e proposta, da me immediatamente accolta con entusiasmo, si è ora concretizzata in questa borsa di studio universitaria, finalizzata a premiare le due migliori tesi di laurea (triennale, magistrale o di dottorato) dedicate al grande autore».
Sull’importanza e l’attualità dell’opera tolkieniana Pezzini spiega: «Con più di 250 milioni di copie vendute, il Signore degli Anelli è il terzo libro più letto nella storia umana, molto amato da una varietà di lettori di ogni nazionalità, credo e cultura. Paradossalmente, questa popolarità è stata a lungo un problema per la sua ricezione in ambito accademico, insieme ad un vago pregiudizio al genere fantasy (con cui in realtà Tolkien ha poco a che fare). Per fortuna queste resistenze sono cadute negli ultimi due decenni, soprattutto nel mondo anglosassone, e Tolkien è entrato a pieno diritto nel canone della letteratura, e la sua opera è oggetto di corsi e ricerche. L’Italia è ancora un po’ indietro su questa strada, anche a causa di diatribe politiche molto provinciali e poco adeguate ad uno scrittore che, come tutti i grandi autori, non si può ridurre facilmente ad etichette o ideologie. Oltre la potenza estetica e narrativa, il merito dell’opera di Tolkien infatti consiste innanzitutto nel riuscire ad armonizzare posizioni contrastanti – mettere insieme popoli diversi in un cammino comune. Una lezione importante in questo contesto storico così travagliato».
Il concetto è esplicitato dal Bando stesso che specifica: «La tesi deve essere dedicata allo studio dell’opera di Tolkien, con una particolare attenzione al tema della pace tra i diversi popoli del mondo tolkieniano».
Ai primi due elaborati giudicati vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 1°premio: € 1.500,00 e diploma di attestazione; 2°premio: € 1.000,00 e diploma di attestazione.
Il bando è scaricabile a QUESTO link.
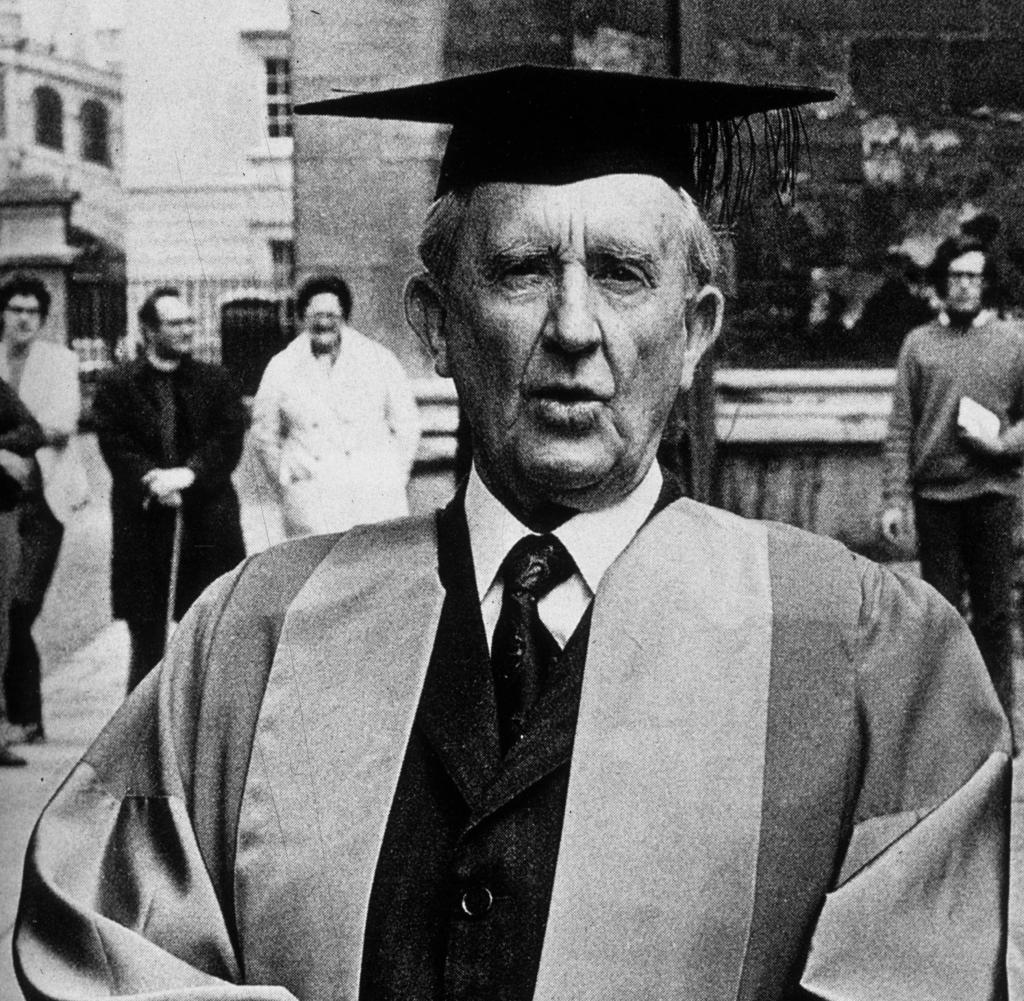
La musica di Wagner, Lewis, e la ricerca della gioia
Il nostro Gabriele Petouchoff mette assieme, in questo articolo, alcune cose che ci piacciono, e che fanno bene allo spirito, se avete finito le vacanze, e che vi ci prepareranno al meglio, se le inizierete a breve.

Richard Wagner segnò indelebilmente la storia della musica.
La sua idea di melodramma come opera d’arte totale che racchiudesse in sé musica, poesia, drammaturgia, coreutica e arti visive cambiò il modo di concepire e rappresentare le opere liriche, modificò le strutture fisiche dei teatri, anticipò il cinema. Soprattutto raccolse i sogni e le inquietudini dell’uomo tardo-ottocentesco, diviso fra speranze, esaltazioni, ricordi dell’ormai lontano mondo dell’epica e strazianti angosce interiori, spettri del futuro esistenzialismo novecentesco. Fin da subito la critica si spezzò in due: da una parte c’era chi Wagner lo amava, dall’altra chi lo detestava. Wagner o si ama o si detesta. Raramente esistono vie di mezzo. Sulla scia di Wagner c’era chi, come Mahler, portò avanti l’idea romantica della musica vista come veicolo di espressioni, immagini, storie, racconti. C’era poi chi, come Stravinskij, opponendosi a lui auspicava il ritorno a un formalismo secondo il quale la musica non esprime nient’altro che se stessa, e dunque va goduta come oggetto estetico per il suo valore intrinseco, e non per ciò che pretende di raccontare. Se per Wagner la musica è un dramma di cui bisogna ascoltare ammaliati la narrazione, per Stravinskij è un edificio di cui bisogna contemplarne la fattura.
Più generazioni di artisti e intellettuali si sono confrontate con Wagner, e la sua persona è stata oggetto di un culto quasi religioso, come prima di lui lo erano stati Bach, riscoperto nell’800, e Beethoven.

Di questa fervente ammirazione non fu immune neanche Clive Staples Lewis, il celebre autore de “Le cronache di Narnia”, professore universitario, filosofo e apologeta fra i più grandi del secolo scorso. Della musica di Wagner ci offre un’interessante e originale descrizione nel libro “Sorpreso dalla gioia”, un’autobiografia che si concentra sui primi anni della sua vita, in particolare sugli anni dell’adolescenza.
La musica wagneriana era capace di ridestare nel giovane Lewis l’assopita sensazione della “gioia”, che l’autore inglese definisce come una sorta di inesprimibile e romantico struggimento verso l’infinito, sensazione intima e contemplativa che provava da bambino e che il mondo, con il suo cinismo e la sua monotonia, lentamente gli stava sottraendo. Sensazione che, quasi voglia nascondersi, scompare non appena l’uomo prende coscienza di essa. In questo senso, Wagner era capace di far sognare, di ridestare lontani desideri, di offrire brame visionarie; soprattutto, essa era uno dei più importanti veicoli di quella mitologia nordica che fondamentale importanza avrà tanto per Lewis (in particolare per i suoi aspetti filosofici) quanto per l’amico e collega Tolkien (di cui prenderà ispirazione soprattutto per i suoi aspetti letterari).
Lascio dunque la parola a Lewis, che prima ancora di scoprire Wagner o sapere chi fosse Sigfrido era rimasto ammaliato dalla nordicità attraverso alcune illustrazioni trovate casualmente in un libro illustrato da Arthur Rackham. La coscienza della “nordicità” è condizione necessaria per comprendere appieno buona parte della produzione wagneriana. Ci racconta così:
La nordicità pura prese possesso di me: ebbi la visione di immensi, chiari spazi sospesi sopra l’Atlantico nell’interminabile crepuscolo dell’estate nordica, e una sensazione di distacco e di gravità…e quasi nello stesso momento mi resi conto di aver già conosciuto tutto ciò molto, molto tempo prima (…) in Tegner’s Drapa [=poesia di Longfellow], e che Sigrido (qualunque cosa fosse) apparteneva allo stesso mondo di Balder e delle gru che migrano verso il sole. E con questo tuffo nel mio passato affiorò subito, togliendomi quasi il respiro, il ricordo della gioia, la cognizione di avere avuto un tempo ciò che da anni non avevo più, di essere finalmente tornato in patria da un esilio in terre deserte; e il Crepuscolo degli Dei e la mia passata gioia, entrambi remoti e irraggiungibili, fluirono in un’unica, intollerabile sensazione di desiderio e di perdita, che d’un tratto fu un tutt’uno con il dissolversi della stessa emozione: mentre ora mi guardavo in giro per l’aula polverosa come un uomo che riprende lentamente i sensi, essa era infatti già svanita, mi era sfuggita nello stesso momento in cui dicevo “Eccola”.
Procedendo con la narrazione, Lewis arriva al momento in cui incontrò finalmente Wagner:
In tutto questo tempo, non avevo ancora sentito una sola nota di Wagner, sebbene la stessa forma delle lettere che costituivano il suo nome fosse divenuta per me un simbolo magico. Durante le vacanze che seguirono (…) sentii per la prima volta il disco della Cavalcata delle Valchirie. Oggi fa ridere e, in effetti, avulsa dal suo contesto per fare da sinfonia, può essere una povera cosa. Ma io avevo questo in comune con Wagner, che non pensavo a sinfonie ma a un dramma epico. (…) Da quel momento in poi, tutto il mio denaro se ne andò nell’acquisto di dischi di Wagner (soprattutto l’Anello, ma anche il Lohengrin, e il Parsifal) e, all’occorrenza, non chiedevo altri regali.
La mia concezione della musica non subì, dapprima, grosse modifiche. La “musica” era una cosa, la “musica wagneriana” era un’altra, e non c’era nulla che le ravvicinasse, non si trattava di un nuovo piacere ma di un piacere di nuovo genere, ammesso che “piacere” sia la parola giusta, anziché turbamento, estasi, sbigottimento, “un conflitto di sensazioni senza nome”. (…) Durante la vacanza a Dundrum, pedalando in bicicletta tra i monti Wicklow, cercavo sempre, involontariamente, scene che appartenessero al mondo wagneriano: qui un’erta collina coperta di abeti dove Mime incontrava Siglinda, laggiù un’assolata radura dove Sigfrido ascoltava l’uccello, oppure un’arida valle rocciosa dove l’agile corpo squamoso di Fafner emergeva dalla sua caverna.
Da lì in avanti, le porte dell’immaginazione saranno totalmente aperte nel mondo interiore di Lewis, che non a caso definì quel periodo della sua vita come un “rinascimento”, cioè “quel meraviglioso risveglio che sopravvive nella maggior parte di noi quando la pubertà è completa”, che è giusto chiamare “rinascita e non nascita, risveglio e non sveglia, perché per molti di noi, oltre che una cosa nuova, rappresenta anche il recupero di cose possedute da bambini e perdute da ragazzi.”
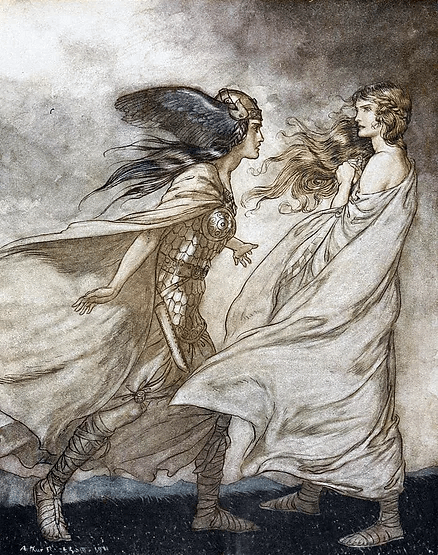
In memoria di J. R. R. Tolkien: Intervista con Paolo Gulisano
Oggi, nel 1973, moriva JRR Tolkien. Lo ricordiamo in questa intervista del nostro Daniele Barale al nostro (perdonate l’iterazione) Paolo Gulisano. Buona lettura!

Il 2 settembre si celebrano i cinquant’anni del dies natalis del subcreatore di Eä, l’universo ove si trova Arda, il mondo della Terra di Mezzo, la cornice entro la quale si svolgono i fatti narrati ne Il Silmarillion, ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli anelli. Ma prima ancora Tolkien è stato docente universitario presso Leeds e Oxford, e autorevole conoscitore delle mitologie classiche, medioevali e moderne. In proposito, meritano attenzione le traduzioni che egli dedicò al Beowulf, a Sir Gawain e il Cavaliere verde, il poema allitterativo La caduta di Artù e il saggio “Sulle fiabe” (On Fairy-Stories).
Tolkien scrisse le sue “fiabe epiche” principalmente per dilettare i famigliari e gli amici (si pensi anche a Mr. Bliss, Le lettere di Babbo Natale, Roverandom), e fornire un mondo verosimile ai suoi linguaggi: dieci lingue e molti alfabeti, tra cui il Sindarin e il Quenya (due esempi: Elen síla lúmenn’ omentielvo; Aiya Eärendil elenion ancalima!).
Come egli stesso scrisse in una lettera del ‘55, alla base del suo lavoro c’è l’invenzione dei linguaggi. Le storie furono create per fornire un mondo ai linguaggi e non il contrario. «Per me, prima viene il nome e poi la storia». E nella lettera “183” (da La realtà in trasparenza) si può leggere: «Io ho la mentalità dello storico. La terra-di-Mezzo non è un mondo immaginario. Il nome è la forma moderna (apparsa nel XIII secolo e ancora in uso) di midden-erd/middel.erd, l’antico nome di oikoumene, il posto degli uomini, il mondo reale, usato proprio in contrasto con il mondo immaginario (come il paese delle fate) o con mondi invisibili (come il paradiso o l’inferno). Il teatro della mia storia è su questa terra, quella su cui noi ora viviamo, solo il periodo storico è immaginario. Ci sono tutte le caratteristiche del nostro mondo (almeno per gli abitanti dell’Europa nord-occidentale) così naturalmente sembra familiare, anche se un pochino nobilitato dalla lontananza temporale. […] Il mio non è un mondo immaginario, ma un momento storico immaginario su una Terra-di-Mezzo – che è la terra dove noi viviamo».
Per celebrare la ricorrenza, abbiamo incontrato Paolo Gulisano, medico, scrittore e tra gli studiosi, italiani ed europei, più importanti del professore; autore di molti libri, tra cui “Tolkien: il mito e la grazia”, “La mappa de Lo Hobbit”, “La mappa della Terra di Mezzo” .
Perché la vita di Tolkien si può definire “eucatastrofica”, a iniziare da fatti quali il “martirio” della madre Mabel e la sua partecipazione alla prima guerra mondiale?
La vita di John Ronald Tolkien può sembrare all’apparenza una vita tranquilla, da docente universitario, da padre di famiglia, coronata dal grande successo letterario che ne fece uno dei più celebri scrittori del XX secolo. Tuttavia non mancarono nel corso degli anni motivi di forte sofferenza, a cominciare dalla perdita ancora ragazzo della madre (dopo che il padre era morto in Sudafrica mentre lui era ancora bambino), una perdita che lui considerò con buone ragioni un martirio, in quanto Mabel dopo la sua conversione al Cattolicesimo era stata ingiustamente discriminata, abbandonata anche da un punto di vista economico, tanto da non poter curare efficacemente il diabete grave da cui era affetta. Il primo evento “eucatastrofico” fu l’ingresso nella sua vita di giovane orfano, affidato alle cure del tutore Padre Francis Morgan, di Edith Bratt, la donna che diventò sua moglie, e in qualche modo una musa ispiratrice. L’amore fu però difficile, un fidanzamento contrastato, perché la priorità che gli aveva posto Padre Morgan era che si laureasse, così da compiere il desiderio della mamma. Una volta sposati, il matrimonio presentò, come tante volte accade, delle difficoltà, dei momenti di incomprensione e amarezze reciproche, anche se durò tutta la vita. A queste sofferenze si aggiunse certamente la Guerra, i cui orrori Tolkien toccò con mano: la perdita degli amici, la sconsiderata follia degli alti ufficiali che utilizzavano i soldati come carne da macello, l’odio e la crudeltà. Tutto questo entrò nel suo immaginario. Ma alla fine, nonostante tutto il male che è in noi e nel mondo, Tolkien ebbe sempre la sicura certezza di quella che chiamò Eucatastrofe, ovvero l’irruzione nella storia della Salvezza. Le porte degli inferi non prevarranno, come nemmeno i neri cancelli di Mordor.
L’amicizia: quanto questa forma alta di Carità è stata per lui fondamentale?
Tolkien come scrittore è stato un vero e proprio cantore dell’amicizia: basti pensare al legame profondo e commovente tra Frodo e Sam, oppure quello sorprendente che si instaura tra Gimli e Legolas. Tolkien aveva vissuto delle amicizie straordinarie, con i suoi compagni di scuola del T.C.B.S. prima, e poi ad Oxford con C.S. Lewis e il gruppo degli Inklings, quel gruppo di accademici e non che condividevano la passione per la Mitologia, per il Cristianesimo, e per i buoni boccali di birra, e che si ritrovarono per anni in un piccolo pub di Oxford, coltivando una bella amicizia. Questo tipo di sentimento, ovvero di forma alta di Carità, fu per lui assolutamente fondamentale, e come detto lo traspose nelle sue creazioni letterarie. Allo stesso modo l’amico Lewis ne parlò in una delle sue opere più significative, il saggio “I Quattro Amori”.
Perché egli può essere definito un autore cattolico, e non un ecologista di sinistra, o un mero conservatore destrorso? Cosa ci dicono al riguardo le sue lettere?
Le interpretazioni politiche di Tolkien sono sempre state del tutto riduttive. Negli anni ’60 fu una certa sinistra americana a cavalcarlo, in nome del suo anticonformismo e di quello che sembrava essere una forma di ecologismo, tant’è che David Taggart, il fondatore di Green Peace, diede il nome di Frodo ad una delle prime imbarcazioni dell’associazione. In Italia invece la cultura dominante di Sinistra lo marchiò immediatamente come “fascista”, forse perché presentava nel suo libro uno scenario di tipo vagamente Medioevale, e per la Sinistra manichea Medioevo equivaleva a significare Destra, dopodiché fu inevitabile che una parte del mondo giovanile di Destra, la parte più anticonformista, più innovativa, più colta, non quella meramente nostalgica o che sognava i colonnelli, lo fece propria. Ma Tolkien è al di là e al di sopra di tutte le ideologie. Risulta riduttiva qualsivoglia etichettatura del professore di Oxford, poiché ciò che ispirò e che diede significato alla sua vita e alla sua opera non è riconducibile ad una ideologia, ma ad una visione della vita, ad una concezione dell’essere, dell’uomo, della storia che è ben di più che una ideologia: è una filosofia. Tolkien possiede addirittura quella che potremmo definire una visione teologica della storia, attraverso la quale giudica, con l’autorevolezza di un filosofo o di un profeta le vicende umane. Tutto ciò emerge anche dalle sue lettere, dove ci rivela quanto il suo profondo, robusto cattolicesimo inglese abbia forgiato la sua opera.
I suoi personaggi – sia de Il Silmarillion, sia de Lo Hobbit, che del Signore degli Anelli – possono essere definiti “grigi” (come Gandalf, prima di diventare bianco), e non neri o bianchi, come sostiene certa interpretazioni manichea. È vero?
Tra le critiche malevole che nel tempo furono fatte all’opera tolkieniana c’è proprio quella di essere manichea. E il manicheismo, in ambito letterario, significa debolezza dell’opera, in quanto la realtà – si sa – è estremamente complessa. Ma di fatto i romanzi di Tolkien non sono affatto manichei: certo, si parla di Bene e di Male, e li si chiama col loro nome, senza ambiguità, ma essi non stanno tutti da una parte o dall’altra: combattono nel cuore dell’uomo. La storia di Theoden è quella di un cambiamento, quasi di una conversione, o un risveglio spirituale da quello stato di incantamento quasi ipnotico (e questa è una condizione dell’uomo contemporaneo descritta profeticamente da Tolkien in modo mirabile) in cui l’aveva condotto Grima Vermilinguo. Oppure le storie di cadute, di tradimenti, come quello di Boromir, in cui possono cadere anche “i buoni”, e infine la drammatica, spaventosa apostasia di Saruman, che abbandona la via della saggezza per mondanizzarsi, per venire a compromesso con Sauron. Insomma: Tolkien non è semplicisticamente manicheo, ma sa bene che la realtà vede gli uomini impastati di Bene e Male e chiamati a scegliere.
Quali frutti occorre prendere dalla sua “opera magna”, per ben riflettere sul potere, sulla tecnica, sul rapporto tra l’uomo e Dio, l’ambiente in cui l’uomo vive (naturale e soprannaturale) e sulla valorizzazione della libertà?
Egli ha riproposto, in pieno ventesimo secolo, il genere letterario epico, ridando dignità letteraria all’antichissimo genere della narrativa dell’immaginario, nonostante il cinismo di una cultura dominante che doveva fare a meno dei valori, in particolare dell’eroismo. Il ritorno al Bello e al Vero auspicato dallo scrittore di Oxford venne realizzato da lui attraverso il ricorso e il ritorno al Mito, per ridare sanità e santità all’uomo moderno. “Il mito è qualcosa di vivo nel suo insieme e in tutte le sue parti, e che muore prima di poter essere dissezionato”, disse Tolkien parlando ai suoi studenti di una delle sue opere preferite, il Beowulf. Il mito è necessario perché la realtà è molto più grande della razionalità. Il mito è visione, è nostalgia per l’eternità. Il mito è un mezzo per dare risposte a questioni fondamentali come l’origine dell’uomo, il bene, il male, l’amore, la morte e per dare spiegazioni ai fenomeni della natura. Se il mito è il nesso, il legame che l’uomo ha sempre cercato con il senso della vita, esso non può quindi che essere considerato un’espressione naturale ed antichissima del senso religioso che vive nel cuore dell’uomo.
Qual è stata l’influenza di San John Henry Newman e Gilbert Keith Chesterton su Tolkien?
Newman, uno dei più grandi pensatori cristiani degli ultimi secoli, era stato, nonostante la mitezza, quasi la fragilità della sua persona, un segno di contraddizione che aveva scosso l’Inghilterra sia cattolica che protestante. Da anglicano aveva dato vita al Movimento di Oxford, teso ad approfondire la ricerca teologica, specie nel campo della Patristica (quando la Chiesa era ancora una e indivisa) e a confrontarsi con le sfide della modernità. Questa ricerca della verità lo aveva fatto infine approdare al cattolicesimo. Un suo discepolo, padre Francis Morgan, era stato suo assistente personale, e quando divenne il tutore di Tolkien gli trasmise tutto quanto aveva appreso da Newman. Sulla sua tomba il grande convertito aveva voluto che fossero incise queste parole: Ex umbris et imaginibus in veritatem. Andiamo verso la verità passando attraverso ombre e immagini. Per John Ronald Tolkien, che amò subito appassionatamente la fede cui sua madre lo aveva condotto, l’arte fu per tutta la vita questa ricerca della verità tra quelle ombre, quelle immagini che sono i miti e i simboli. Allo stesso tempo Tolkien guardò con grande interesse a Chesterton, di cui fu lettore, ma che non incontrò mai personalmente (c’era tra i due quasi una generazione di differenza), e sicuramente rimase colpito, come scrive nel suo saggio Sulle fiabe, dalla via chestertoniana dell’immaginario, del paradosso, dell’immagine velata, allo scopo di liberarci dai vari orpelli che, nella vita ordinaria, mascherano il volto della verità. Fu di fatto un ottimo allievo di GKC.
Cosa pensi della traduzione a opera di Ottavio Fatica: rappresenta il tentativo della cultura di sinistra di tirare verso di sé la manica di Tolkien? E della serie curata da Amazon, “Gli anelli del potere”: è meramente il tentativo di asservire il suo ricchissimo immaginario al politicamente corretto? Oppure, vi è ancora qualcosa di buono in esse?
Premesso che è del tutto lecito ritradurre i Classici della Letteratura (e Tolkien lo deve assolutamente essere considerato) come avviene per Omero o Shakespeare, le premesse di questa nuova edizione effettivamente avevano delle motivazioni ideologiche. Dopo i grossolani e ottusi attacchi degli anni ’70, a sinistra ci fu qualcuno – e non pochi- che lesse Tolkien, e ne apprezzò tutto il valore. Tuttavia c’era il problema di un autore ormai diventato nella vulgata corrente “di destra”. Come fare dunque a sdoganarlo? A farlo arrivare anche ai compagni lettori? Un’ opinione era che lo scivolamento a destra era avvenuto anche per colpa della traduzione del Signore degli Anelli, giudicata troppo aulica, epica, e quindi il linguaggio avrebbe determinato il celebre feeling politico. Occorreva una traduzione più popolare, più colloquiale, meno altisonante, più simile al linguaggio della narrativa realista, e così è arrivata la versione di Fatica. Personalmente non ne sono stato molto soddisfatto, pur nella consapevolezza che anche la prima traduzione fosse decisamente rivedibile. Rimane il rimpianto che il Signore degli Anelli non sia mai stato tradotto da Francesco Saba Sardi, il traduttore del Silmarillion, che a mio avviso resta di gran lunga il miglior interprete in lingua italiana di Tolkien. In quanto alla serie Amazon, devo dire che l’ho trovata completamente priva dello spessore epico di Tolkien. Un fantasy come tanti altri. Di Tolkieniano sono rimasti solo i nomi.
Ultima domanda, molto personale: quando e come ha cambiato la tua vita “l’incontro con il professore oxoniense”?
John Ronald Tolkien mi ha dato tantissimo, dal momento in cui lo scoprii a 19 anni. Mi ha ricolmato di bellezza, di valori grandi che ho cercato di far miei; mi ha aperto orizzonti culturali infiniti sulla storia, sulla mitologia, e cosa più importante di tutte, sul senso del Sacro e sulla Fede Cattolica. E’ stato un onore e una grande gioia diventare un suo esegeta, e raccontarlo non solo al pubblico italiano, ma anche a quelli di Polonia e Repubblica Ceca dove i miei libri sono stati tradotti. Non gli sarò mai abbastanza grato.

Il Palio di Siena, dalla nostra inviata sul posto (un ritorno).
Qui così Miriam ci raccontava del Palio della Madonna di Provenzano: adesso, come è bene che sia, ci racconta il Palio dell’Assunta (se eravate distratti, ecco qua), con un focus tutto particolare.
Ceri e Censi, l’antico cuore sacro del Palio dell’Assunta
14 agosto, nel torrido pomeriggio estivo, da secoli, tutta Siena si riunisce per una tradizione che pare provenire dal XII secolo, forse più antica della corsa del Palio che si svolge il 16 agosto. La devozione alla Madonna Assunta affonda le sue origini proprio in tale periodo, quando la città di Siena conquista e afferma la sua indipendenza, costruendosi attorno il grande stato che fino alla caduta nel ‘500 l’ha resa una delle città più potenti d’Italia; tale devozione si rinsalda dopo la vittoria di Montaperti contro Firenze, nel 1260. Da allora, con una breve assenza dopo l’unità d’Italia, ogni anno contrade, parrocchie, castelli e comunità dell’antica repubblica affollano le vie della città in processione verso la cattedrale recando in dono alla Vergine Assunta, venerata con il titolo di Advocata Senensium, preziosi ceri decorati. L’uso di donare ceri, e più in generale la costosissima cera, ai luoghi di culto, proviene proprio dal medioevo ed era una donazione preziosa visto i prezzi del materiale e l’utilità che le chiese ne traevano: tale cero aveva un peso in libbre equivalente al censo ovvero la vetta collettiva di tasse che tale terra doveva versare a Siena.
La processione in sé è studiata nei minimi dettagli dal comitato preposto e l’ordine prestabilito non può essere infranto per nessun motivo, il che contribuisce all’enorme solennità e spettacolarità del momento. Dalla chiesa di San Giorgio parte la componente ecclesiale scortata dalla polizia municipale e dalla banda “Città del Palio”, seguiti dai gonfaloni dei terzi della città, dalle relative rappresentanze delle contrade formate da giovani contradaioli recanti il prezioso cero e dalle parrocchie presenti dentro e fuori le mura. Lambendo Piazza del Campo lungo il chiasso largo si aggrega la componente civica con le comparse delle contrade, un tamburino e due alfieri, nell’ordine delle bandiere esposte a Palazzo Pubblico per l’estrazione del Palio, seguite da quelle che quest’anno non correranno la carriera del 16. Chiudono il corteo le chiarine di Palazzo, il Sindaco e le autorità, i labari del Comune e del Magistrato delle Contrade con la rappresentanza dei priori, il Drappellone scortato dai valletti e il Carroccio con il cero comunale tirato da due immensi buoi di razza chianina.

Le comparse delle contrade accolgono l’ingresso dei Trombetti di Palazzo, delle autorità e delle insegne comunali.
Si suda lungo il corteo, d’altronde sono le quattro di pomeriggio in pieno agosto, ma si arriva senza intoppi davanti alla cattedrale dove il campanile suona a distesa ad accogliere la città intera. Entrano le comparse e tutte le componenti del corteo depositando i doni ai piedi della madonna del Voto, con i tamburi e le chiarine a far tremare le pareti del Duomo e in ultimo viene portato il grande cero comunale, preziosamente dipinto a mano e acceso dal sindaco Nicoletta Fabio; nel mentre il canto più bello e caro ai senesi ripete: “O Maria, la tua Siena difendi, per lei prega benigna il Signor”.
Parola al Cardinale Arcivescovo di Siena – Colle Val d’Elsa – Montalcino, Augusto Paolo Lojudice, amico delle Contrade e del Palio; parla ai bambini e ai ragazzi delle contrade che hanno portato i ceri: “Un saluto a tutti voi più piccoli che avete fatto questo sforzo, un bel cammino in tutte le strade con questo peso, con questi regali che avete portato in Duomo ai piedi della Madonna. È importante fare questo dono, questo è il segno di una festa, dove la festeggiata è proprio lei, Maria, ai piedi della quale avete portato questi regali; quando si va a una festa si è contenti e gioiosi, si portano regali, e così è stato fatto. Mi soffermo ora sul drappellone, il meritato premio per chi vincerà il 16, lì si evince con chiarezza e forza che Lei è al centro, in alto, con il suo manto, assunta in cielo. Vi ringrazio, non voglio arrogarmi il titolo di prendere le parti di Maria, di questi regali come vi ringrazierebbe lei, mamma di tutti noi alla quale nei momenti difficili possiamo e dobbiamo rivolgerci. Chiediamole un aiuto, una vicinanza e un sostegno, come tante volte nella storia Siena ha fatto.” Squilli di chiarine, rullo di tamburi e l’Arcivescovo benedice il tanto contestato drappellone, manca poco al Palio e i popoli sono in fermento, non è un segreto che con questa offerta del cero le contrade auspicano un qualche favore celeste nei propri confronti alla carriera dell’Assunta.
Questa celebrazione tanto sentita, nonostante le accuse rivolte ai senesi di avere solo forma e niente sostanza in campo di fede, dimostra come a distanza di secoli Siena continua a guardare alla Vergine nei momenti di festa come il Palio e nei momenti di difficoltà; in ultimo nel 2020 erano state deposte ai piedi della Madonna del Voto (opera di Dietisalvi di Speme, datata 1267), l’icona più venerata della Madonna Advocata Senensium, le chiavi della città come supplica durante la pandemia. Dopo la processione un violento acquazzone si è abbattuta sulla città causando l’annullamento di due prove del Palio e del concerto della Città del Palio, ma questo non ha scoraggiato i popoli che alla prova generale e poi alla carriera hanno riempito fino all’orlo Piazza del Campo.

A onor di cronaca il Palio, uno dei più movimentati e imprevedibili mai visti, l’ha vinto la contrada dell’oca con il cavallo scosso Zio Frac, dapprima montato da Carlo Sanna detto Brigante, dopo una serie di rocambolesche cadute e sorpassi. Non si smetterà mai di accusare l’oca di essere favorita dall’alto essendo il rione d’origine di Santa Caterina ma, dati in mano, è la contrada più vittoriosa con ora 67 palii ad arricchirne il popolo. Eppure, dopo la corsa, recuperato il drappellone, dopo qualche disfida e fronteggiamento con la Torre, arrivata seconda per ben tre volte di fila, stavolta dopo la rivale, la prima cosa che il popolo vittorioso fa è tornare da Lei, in duomo, per rendere grazie alla Vergine Regina di Siena per la vittoria con il “Maria mater gratiae”, segno che, nel cuore di una delle tradizioni più mondane e profane, c’è ancora qualcosa di veramente devoto.
Maria Mater Gratiæ,
Mater Misericordiæ,
Tu nos ab hoste protege
et mortis hora suscipe.
Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu
in sempiterna sæcula. Amen.

La madonna del voto, dipinta nel 1267 circa da Dietisalvi di Speme, l’immagine più venerata della Cattedrale, con il nome di Advocata Senensium.