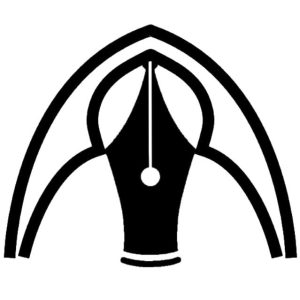Pubblichiamo qui un racconto del nostro Davide Gorga, dal titolo La soffitta, comparso nella raccolta Realfiabe, pubblicata da Montedit. Trovate il pdf qui, oppure anche sotto sotto. Buona lettura!
Le scale si arrampicavano nere su per i muri scrostati, fiocamente illuminati dagli ultimi raggi di una giornata grigia e spenta che entravano dai vetri sporchi; i gradini, perdendosi nel buio lungo la rampa, erano rigati di venature brune. L’immagine fuggente e indistinta di una figura attraversò il pianerottolo, dopo aver indugiato un attimo volgendo lo sguardo verso quell’ascesa nell’oscurità; aprì una porta senza colore e la richiuse alle spalle.
Il sole morì tra nuvole di polvere, lontano.
Le luci gialle dei lampioni stradali illuminavano la camera attraverso le persiane che le lasciavano filtrare in strisce acide. Sul letto in disordine, lacrime e macchie di sporco. Intorno, lattine, stracci che dovevano essere indumenti, uno walkman dimenticato. La porta si aprì con un fascio di luce; l’ombra sulla soglia non parve rivolgersi a nessuno in particolare con la sua voce roca;
– Sei lì?
Non venne risposta dalla figura a malapena distinguibile nell’oscurità; l’ombra si avvicinò:
– Elena, non fai altro che startene rinchiusa in camera tua a dormire, – proseguì la voce; – almeno potresti fare finta di farci compagnia mentre mangiamo!
La ragazza si riscosse passandosi sugli occhi una mano che risaltò bianca nel nero della notte; non vedeva nulla oltre il mare di ortensie brunite in cui navigava, come bruciate dalla luce dell’inferno. Volse il viso dalla parte della finestra, sempre in silenzio.
Un odore di sporco e solitudine si risollevò dal letto su cui si era appoggiata l’ombra;
– Fa’ quello che vuoi. – riprese la voce, – Sei una fallita da quando sei nata. – quindi scomparve nella luce malsana della porta che si richiuse cigolando sui cardini.
Sei una fallita da quando sei nata.
Con uno sforzo, Elena allungò una mano oltre la sponda del letto e raggiunse lo walkman, si mise le cuffie e dimenticò la voce; chiuse gli occhi nel cinguettio di un’alba che si andava disegnando come in un quadro sempre più luminoso nella sua mente e avvertì il sangue ritemprarle le membra, in un’aura dolce e vigorosa, mentre il mondo con le sue tempeste svaniva dietro un velo di nebbia argentea, lontano, sinché scivolò insensibilmente dalla visione in sogni scintillanti.
* * *
L’orologio sul muro segnava le tre di notte passate. Il frastuono della strada rimbombava nella stanza nera, unico rumore; le luci si rincorrevano riflettendosi sulle trasparenze della camera. Nausea. Elena si sollevò sul letto lentamente, sforzandosi di non vomitare; la camera ruotava intorno a lei come una giostra fuori controllo, le sorgenti del sogno si erano disseccate. Cercò di alzarsi, ma cadde pesantemente sul pavimento; il suo corpo leggero sembrava dolere in ogni parte quando tentò a fatica di reggersi in piedi; poi, in un incubo senza fine, un passo trascinato dietro l’altro, in un tempo dilatato come un lombo di carne tra i ganci di un invisibile macellaio, raggiunse il bagno strisciando. Mentre vomitava, la luce spenta, da oltre il tramezzo giunsero frasi incomprensibili, come bocconi di cui dovesse liberarsi, sino ad essere scossa violentemente in spasmi taglienti come spade.
Lacrime di lira sembrarono piovere visibilmente intorno a lei, gocce d’argento che risalivano la corrente dello spazio e del tempo; canti di vestali di un tempio di vetro dimenticato, fluendo in lei come il giardino di sogno dalle acque fiorenti di fuoco ghiacciato. Elena sentì gli spasmi placarsi a poco a poco. Non era la prima volta che avvertiva quella musica, come un canto di benedizione nella sua vita maledetta. Non era la prima volta che si snodava dal nulla senza preavviso, quando si era sentita sola, sperduta, a un passo dalla morte, ed era tornata indietro, come richiamata dalla forza invincibile di un incantesimo che originasse dalla potenza stessa delle stelle. Ansimò profondamente; si rimise in piedi, ora salda, viva e quasi lucente in quella tenebra. Chiuse gli occhi, come se la musica potesse abbagliarli tanto era limpida e pulita, alta come un cirro in inverno. Dopo qualche minuto, il celeste canto smise di colpo.
La ragazza rimase impietrita, travolta da un’ondata d’ineffabilità, piena di pace, e così rimase a lungo. Gli accordi ghiacciati dell’inverno su distese di neve senza fine, il cielo in laghi che piovevano sulla terra bianca. Vagabondi e girovaghi sul sentiero tra impronte fresche e foglie calcate nel cammino verso l’infinito. Occhi di luce per accogliere il mondo.
E stelle nella notte amica.
* * *
Il mattino si presentò con lo stesso squallore del giorno precedente, ma i primi pallidi raggi trovarono sorridenti le ciglia della giovane. Il sogno della musica, la musica che penetra ogni difesa inconscia sino all’intimo, era continuato tutta la notte, virgineo, purpureo come una cascata di fiori ghiacciati, sereno come il blu del cielo oltre le nubi.
Prima che l’ombra e la voce potessero sorprenderla, afferrò lo zaino di scuola e si precipitò fuori di casa, ebbra di felicità, sbattendo alle sue spalle la porta quasi fosse il cancello dell’inferno.
Il carnaio si snodava dinanzi al vecchio edificio. Effluvî di sudore e saliva la circondavano; la danza della bianca estasi chimica rincantucciata in un angolo era fitta di colori sgargianti. Le nubi piangevano qualche lacrima stanca e grigia. Elena chiuse gli occhi e si affrettò verso l’entrata, sempre sola, sempre maledetta.
Le ore trascorsero vuote.
Il giorno moriva lentamente prima di essere nato.
La sfilata dei corpi in saldo si esauriva in un viavai di automobili anche quella mattina; dietro una colonna, Elena, la mente stanca, si mosse per raggiungere l’uscita un istante prima che il portone chiudesse, come ogni giorno; come ogni maledetto giorno, mentre l’asfalto chiaro e sgretolato svaniva divorando sé stesso.
* * *
I circoli concentrici si richiudevano sulla voce mascolina della ragazzina che cantava nelle tempie, mentre Elena serrava gli occhi dinanzi alla vernice di sangue che aveva imbrattato le pareti dell’autobus, le ginocchia al petto, sorda alle urla che venivano lanciate nella sua direzione, allontanandole come miasmi di scarti che il mercato di carne morta avesse lasciato sul campo. Il corpo pesante, sempre troppo pesante, sempre di più, scese finalmente con fatica dall’autobus, fece lentamente qualche passo nel vento lieve e rientrò in casa, chiudendo la porta dietro di sé.
– Com’è andata la scuola, Elena? – chiese una voce squillante; la ragazza chiuse gli occhi.
– Bene.
– Tra cinque minuti a tavola, mi raccomando, non vorrai fare arrabbiare tuo padre, no?
Elena sorrise amaramente, fece qualche passo in direzione della sua stanza e si lasciò cadere sul letto ancora sfatto, senza rispondere. La luce del giorno sembrava troppo forte, chiuse di nuovo gli occhi e accese lo walkman.
La musica s’interruppe d’improvviso. Uno schianto secco e un bruciore lungo il viso la fecero gridare, vide le lacrime scorrere prima di accorgersi di quanto era successo. L’ombra era lì. Elena si prese il volto tra le mani.
– Ma non sai fare altro che ascoltare questo pezzo di metallo idiota?
– Lasciami stare, papà… – balbettò soltanto tra le lacrime la ragazzina. Prima che potesse raggomitolarsi su sé stessa, un colpo violento sollevò il suo fin troppo fragile corpo dalle coperte mandandola a sbattere contro la parete. A Elena parve che tutte le ossa si spezzassero come cristallo, togliendole il fiato e la vista; ricadendo udì ancora rumori confusi come in un concerto infernale, quindi rimase immobile, la gola bene in vista, le lacrime che sgorgavano a fiotti, mentre la porta della stanza si richiudeva.
Il battito del suo cuore fu la prima cosa che avvertì svegliandosi dall’incubo. Il pavimento era freddo, ma lei non tremava. Poi, come invisibili mani che la sorreggessero, dolci note l’avvolsero in un vortice bianco come neve, quasi risollevandola contro la sua stessa volontà, sinché Elena non si ritrovò in piedi; stava male, aveva voglia di vomitare e non riusciva a muoversi ma inspiegabilmente era riuscita a rialzarsi; e allora, lentamente, un passo dopo l’altro, si diresse verso l’unico luogo che potesse prometterle ormai riposo.
La soffitta era oscura, ma la luce che filtrava dai grandi finestroni limpidi illuminava ampi squarci di pavimento lindo; profumi di fiori si levavano da ogni parte, senza che la ragazza sapesse riconoscerne l’origine, ed ovunque la musica, sempre più alta e dolce, la circondava. Come una sonnambula, arrivò sino alle finestre, le aprì e guardò in basso il selciato lontano, e si lasciò andare.
Come una mano vibrante, le note della lira la trassero indietro, sospingendola verso il centro della stanza.
– Che stai facendo!? – chiese una voce alta e limpida come le note, mentre queste si spegnevano senza che tuttavia l’incantesimo sembrasse rompersi. Era una voce alta, maschile e femminile, sottile e tesa come l’argento. Elena si volse. Dinanzi a lei un ragazzo dagli occhi color del cielo, vestito solo di una pesante tunica bianca sulla quale ricadevano lunghi capelli corvini, la osservava. La ragazza non rispose, sentendo gli occhi severi immobilizzarla in quella posizione, mentre il dolore poco per volta scompariva dal suo volto e dalle sue membra; – Allora? – chiese nuovamente la voce.
– Chi sei? – rispose Elena.
– Siediti. – ordinò dolcemente l’altro, mentre rimaneva in piedi dinanzi a lei; – Se sei così decisa a suicidarti, cerca un altro posto e non interrompere la mia musica. Oppure, spiegati.
Nonostante il giovane avesse lasciato il suo strumento nell’ombra, parve a Elena di udire ancora le note dell’incantesimo dipanarsi come una melodia albeggiante su una vetta di paradiso; eppure, udì la sua voce rispondere in tono sommesso:
– Non volevo.
– Lo vuoi da molto tempo. – rispose il ragazzo, quasi senza muovere le labbra; dinanzi allo sguardo attonito dell’altra, riprese: – Tanto nessuno sentirà la tua mancanza, vero? Sei una fallita da quando sei nata. – Elena abbassò gli occhi, ma non riuscì a tenere lo sguardo basso a lungo, una volontà più forte della sua si era impadronita del suo corpo; gli occhi color del cielo la fissavano ancora. Dietro al ragazzo apparve fugacemente una figura di donna, giovane, castana, eterea, della sostanza dei sogni; – Mamma! – gridò Elena slanciandosi in avanti, ma la visione scomparve con la stessa fugacità con la quale era apparsa, lasciandola con il cuore gonfio di collera, rimpianto, nostalgia, mentre un pianto dirotto prorompeva, ancora; ma questa volta sembrava che ogni lacrima la lavasse del veleno che le corrodeva le membra.
– Vedo che hai deciso di reagire. – riprese il ragazzo senza mutare espressione, – Combatti, se non per te, almeno per lei, per questo mondo malato che tanto ti disgusta; lo vomiti ogni giorno ma non fai nulla per cambiarlo. – continuò con voce dolce; – Puoi vivere una vita splendente come un arcobaleno, oppure spegnerti. Dunque? –
La ragazza singhiozzava senza capire, eppure sentiva la vita rinascere in lei in ogni vena, in ogni parte del suo corpo martoriato; e udì la sua stessa voce rispondere: – Non ce la faccio.
Il ragazzo non lasciò il suo sguardo, gli occhi azzurri divennero ancora più penetranti; – Allora, muori. – disse.
In quell’attimo, la musica che sembrava vibrare nella stanza cessò all’istante, la luce del giorno si oscurò dietro una nube grigia, la soffitta parve vuota e buia, priva del profumo e dell’incanto che avevano accolto la ragazza, simile ad un baratro oscuro come oscuri erano stati gli anni della sua vita; la figura stessa del ragazzo che le stava davanti parve scomparire; – No!– gridò con una voce talmente acuta da far vibrare i vetri delle finestre; il ragazzo le parlò ancora una volta; – Dunque?
– Voglio vivere, – urlò Elena, – voglio vivere per sempre così!
Il giovane la guardò con dolcezza, sorridendo; la luce rischiarò nuovamente la stanza e musica, profumi e suoni si mescolarono ancora una volta in quell’angolo di paradiso così vicino al cielo.
Il sorriso del ragazzo illuminò il suo volto, quindi, chiudendo gli occhi, questi si volse e fece per andarsene; – Addio – mormorò soltanto.
– Aspetta! Dove vai? – ma l’altro sembrava allontanarsi quietamente, quasi sfiorasse appena il terreno; – Come farò senza la tua musica!? – gridò ancora Elena in lacrime. Fu solo in quell’istante che la figura si arrestò e, sempre sorridendo, chiese, di rimando: – La mia musica? Ti sbagli, quella era la tua. Altrimenti perché la sentiresti anche ora che ho smesso di suonare? –
Poi, il giovane sembrò sfuggire nell’ombra della soffitta; Elena lo cercò, nella stanza, per le scale, per le strade, senza trovarlo. Ma la musica era rimasta.
Aveva ragione lui.
* * *
Il sole calava lento indorando di riflessi multicolori gli aghi degli abeti che svettavano intorno al cimitero, e la lastra bianca dinanzi alla quale non aveva mai voluto inginocchiarsi risplendeva come un arcobaleno, come un dono del cielo sulla terra. Elena depose le ortensie sulla tomba della madre accarezzandole, come se ognuna fosse una nota di quella musica, ora sottile, dolce, nostalgica eppure di una bellezza infinita che non aveva mai smesso di vibrare da quel giorno, in soffitta, donandole il coraggio di risorgere alla vita.
Elena si alzò, fece pochi passi indietro e notò una lapide screpolata dal tempo, senza fiori, su cui campeggiava il ritratto di un giovane corvino dagli occhi color del cielo.
Una nota si levò più alta nella musica di Elena. Prese una delle ortensie che ancora reggeva in grembo e la depose sulla pietra.
Il vento sembrò carezzarle il viso.