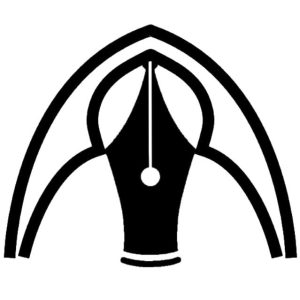Ritorniamo attivi dopo l’estate (si spera passata al meglio per tutti!) in questo giorno del cinquantaunesimo di morte di JRR Tolkien con un racconto di Davide Gorga, dal titolo intuitivamente autunnale, e che potete anche scaricare qui (o in fondo a questa pagina).
Buona lettura!
Pioveva ormai da non importa più quanto tempo, e il cielo era sempre grigio e pallido — eppure, continuava a piovere. Le strade si erano trasformate in ruscelli che scorrevano inevitabilmente verso il basso, eppure, le colline non erano franate, le piante avevano continuato a crescere, le radici nodose a irrobustirsi e a trattenere la terra e l’erba rorida.
Ed io continuavo a viaggiare. Sempre, sotto la pioggia.
Tornavo sulle colline che mi avevano visto bambino in giorni di sole. Era come se la coltre grigia che avvolgeva ogni cosa col battito ritmico delle gocce desse al mondo non un tempo diverso ma l’opportunità di rimediare agli errori del tempo passato.
Pioveva da sempre ormai; i fiumi erano ingrossati e lavavano via la terra da tutto il marcio e lo sporco che gli uomini avevano accumulato – e in molti si erano chiesti perché; come fosse possibile. Le nuvole non si diradavano, il sereno non tornava, continuava a cadere quell’acqua che univa la terra al cielo. Eppure, le dighe non strariparono, i fiumi non esondarono, non vi furono alluvioni né allagamenti, soltanto lo scorrere impetuoso delle acque verso il mare. Tentarono di capire, ma non vi riuscirono. Studiarono, e non compresero. E così, dopo un tempo che ormai nessuno misurava più, smisero di tentare di capire — e intanto, continuava a piovere.
Mi fermai alla casa in collina.
Nell’aria echeggiava la luce delle candele. Era come se il persistere di un’atmosfera opprimente avesse invitato gli animi a cercare il calore di quel fuoco che non conoscevano ormai più. Le persone che si riunivano tornavano a scoprire il piacere di stare insieme; i vicini in un’unica casa; parenti, amici, a parlare, a guardarsi ancora una volte negli occhi, giovani e vecchi; padri, madri e figli, ancora uniti, mentre fuori pioveva. Nel silenzio scrosciante di quella fitta coltre liquida.
Quella sera, il centro città splendeva di una luce interiore nell’oscurità del sole calante. Gli alberi avevano continuato la loro crescita, le foglie grondanti, le chiome ombre nel cielo senza stelle.
Chiara si avvicinò, scarponi rossi scintillanti, mantella blu, una figura colorata in tutto quel grigiore. E il sorriso della gioia. La panchina stillava gocce grigie in ruscelli.
In silenzio.
«Grazie per essere venuta!»
«Figurati!» rispose il sogno di sole.
«Questa pioggia, questo cielo; non sorgerà mai più il sole, vero?»
«Forse!» sospirò Chiara; «ma l’importante è il calore delle nostre famiglie, quello che abbiamo coltivato, che ci siamo meritati.»
«Ma questo è il mio dolore! Questa è la mia notte!»
L’angelo che mi sedeva affianco sorrise ancora, e parve divenire velato, quasi trasparente nell’oscurità.
«Sì, È questo. Sei pronto per lasciare andare il passato, per lasciare le foglie cadere, le acque scorrere? Devi accettare l’autunno, devi accettare la notte, o non ci sarà mai più aurora.»
Levai lo sguardo al cielo.
Erano così tanti anni, così tanti ricordi, era così tanto dolore da allontanare, che mi sembrava impossibile liberarmene, quanto un forzato non possa togliersi le catene che lo ancorano al suolo.
«Devi solo lasciare andare.» disse più fievole ma con un accento brillante come la fiamma di una candela la figura sempre più evanescente fra le brume.
Lasciare andare.
Chiusi gli occhi e rividi la strada della scuola, le giornate grigie dell’inverno – il mio inverno – immobili, dure, ghiacciate; l’oscurità dell’anima. E le ringraziai e le benedissi. Perché mi avevano ferito. Perché mi avevano fatto del male. Perché mi avevano lasciato cicatrici da cui avevo imparato qualcosa di prezioso.
Avevo imparato ad amare.
Socchiusi lentamente le palpebre. Il sottile cantilenare delle gocce sul selciato era svanito. Chiara non si vedeva più. Le foglie degli alberi intorno a me presero ad ingiallire e cadere una ad una, in un canto d’autunno che mi sorprese estasiato.
Mi sollevai. Camminai fra i turbini di foglie. Ed essi cessarono. Rosse come l’autunno e sbiadite nei colori freddi dell’inverno, su un tappeto scintillante di neve fino all’orizzonte. Ed all’oriente, lontano, sul mare, sorse finalmente un sole limpido, chiaro, alto, in un cielo sereno e terso.
Mi chinai. Tra i prati indugiavano le prime sottili luci. E, tra esse, fiori tra le pietre a disegnare il cammino.
«Sentinella, quanto resta della notte?» udii lontana la voce di Chiara, ormai scomparsa nella luce.
«Più nulla, ormai», mormorai, rinato.