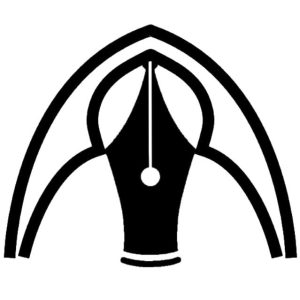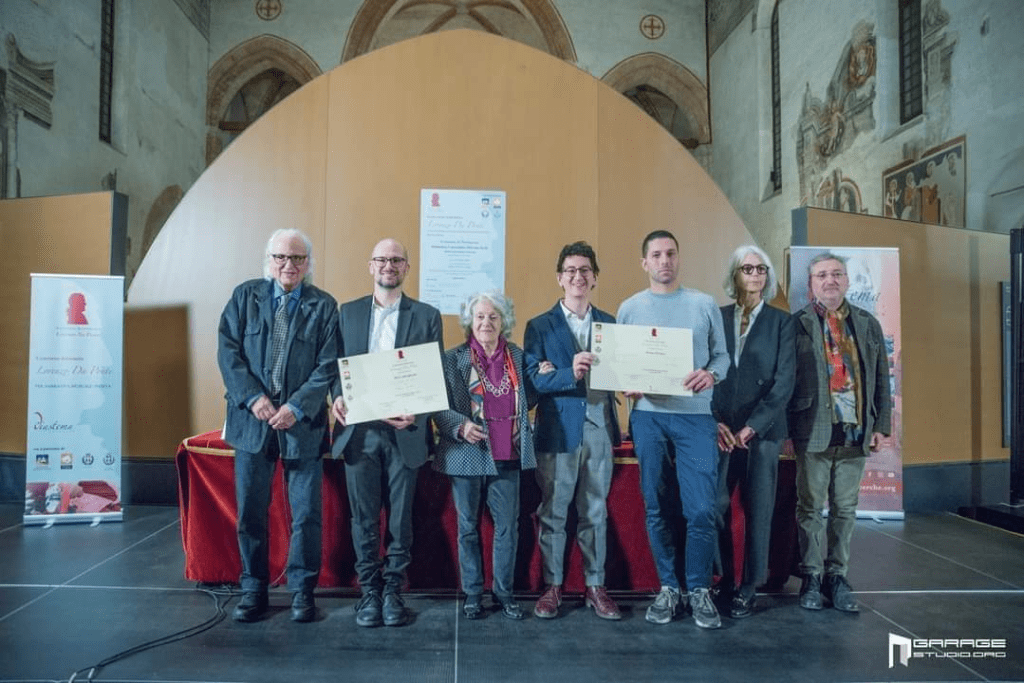Intervista con Paolo Gulisano
Clive Staples Lewis (29 novembre 1898, Belfast – 22 novembre 1963, Oxford) fu eminente professore di lingua e letteratura inglese all’Università di Oxford, ma, soprattutto, grande autore di narrativa con opere quali Le Cronache di Narnia, Le Lettere di Berlicche, The Space Trilogy, Il Grande Divorzio, e di saggistica come I quattro amori, Sorpreso dalla gioia; nonché amico fraterno di J. R. R. Tolkien, con cui – e non solo – egli animò per anni gli Inklings (“Imbrattacarte”), eutrapelica compagnia di amici uniti da ciò che è Vero, Bello e Buono; Humphrey Carpenter, biografo di Tolkien, dedicò loro un libro. Il gruppo si ritrovava al pub oxoniense The Eagle and the Child (ribattezzato The Bird and Baby), ogni martedì sera a discutere e a leggere anticipazioni delle opere che andavano scrivendo, tra letteratura, poesia, allegrezza e il fumo delle immancabili pipe.
Era il 22 novembre 1963, quando a Oxford, in Inghilterra, Clive Staples Lewis si congedava da questo mondo. Quello stesso giorno in cui, a Dallas, in Texas, venne assassinato il trentacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America (1961-1963), ossia John Kennedy, tra gli uomini più popolari e stimati a livello internazionale. L’attentato non lasciò molto spazio alla morte di Lewis, monopolizzando i media e l’opinione pubblica mondiale.
Per approfondire la storia di questo insigne figlio d’Irlanda, ho contattato il dottor Gulisano, il quale, oltre a essere un esperto tolkieniano (come dimostra questa intervista fattagli nel settembre scorso, per celebrare il “cinquantenario” tolkieniano: https://t.ly/WMf_2) è anche un autorevole studioso del (sub)creatore di Narnia, a cui ha dedicato C.S. Lewis. Tra fantasy e Vangelo, edizione Ancora, Narnia. La teologia fuori dall’armadio, co-curato con altri studiosi di Lewis e, più recentemente, Clive Staples Lewis. Nella Terra delle Ombre, edito da Ares.
Chi è Clive Staples Lewis? Quali sono le tappe salienti della sua vita?
Lewis è stato un grande intellettuale del ‘900, un uomo che ha dato di che pensare con i suoi scritti letterari e filosofici, ma che allo stesso tempo ha divertito, commosso e fatto sognare milioni di giovani lettori con le sue narrazioni fantasy. Fu senza dubbio uno dei più singolari intellettuali dell’Inghilterra del suo tempo, un uomo affascinante e contraddittorio: non era un professionista dei racconti per bambini, né ebbe mai figli a cui narrare fiabe alla sera, ma realizzò con Narnia un autentico classico della Letteratura per ragazzi; visse gran parte della sua vita in Inghilterra, diventando uno dei massimi protagonisti della vita culturale del Paese, ma era irlandese. Era però, a differenza della grande maggioranza degli irlandesi che era cattolica, di fede protestante. Non di meno è stato un grande apologeta del Cristianesimo, che difese con lucidità e passione dalle aggressioni ideologiche della Modernità. Una personalità complessa, ma proprio per questo estremamente interessante. Nasce nel 1898, a Belfast, poi si trasferisce a studiare in Inghilterra, e diventerà professore prima a Oxford e poi a Cambridge. Passerà dall’ateismo militante al Cristianesimo attraverso una conversione che fu dovuta in gran parte al collega e amico John Ronald Tolkien. Morì il 22 novembre 1963, sessant’anni fa. Una data restata nella storia, perché quel giorno venne assassinato a Dallas il Presidente John Kennedy.
Cosa ci puoi dire al riguardo delle opere di C.S. Lewis, dalle più celebri (ad es. Le Cronache di Narnia, Le lettere di Berlicche, I quattro amori) a quelle – purtroppo – meno note ma non meno significative (ad es. i testi della “trilogia del cosmo” e Il grande divorzio).
Scrisse opere storiche e libri in difesa del Cristianesimo in un mondo che vedeva scivolare inesorabilmente verso l’indifferentismo religioso, ma scrisse anche opere di fantascienza, e romanzi ricchi della presenza di riferimenti simbolici e mitici.
Potrebbe sembrare strano che un professore di Oxford, docente ed esperto di letteratura inglese medioevale e rinascimentale, sia conosciuto soprattutto per la sua produzione fantastica. In realtà la biografia di C. S. Lewis ci rivela un percorso in cui il fantastico occupa uno spazio importante, e soprattutto si manifesta saldamente connesso con tutto l’itinerario spirituale dello scrittore. Lewis non è solo il brillante autore delle Cronache di Narnia, lo scrittore moralista di successo, esperto nell’uso del registro ironico con cui dava forza ai contenuti della sua rilettura di un pensiero cristiano radicato nell’esperienza dell’uomo contemporaneo (come nelle arcinote Lettere di Berlicche).
Nei suoi saggi, uno degli obiettivi fondamentali è la messa a fuoco dell’universo culturale che ha inquadrato la vita dell’uomo europeo fino alla nascita del mondo pienamente moderno. L’orizzonte intellettuale che lo ha abbracciato è quello che si è riflesso nella tradizione enciclopedica di un sapere ridotto a una unità facilmente accessibile dall’uomo antico e medievale.
Quando nacque l’amicizia con J.R.R. Tolkien e quanto fu fondamentale per la sua conversione dall’ateismo al cristianesimo? Per quale motivo non divenne pienamente cattolico?
L’incontro avvenne all’Università di Oxford, dove entrambi erano giovani insegnanti. L’amicizia nacque dallo stupore di riconoscere interessi e passioni comuni. I due si intrattenevano in lunghe discussioni. A dividerli sembra esserci la religione: Tolkien era profondamente cattolico mentre Lewis – nato protestante- era diventato un ateo convinto. Lewis non nascose, fin dall’inizio, di avere un pregiudizio religioso nei confronti di Tolkien: era nato nell’Irlanda del Nord, discendente di quei britannici, che avevano fatto parte del piano di colonizzazione attuato dall’Inghilterra dopo la conquista militare dell’Irlanda. Sudditi fedeli di Londra, avamposto dell’Impero, fieri protestanti visceralmente anti-cattolici. Lewis tuttavia aveva abbandonato in gioventù la religione dei padri, ed era transitato nei territori aspri dell’ateismo. Fu Tolkien a toccargli il cuore e la mente, e a portarlo ad abbracciare il Cristianesimo. Tolkien avrebbe voluto naturalmente potarlo nella Chiesa Cattolica, ma Lewis si “fermò” alla Chiesa Anglicana, anche nel suo parlare di Medioevo, si avvertiva la nostalgia per quando la Chiesa era Una e indivisa.
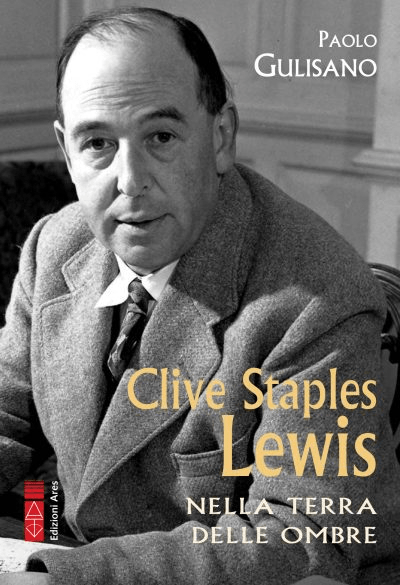
Quali temi e valori li unirono in profonda amicizia, al punto di giungere a dirsi: “Come? Anche tu? Credevo di essere l’unico…”? E quali scelte tematiche e stilistiche, invece, li contraddistinguono nettamente?
Li univa la comune passione per il Bello, il Buono, e soprattutto il Vero. Tolkien gli aveva fatto comprendere che tra i tanti Miti, ce n’era uno che si era inverato, e precisamente si era incarnato . Li univa la passione per la Letteratura mitica, epica, e per il Medioevo come grande civiltà. Li divideva un aspetto: Tolkien era molto preciso e filologicamente accurato nelle sue elaborazioni immaginarie, mentre Lewis realizzò con Narnia ma anche con la Trilogia Cosmica una vasta commistione di mitologie e leggende che non piacque molto al creatore del Signore degli Anelli.
I più noti cattolici di Inghilterra, quali San John Henry Newman, Hugh Benson, Chesterton, lo influenzarono? Vi erano altri “ispiratori”?
L’unico tra i grandi cattolici inglesi che ispirò Lewis fu Chesterton. Anzi, prima che Tolkien riuscisse a convertirlo, una prima breccia nel suo ateismo si era aperta grazie alla lettura di Ortodossia di GKC. Soprattutto rimase colpito dall’affermazione del gigante di Beaconsfield che “Lo straordinario segreto del Cristianesimo è la Gioia”. Una prospettiva del genere, per lui che veniva dall’Ulster calvinista, era assolutamente inedita, e lo colpì molto. Per il resto, gli ispiratori di Lewis furono gli autori religiosi, come i pensatori medievali, la Letteratura Cortese, e infine i Padri della Chiesa. Fonti antiche alle quali era andato ad attingere.
Tra i suoi amici di penna vi era un importante sacerdote veronese, Don Giovanni Calabria, fondatore delle congregazioni dei Poveri Servi e delle Povere Serve della Divina Provvidenza. Che tipo di rapporto fu il loro?
Don Calabria, uno dei grandi santi della Carità degli ultimi secoli, era anche un uomo di sana curiosità intellettuale. Aveva letto Le Lettere di Berlicche, e ne era rimasto affascinato. Volle allora contattarne l’autore, prese carta e penna, e scrisse in latino (non sapeva l’inglese!) al professore di Oxford, il quale immediatamente rispose, sempre in latino. Fu l’inizio di una lunga corrispondenza epistolare, durata anni, fino alla morte di don Calabria. Erano tempi in cui l’ecumenismo era quasi sconosciuto, e questa amicizia tra un prete cattolico e un intellettuale anglicano poteva sembrare molto insolita, ma entrambi erano due anime assetate di Dio, e senza alcun compromesso né sincretismo si testimoniavano l’un l’altro la gioia e la passione del credere.
Il 31 ottobre è stato pubblicato il libro più recente che hai dedicato proprio a Lewis. Che cosa potremo trovarvi? Perché hai sentito l’esigenza di dedicarglielo?
Ho voluto raccontare la vita stessa e l’opera di Lewis, tant’è che il libro è diviso in due parti che affrontano entrambi gli aspetti. Ho cercato di raccontare il desiderio di Lewis di realizzare il progetto buono di Dio. Un ideale che si concretizzò nella ricerca della Verità e della Gioia. Tutte le opere di Lewis s’intrecciano variamente attorno ad un tema che ritorna costantemente e che, parafrasando le sue stesse parole, possiamo definire «the lived dialectic of Desire», la dialettica vissuta del desiderio. Un desiderio imprecisabile, ma intensissimo, che Lewis inseguì tenacemente per tutta la sua vita e che crebbe di pari passo con la sua evoluzione spirituale, assumendo di volta in volta connotazioni sempre più definite e arrivando, finalmente, ad essere identificato come la Gioia.