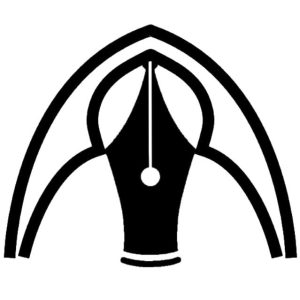Qui sotto una breve chiacchierata col nostro Andrea Donna, che ha pubblicato recentemente, per Aristodemica, Incubi, una raccolta di poesie ed una riscrittura de Fungi from Yuggoth di Howard Phillips Lovercraft. Il libro lo potete acquistare tramite questo form, oppure alla librerie Arethusa (via Giolitti 18, Torino) e Donostia (via Monginevro 85/A, Torino). Qui trovate una videointervista dell’editore Antonello Fabio Caterino ad Andrea.
I tuoi Incubi potrebbero aprirsi con l’Ozymandias di Shelley: I met a traveller from an antique land who said … Te saresti questo viandante, che racconta scorci di vecchie storie.
C’è un io lirico che viaggia — da solo o con i propri compagni — in uno spazio e in un tempo che oscillano tra la dimensione fisica e quella onirica. Verissimo: ciò che queste voci raccontano sono scorci di storie, brandelli che si interrompono — fatto tipico dei sogni paurosi: “La caduta”, “Il precipizio” — un attimo prima della fine, della tragedia.
Si ha in tutta la raccolta l’impressione che racconti mondi antichi, più che primitivi, prima del Diluvio, che incidentalmente sono sopravvissuti, in qualche residuo, al loro sgretolarsi: che ci inquieta.
L’esistenza di civiltà indicibili e inconcepibili, antichissime, pre-umane o sovra-umane è uno dei fondamenti della mitologia di Lovecraft, i cui “Fungi from Yuggoth” riscrivo nella seconda metà del volume: ho ripreso anche nei sonetti originali questo topos, sfruttandone il potenziale espressivo ed evocativo, pur cercando sempre di evocare e alludere, senza affermare esplicitamente.
Visto che l’hai citato, andiamo direttamente su Lovecraft (che vedo avere scritto Fungi from Yuggoth tra il 27 dicembre 1929 e il 3 gennaio 1930: un modo molto proficuo di passare il periodo natalizio): vorresti prima di tutto darci una sua biografia sentimentale (darei per scontato che per quella ordinaria ognuno possa visitare la rete), vista attraverso i tuoi occhi?
Sapendomi lettore di Poe, un compagno di classe e tuttora grande amico mi prestò, a pochi mesi dalla maturità, una raccolta di racconti, assicurandomi che Lovecraft, che qualcuno ha definito il più grande e inconsapevole parodista dello stesso Poe, mi avrebbe cambiato la vita: fu così, pur facendo la tara alla natura iperbolica del concetto di “cambiare la vita”. Uno dei pochissimi autori che leggo o rileggo costantemente da quasi trent’anni: un amore letterario nato in adolescenza e non raffreddatosi — tutt’altro — con l’età adulta.

Quali sono le peculiarità di Lovecraft che più hanno toccato la tua immaginazione, e così influenzato la tua attività poetica e letteraria?
Il Lovecraft che si esprime in versi è in grado di costruire storie dell’orrore pienamente compiute, credibili, efficaci e perfettamente moderne in una forma poetica, quella del sonetto elisabettiano, di per sé adatta a contenuti più lirici che narrativi e a una scelta stilistica tradizionale più che contemporanea: fatto tanto sorprendente, ai miei occhi, da aver stimolato non solo la ripetuta lettura, ma la riscrittura del corpus dei “Fungi from Yuggoth”.
Anche nella tua premessa lo specifichi: è più una riscrittura che una traduzione. In cosa hai avuto particolarmente l’impressione di essere “coautore” dei “Fungi from Yuggoth”?
Sentirmi coautore dei “Fungi” sarebbe, da parte mia, decisamente presuntuoso: ma senz’altro posso dirmi autore secondario di una versione in lingua italiana della raccolta. Se è vero — ed è vero, a meno che non voglia limitarsi a una traduzione interlineare di servizio — che chi traduce poesia in realtà sempre riscrive, io ho esasperato questa scelta programmatica: e sono stato quasi obbligato, dal momento che non avrei potuto rispettare, insieme, prosodia, atmosfera e senso letterale; ho scrupolosamente mantenuto la prima e la seconda, sacrificando il terzo.
Ecco: l’atmosfera: sia nelle tue composizioni originali, sia nella riscrittura dei “Fungi” l’atmosfera sembra prevalere su ogni cosa. Si viene calati in queste realtà dove il non detto e l’allusione sono parte essenziale del piacere (e dello stimolo) che tocca il lettore.
Notazione critica puntualissima: confermo quanto dici. Inoltre il desiderio e il piacere di creare un’atmosfera — da incubo o da sogno — è stata anche la principale leva che ha stimolato la scrittura o la riscrittura dei componimenti.
Probabilmente perché una atmosfera è “più ampia” di una storia in sé: riesci a creare un mondo, o una parte di esso, in cui chi legge possa perdersi e, in parte, avere delle proprie storie, complementari a quelle che immagini tu.
Possiamo senz’altro dire che l’elemento dell’emozione non è subalterno all’elemento strettamente narrativo né nei “Fungi” né negli “Incubi”.
Potrebbe essere interessante a chi ci legge magari avere davanti una tua poesia, e sentirsela descrivere (anche se probabilmente la poesia non sarebbe mai troppo da raccontare) da te. Mi piacere che tu ci parlassi ad esempio di XII – La Torre:
La prora si schiantò contro gli scogli
Dell’isola da eoni massacrata
Da gelidi marosi e circondata
Da bianche procellarie e capidogli:
Un luogo di desolazione atroce,
All’uomo ignoto e alla cartografia;
E pur pervaso di una sua malia,
Al largo dell’Antartide feroce.
La terra più vicina era a migliaia
Di miglia; disperati perlustrammo
La riva gelida e ci arrampicammo
Sull’orrido inciampando sulla ghiaia:
Gran Dio! Sull’altipiano d’atra lava
Pietrificata una torre svettava!
Dove, in proposito di atmosfera, sembra di stare tra Poe e Coleridge, mi pare.
Un noi lirico (non un io) e l’emisfero sud: la dimensione collettiva della spedizione ricorre frequentemente negli “Incubi”, spesso ambientati nell’emisfero australe e in contesti di gelo. Non vi sono elementi che permettano di identificare un periodo storico specifico, ma immagino che qualunque lettore si figuri un momento compreso tra l’ottocento e la contemporaneità: ha ragione. Ci muoviamo infatti — è vero — tra “Gordon Pym”, la “Ballata del vecchio marinaio” e le “Montagne della follia”. La prora (di un veliero? Di un clipper? Di un battello a motore?) si schianta sulla costa di un’isola perduta nell’oceano, che immaginiamo isolata e vulcanica, a migliaia di miglia dalla costa più vicina: perché quell’isola è lì? È un’isola nota, per quanto remota, o mai scoperta da alcuno? Quindi, la rivelazione, nella quale consiste l’incubo: qualcuno, anzi forse Qualcuno ha abitato quel luogo, vi ha costruito un manufatto di dimensioni immani (la torre “svettava”). Forse questo qualcuno, questo Qualcuno è ancora lì. Il noi lirico / narrante è evidentemente tornato, vivo e forse anche salvo, ma verosimilmente cambiato: ora sa qualcosa, Qualcosa che nessun altro conosce, che nessuno dovrebbe sapere.
Porta pazienza ma ad un certo punto su questo blog arriviamo sempre a parlare di Tolkien: ma in XVI. Il cunicolo pare proprio di trovarsi di fronte ad un manipolo di nani (magari guidati da un hobbit) che devono sgusciare all’interno di una Montagna Solitaria per un tesoro custodito da un drago!
Una splendida lettura! Conta poco che l’occasione del sonetto sia stata un mio incubo claustrofobico, pedissequamente restituito nel corrispondente sonetto: è un’interpretazione, la tua, non solo legittima, ma molto bella.

Dai, raccontaci un po’ il tuo modo d’operare da autore, come nasce, per te, una poesia, come è la sua stesura, la sua pulizia, fino al momento in cui dici “ok va bene può andare”.
Limito il campo agli “Incubi”: la situazione standard è un sogno particolarmente vivido oppure una rêverie dalle peculiari potenzialità narrative e liriche: inizio provando a ritmare un paio di versi, ipotizzo qualche rima, arrivo a costruire una delle tre quartine o, magari (è la cosa più difficile!), il distico finale; penso: «Questa volta non ce la farò mai, è troppo difficile, lascio perdere». Il giorno dopo, da fresco, aggiungo un altro paio di versi. «Siamo quasi a metà!» penso con entusiasmo, ma poi di nuovo sopravviene lo sconforto: «Manca la seconda metà abbondante, la più difficile, perché ora spazi e quantità sono obbligati: ce la farò?» Ecco, ancora un verso, due, tre… il puzzle si sta completando. Mancano due, tre tessere al massimo. Ma i bordi non combaciano, devo forzarli perché vadano al loro posto, tutto sembra brutto e goffo. Poi, intuizione: ecco la parola che mancava! La incastro come l’ultima tessera del rompicapo, anzi come la chiave di volta dell’arco: tutto sembra reggere, l’incantesimo è compiuto! Siamo sicuri? Lo sapremo dopo un giorno o due: alcune costruzioni crollano nella notte, altre reggono ma, da meravigliose che sembravano, paiono insulse il giorno dopo. Una parte residuale regge, chissà come e chissà perché, sia alla statica che all’estetica: ecco un sonetto che merita di scampare alla distruzione, qualche ulteriore intervento (si cambia la collocazione di una parola, un segno di interpunzione) e si può inserire nella raccolta.
Nella cosiddetta Lettera del Veggente, Arthur Rimbaud scrive (con la sua prosa sempre un pochetto carica): “Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. (…) Poiché giunge all’ignoto! Avendo coltivato la sua anima, già ricca, più di ogni altro! Egli giunge all’ignoto, e anche se, sconvolto, dovesse finire per perdere l’intelligenza delle sue visioni, le avrebbe pur sempre viste! Crepi pure nel suo balzo attraverso le cose inaudite e innominabili: verranno altri orribili lavoratori; cominceranno dagli orizzonti su cui l’altro si è accasciato!“.
Possiamo perdonare a un poeta adolescente un po’ di verticalismo! Questo brano afferma qualcosa di grande e vero e cioè: chi non è veggente può comunque farsi tale e cogliere in qualche modo un germe di ignoto, un barlume di mistero.
Bene, abbiamo avuto una bella chiacchierata. Un’ultima cosa: quando hai iniziato la tua antologia di Incubi, ti eri posto un fine, uno scopo, la volontà di solleticare una idea o un sentimento? E pensi di avere raggiunto il tuo obiettivo?
Con i miei “Incubi” ho provato a ricreare una poesia, uno stile e un dettato mimetici dei modi della letteratura popolare, spontanea e ingenua nel senso di priva di sovrastruttura accademica: un’operazione difficile, sui cui esiti aspetto il responso dei miei lettori. Di mio, posso dire che sono moderatamente soddisfatto. E che mi sono molto divertito.
Ricordiamo come il libro di Andrea possa essere acquistato tramite questo form, oppure alla librerie Arethusa (via Giolitti 18, Torino) e Donostia (via Monginevro 85/A, Torino).